UNIVERSITÁ
DEGLI STUDI DI FIRENZE
Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Economia
dell’Ambiente
IL RUOLO
DELLA TERRITORIALITÁ
NELL’EVOLUZIONE DELL’AGRICOLTURA .
LA SVIZZERA COME CASO – STUDIO: VERSO
UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Tesi di laurea di:
Lorenzo Pistolesi
Relatore:
Maria Tinacci Mossello
Anno accademico 2003-2004
1. EVOLUZIONE DELLE CARATTERSTICHE TECNICO-ORGANIZZATIVE
DELL’AGRICOLTURA TRADIZIONALE
1.1. Gli inizi
dell’agricoltura e la territorialità
1.2. I sistemi
di coltivazione delle piante
1.2.1. Sistemi d’agricoltura discontinua
1.2.2. Sistemi d’agricoltura intensiva e continua
1.3. Sistemi
d’allevamento d’animali
1.3.3.
L’allevamento sentimentale
1.3.4.
L’allevamento pascolo-stalla
2. CARATTERISTICHE ECONOMICO-SOCIALI E FORME DI PROPRIETÁ
DELL’AGRICOLTURA
2.1.1.
Società di raccolta e caccia
2.1.4.
Ruolo attuale e futuro delle comunità agricole
2.2.1.
Le grandi proprietà terriere come residuo del feudalesimo
2.2.2.
La grande proprietà e l’affitto della terra
2.2.3.
La grande proprietà come grande azienda agricola
2.2.4.
La piccola proprietà individuale
2.2.5.
La cooperativa agricola
2.4.1.
I caratteri strutturali delle aziende agricole
2.4.2.
I caratteri economici delle aziende agricole
3. TRANSIZIONE DALL’AGRICOLTURA TRADIZIONALE A QUELLA
MODERNA. L’IMPATTO SULL’AMBIENTE
3.1.
Agricoltura tradizionale e moderna
3.1.1.
L’aiuto della geografia
3.1.2.
Tradizione, diversificazione e territorialità.
3.1.3.
Modernità, omologazione e de-territorializzazione.
3.1.4.
Interazione tra modernità e tradizione in agricoltura: il caso Italiano
3.2.
Agricoltura e ambiente culturale
3.3.
Agricoltura e ambiente fisico
3.3.3.
Resistenza naturale ai pesticidi
3.4.
Agricoltura e ambiente politico
3.4.1.
La Politica Agricola Comune
3.5.
Agricoltura e biotecnologie
3.5.1.
L’impatto socio-ambientale
3.5.3.
L’impatto economico-ambientale
4. TRANSIZIONE DALL’AGRICOLTURA MODERNA A QUELLA SOSTENIBILE.
CASO-STUDIO : L’AGRICOLTURA SVIZZERA
4.1.1. Definizione di sostenibilità in agricoltura
4.1.2. Breve storia dell’agricoltura biologica e biodinamica
4.1.3.
Territorialità e sostenibilità
4.2.
Transizione dell’agricoltura in Europa: aspetto politico
4.2.2.
La recente riforma della PAC (Luglio 2003)
4.3.1. Aspetto
politico: la riforma agraria
4.3.2.
Aspetto economico. I prodotti biologici
4.3.3. Aspetto
produttivo: una produzione rispettosa dell’ambiente
4.4.2. Aspetto
socio-economico
4.5. L’agricoltura svizzera:
importanza della riduzione degli incentivi indiretti
4.5.1.
Incentivi indiretti: inefficienza e inefficacia
4.5.2.
L’aspetto economico-ambientale
4.6.2.
Aspetto biologico della riduzione della produzione
4.6.3.
Effetto sul prezzo: un’attrito di forze
5. IL
SISTEMA TERRITORIALE SVIZZERO: UNA “V.I.A.” PER L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE (CONCLUSIONI)
5.1.1.
Dell’offerta dei beni agricoli
5.1.3.
Della spesa della Confederazione
5.1.4.
Del conto economico delle aziende
5.1.5.
Della volontà comune per un’agricoltura sostenibile. Il principio di neutralità
5.2. Il mercato
dell’agricoltura biologica
5.2.2.
Confronto tra aziende a coltivazione biologica e non biologica
5.2.3.
Un indice di valutazione della contre-performance ambientale delle aziende
5.3. Il governo delle esternalità
5.3.1. La “V.I.A.” per la
sostenibilità dell’agricoltura svizzera
5.3.2.
Valutazione semplificata dell’impatto ambientale potenziale dell’agricoltura
svizzera
5.4. Considerazioni finali
ipotetiche e tutte da dimostrare
5.4.1.
La differenziazione dei prezzi come condizione necessaria verso un’agricoltura
sostenibile
5.4.2.
L’evoluzione dell’agricoltura (territorialità e sostenibilità)
5.5.1.
Conclusione logica della tesi
INTRODUZIONE
L’agricoltura è la più
anziana forma di produzione inventata dall’uomo e da circa 12000 anni, non ha
mai cessato di essere la nostra base d’esistenza. Nell’agricoltura
interagiscono tre logiche diverse: ecologica, biologica e antropologica; essa
può essere considerata l’interfaccia tra uomo e natura, il punto d’incontro,
l’intersezione (Raffestin, 1997). Il suolo agricolo è soggetto sia
all’influenza dell’uomo, con il suo lavoro (manuale, di analisi, di attesa, di
trasmissione nel tempo), sia a quella della natura, con il clima, le stagioni,
gli animali, i parassiti, l’acqua, ecc. Nel corso della storia, infatti, il
suolo agricolo si è trasformato a seguito dell’evoluzione delle condizioni
eco-biologiche e delle condizioni antropologiche, così da diventare uno
specchio che riflette le due variabili uomo-natura (cfr par 1.1.2. e 3.1.2.).
L’agricoltura ha avuto
sempre la doppia caratteristica di produrre del “vivente” e restituire più di
quello che veniva investito ovvero un surplus agricolo (cfr par 3.2.).
Fino a qualche anno fa, nell’agricoltura, l’energia prodotta era uguale o
maggiore dell’energia impiegata, cioè il totale dei fattori produttivi (lavoro,
sementi, concimi naturali, animali) era minore della produzione lorda,
necessaria al sostentamento (cfr cap 1. e 2.); un bilancio negativo si sarebbe
tradotto, una volta finite le scorte, in malnutrizione e fame, basti pensare ad
alcuni paesi ad agricoltura di sussistenza ancora presenti nel Pianeta.
Fortunatamente, adesso il
sistema è cambiato, così che, a controbilanciare una produzione agricola sempre
crescente e dipendente dal mercato, c’è un più che crescente apporto di input
(fisici, energetici ed economici) esterni ad essa, che rendono il bilancio
netto (fisico, energetico ed economico) negativo (cfr cap 3.). Oggi, nei paesi
industrializzati questo bilancio negativo, se non fosse stato per le
esternalità negative che esso stesso ha generato, sarebbe stato difficilmente
percepibile
Diventando un’appendice
dell’economia, l’agricoltura, non ha dovuto più rispettare le leggi della
termodinamica, proprio perché è diventata uno strumento di un sistema più
grande, che la usa e la protegge. Ma un bilancio ecologico ed economico
negativo si traducono in una perdita continua di capitale fisico[1] e sociale[2].
Produrre del vivente per i
viventi, significa disporre di una straordinaria autonomia territoriale, e una
società che riduce il suo stock di capitale fisico e sociale, riduce la sua
autonomia sia da un punto di vista ecologico, che da un punto di vista
economico. In questi ultimi anni, la perdita di suolo agricolo per cause di
dissesto idrogeologico, di dilavamento del terreno, di perdite di sostanze
nutritive data dall’utilizzo intensivo del suolo agricolo è stata molto forte.
Infatti l’agricoltura, essendo lo specchio delle variabili uomo-natura,
riflette una società più incentrata sull’economia, in cui l’agricoltura ricopre
un ruolo marginale, quale strumento dell’economia.
L’agricoltura diviene la
fonte e il bersaglio di una serie di stress di natura ecologica e
antropologica, ma l’agricoltura è la fonte della catena alimentare dell’uomo.
Da qui il bisogno di una produzione il più possibile sana e ricca di principi
nutritivi, il più possibile diversificata, senza rischi o danni per la salute
umana e per l’ambiente; senza contare l’importanza sempre crescente dei servizi
(multifunzionalità, par. 4.3.) che l’agricoltura offre, si pensi a certi
programmi di riabilitazione per tossicodipendenti o per persone con problemi
psicologici.
Se l’agricoltura rappresenta
la nostra storia, il nostro passato, è altrettanto vero che essa rappresenta il
nostro futuro e, non come problema economico ed ecologico da risolvere, ma come
opportunità data all’uomo di vivere la “creazione”, come opportunità per
l’economia di migliorare la sua efficienza sociale (cfr cap 4.) e come
opportunità di aprire le sinergie contenute nella relazione uomo-natura.
Da qui, l’esigenza di una
ricerca, questa, che non si perda nello specifico, ma che mantenga sempre una
buona prospettiva spaziale e temporale. Proprio questa prospettiva permette di
aver sempre una percezione più oggettiva del ruolo dell’agricoltura.
Questa ricerca non ha la
pretesa di trovare le soluzioni alla sostenibilità, ma semplicemente descrive
nel tempo l’evoluzione dell’agricoltura, attraverso l’ausilio della
territorialità. Per poter capire il futuro bisogna prima cercare di capire il
passato, perché è nel futuro che si manifestano gli effetti delle cause poste
nel passato. Il presente è l’incontro di cause passate ed effetti futuri, che,
nell’agricoltura, trovano un fil rouge. Con la “territorialità” (cfr par
1.1.2.) si evidenziano le differenze tra agricoltura tradizionale e moderna
(cfr par 3.1.), la prima rivolta al passato e la seconda al futuro.
Attraverso un metodo
sistemico, ho organizzato i lavori seguendo un ordine cronologico diviso in tre
periodi ben distinti e distinguibili. L’evoluzione dell’agricoltura può essere
riconducibile ad un albero, nel quale:
·
le radici rappresentano la
multiformità dell’agricoltura tradizionale (cap 1 e 2), che rimangono sempre
impermeate nel passato;
·
il tronco rappresenta l’uniformità
dell’agricoltura moderna (cap 3) e la sua strutturazione produttiva;
·
il fusto rappresenta la
multifunzionalità dell’agricoltura sostenibile (cap 4 e 5) e la sua sinergia
produttiva con l’ambiente;
La territorialità s’inserisce
in questo schema, andando ad evidenziare il forte legame che c’è tra passato,
presente e futuro; tra agricoltura moderna e tradizionale, come due aspetti
indissociabili dell’agricoltura sostenibile (cfr par 3.1.). Ogni capitolo ha
almeno un paragrafo dedicato alla territorialità e all’evoluzione all’interno
dell’agricoltura.
Tramite questo percorso
cronologico, si evidenziano gli aspetti dinamici dell’evoluzione, ovvero le
transizioni da una forma ad un’altra, si mettono in evidenzia (con la
territorialità) i cambiamenti avvenuti, cercando di dare un significato
olistico riconducibile ad un sistema territoriale che si estenda nel tempo e
nello spazio (cfr par 4.1.3).
Nel sistema agricolo
territoriale (punto d’arrivo di questa ricerca) convergono logiche dettate
dalle tradizioni che arrivano dal passato, logiche economiche del presente e
logiche di sostenibilità che “vengono dal futuro”. In questo punto d’incontro e
d’intersezione ho preferito parlare di sistema territoriale, proprio perchè le
relazioni tra i soggetti (tramite il mercato e l’ambiente) passati, presenti e
futuri, sono in continua evoluzione.
Questo percorso è approdato
su una breve analisi sistematica del sistema territoriale svizzero, il quale è
riuscito a creare all’interno dell’agricoltura delle economie ambientali
crescenti (cap 5). Economia, politica, ecologia e la società stessa, convergono
su un modello di agricoltura sostenibile. Azzardando l’ipotesi che il sistema
territoriale compia, attraverso il mercato, una vera e propria V.I.A. (par
5.2.3.), sono riuscito a trovare un indice che esprimesse tale valore,
ordinando le aziende in base all’impatto che esse hanno sull’ambiente.
1.
EVOLUZIONE DELLE CARATTERSTICHE TECNICO-ORGANIZZATIVE DELL’AGRICOLTURA
TRADIZIONALE
Da sempre l’agricoltura ha esercitato un
notevole impatto sull’ambiente. Tra le diverse attività umane, l’agricoltura è
quella che maggiormente ha cambiato il paesaggio in maniera sostanziale.
Foreste che lasciano il posto a campi e a praterie, sono l’esempio più lampante.
Canali d’irrigazione, bonifiche, nuovi assetti fondiari, silvicoltura, hanno
praticamente cancellato le zone di natura incontaminata. Oggi,
nell’immaginario collettivo, è piuttosto il paesaggio agricolo ad essere
percepito come “natura”.
Una caratteristica dell’impatto dell’agricoltura
sull’ambiente si ritrova nella sua estensione, sia di carattere spaziale, sia
temporale: sappiamo che l’agricoltura, in modi e forme diverse, è praticata in
tutto il mondo e sappiamo anche, che essa è stata la prima attività dell’uomo a
produrre un impatto rilevante sull’ambiente; un impatto che si estende dunque nel tempo e nello spazio. La trasformazione
del paesaggio è avvenuta nei secoli, gradualmente, cosicché oggi il paesaggio
agricolo è diventato una costante del territorio alla quale non facciamo più
caso. Ci colpiscono, al contrario, quelle zone nelle quali l’attività agricola
si è arrestata, le quali si mostrano ai nostri occhi come “abbandonate”.
La maggior parte delle zone ecumeniche
esistenti sulla terra sono state modellate, in misura più o meno rimarcabile,
dal lavoro dell’uomo in agricoltura. L’agricoltura, e il paesaggio che ha
creato l’uomo tramite essa, sono diventate una costante del tessuto quotidiano
delle società, tradizionali o moderne, che va ben al di là del puro fatto
geografico o economico.
Il posto che spetta all’agricoltura è
spesso sottostimato, la percezione che si ha e l’uso che se ne fa, è ancora
troppo limitato al mero aspetto produttivo siano essi beni o servizi, essa
accompagna l’uomo nella storia, sia in epoca preindustriale, industriale, che
postindustriale.
1.1. Gli inizi dell’agricoltura e la
territorialità
1.1.1. Le origini
Nell'epoca in cui ebbe origine
l'agricoltura, l’uomo provvedeva ai suoi bisogni alimentari sfruttando
direttamente ciò che la natura produceva spontaneamente. A quel tempo,
l’impatto sulla natura era molto limitato e lo spazio vitale per sopravvivere
era molto esteso: dai 10 km²/abitante fino ai 140 km²/abitante per i climi più
difficili. Questo stato di cose rimase inalterato fino alla
scoperta della coltivazione delle piante. La prima forma di agricoltura era molto invasiva. Si praticava una
coltivazione del terreno temporanea previa distruzione, mediante incendio,
della foresta o della macchia. L’agricoltura itinerante ridusse lo spazio
vitale necessario per vivere: da 0,5 a 1,3 km²/abitante per la pastorizia
nomade e da 0,03 a 0,5 km²/abitante per l’agricoltura discontinua. Per fare un
raffronto oggi, lo spazio vitale sufficiente varia da 400-800 m²/abitante nei paesi
che soddisfano i loro bisogni alimentari con la produzione interna (Egitto,
Cina) e da 3500 a 7500 m²/abitante per i paesi d’esportazione agricola
(Francia, USA). Questi primi dati ci danno una misura dell’aumento d’efficacia
e d’efficienza che l’uomo ha prodotto, nell’utilizzare la natura per produrre
il cibo di cui aveva bisogno. Il rapporto è nell’ordine di 1 a 10.000; in altri
termini, la quantità di terreno che prima bastava appena a far sopravvivere un
solo essere umano, adesso è sufficiente a sfamare oltre 10.000 persone (PNUE,
2000).
Le fonti archeologiche ci dicono, con
certezza, che nel nono millennio a.C. sulla Mezzaluna Fertile esisteva già
un’agricoltura primitiva, costituita dalla coltivazione di cereali
(Kostrowicki, 1980). Diffusasi successivamente nelle zone tropicali,
l’agricoltura si diversificò nella coltivazione di piante che forniscono
radici, rizomi e tuberi, mentre nella steppa diventò pastorizia nomade.
Ci sono anche i sostenitori (Sinskaja,
1969) del policentrismo, che ipotizzano che i luoghi di nascita
dell’agricoltura siano stati più di uno. Le regioni sarebbero cinque:
Mediterraneo antico, Est-asiatico, Sud-asiatico, Africano e Nuovo Mondo. Ogni
regione presentava delle differenze sostanziali riguardanti le forme d’agricoltura
primitiva, relative al differente uso dell’irrigazione e la diversa importanza
e utilizzo del bestiame. Con l’invenzione dell’agricoltura ci fu un vero e
proprio boom demografico.
Sembra che l’evoluzione
dell’agricoltura, almeno dal punto di vista tecnico-organizzativo, possa essere
immaginato come una figura che si avvicina al rombo (Kostrowichi, 1980):
inizialmente formata da un piccolo numero di forme di coltivazione essa si è
diversificata, in misura del suo ampliarsi nello spazio e nel tempo, in una
miriade di differenti combinazioni tecnico-organizzative. È affascinante
immaginare quanto l’agricoltura possa esprimere le differenze che ci sono sul
nostro pianeta, inserendosi a pieno nel rapporto uomo-natura.
1.1.2. La territorialità
Altrettanto interessante è rendersi conto di quanto l’agricoltura possa esprimere la “territorialità”, poiché è il risultato dell’interazione del fattore ambiente (clima, territorio, paesaggio), con il fattore umano (uomo, società, cultura, religione) attraverso il tempo. L’agricoltura, in altri termini, attraverso la sua varietà, dimostra quanto complesso e poliedrico è il rapporto tra l’uomo e l’ambiente (v. tab 1 in appendice). Fino a pochi anni fa, era l’unica vera attività per mezzo della quale l’uomo poteva interagire col territorio, accrescendone le differenze e aumentandone le specificità. Considerando la superficie, le zone agricole sono pur sempre le più estese e molto stabili nel tempo.
Introduciamo la definizione di territorialità data da Claude Raffestin (1986) come “L’insieme delle relazioni che i gruppi e di conseguenza, i soggetti che ad essi appartengono, sviluppano con l’esteriorità e con il territorio, grazie all’aiuto di mediatori e nella prospettiva di raggiungere la più grande autonomia possibile, compatibile con le risorse del sistema”.
L’agricoltura sembra proprio essere un mediatore incontrastato della territorialità, attraverso la quale il lavoro dell’uomo ha saputo ottenere la più grande autonomia possibile, relativamente ad ogni determinato territorio. Le risorse di ogni sistema territoriale attraverso l’agricoltura sono state sfruttate al meglio, attraverso un incremento graduale dell’efficienza agricola.
Nell’ “ecogenesi territoriale”, termine coniato da Raffestin (1986), l’agricoltura ha sempre svolto un ruolo determinante, distintivo, modellando i paesaggi e regolando la vita dell’uomo. L’evoluzione dei sistemi territoriali, intesi come strutture autorganizzate, segue alcune delle regole delle strutture dissipative inorganiche (Prigogine e Stengers, 1979): irreversibilità, livelli soglia, memoria genetica codificata, gradienti, attrattori, ecc., senza che queste siano determinanti. Cosicché ogni forma di agricoltura tradizionale è portatrice di un codice genetico territoriale che modella i paesaggi e influisce sulla cultura e sulla società in modo caratterizzante e autoreferenziante, ovvero, l’agricoltura tradizionale intesa, non semplicemente come attività necessaria all’uomo per soddisfare i propri bisogni alimentari, ma come chiave d’accesso per capire il passato e il presente. Ogni forma di agricoltura tradizionale è portatice di una specificità territoriale che la porta, in maniera sistemica, a completare l’olisticità del mondo. Più le forme d’agricoltura si differenziano e più che il sistema mondo evidenzia la sua complessità, e conseguentemente la sua stabilità. Dovremmo pensare ai confini geografici tra un sistema territoriale ed un altro, non come una linea ben definita, ma come un graduale passaggio dalle infinite sfumature, che partecipa a “disegnare l’affresco della creazione”.
L’industrializzazione dell’agricoltura e la mondializzazione recente hanno un po’ perturbato questa specificità territoriale, che nel passato aveva prodotto e arricchito, per sedimentazione, il territorio locale e trasmesso da una generazione all’altra i principi dell’auto-organizzazione, che coincide con l’identità (attiva) del sistema locale (Cahier Geographique, 2002). L’agricoltura moderna ha ridotto notevolmente la territorialità nell’agricoltura, che la faceva portatrice del “codice genetico territoriale”, uniformandosi a poche forme veramente distintive. Si pensi al controllo che le multinazionali esercitano sui flussi di sementi (Ogm), di pesticidi e di concimi per avere un’idea di quanto la de-territorializzazione sia in atto già da tempo.
Tuttavia il fenomeno dell’estinzione di forme agricole arcaiche e tradizionali non ci deve spaventare, soprattutto perché è una costante evolutiva di ogni sistema, ma la sistematica riduzione della diversità a poche forme veramente distintive potrebbe porre molti problemi.
Nei prossimi paragrafi andremo a vedere le
forme d’agricoltura presenti sulla terra, classificate secondo il Kostrowicki
(1980).
1.2. I sistemi di coltivazione delle
piante
1.2.1. Sistemi d’agricoltura discontinua
- Sistemi
a coltivazione temporanea del terreno, mediante distruzione tramite incendio
della vegetazione selvatica. Questi sistemi hanno in comune una condizione
di popolamento rado e semi-nomade o stanziale, l’autoapprovvigionamento ed
un’organizzazione ed una tecnica primitivi. L’incendio oltre ad eliminare
gli arbusti o gli alberi, serve a concimare il terreno, che non ha bisogno
di essere lavorato. Gli utensili usati sono semplici bastoni appuntiti. La zappa e il bastone escavatore,
sono utilizzati per togliere la malerbe negli anni successivi. Si
coltivava per uno o due anni, lasciando successivamente alla natura il
compito di riformare la vegetazione. Una volta lasciato il campo, il bosco
riprende la sua forma originale. 20-30 anni per il bosco e 6-15 anni per la macchia. L’incendio di macchia si differenzia
da quello di bosco, anche per il maggior uso della zappa necessaria per
dissodare il terreno, ben più compatto e pieno di radici (Sinskaja, 1969).
- Sistema a coltivazione discontinua con strumenti arativi, sviluppatisi nel Vicino Oriente ai piedi dei monti, dove i boschi erano radi. Questo sistema era basato sullo sfruttamento della forza trainante degli animali e su un maggior sviluppo degli attrezzi di coltivazione. L’aratro ad uncino fece la sua comparsa nel IV millennio a.C. (Wissmann, 1956), anche se, inizialmente non fu utilizzato per dissodare il terreno. L’aratro dal Vicino Oriente si diffuse in Egitto, a Cipro, in Grecia e in Italia. Successivamente, l’introduzione del ferro, lo trasformò in aratro a telaio, che arava più profondamente. Fino a poco tempo fa, alcuni relitti d’agricoltura discontinua si sono registrati nelle regioni montane della Spagna, del Portogallo e del Massiccio Centrale. In questo sistema di coltivazione non era utilizzato alcun tipo di concimazione (Kostrowichi, 1980).
- Sistema a maggese, consiste nella limitazione del periodo di riposo del suolo ad un
tempo molto breve. È
un’agricoltura mista, con la quale inizia l’associazione sinergica con
l’allevamento, indispensabile nel breve periodo di riposo. Si semina per
1-2 anni e successivamente, si lascia il terreno a riposo per uno o più
anni, allo scopo di stimolare la nitrificazione e di migliorare la
struttura del suolo. Il sistema a maggese si è evoluto, a partire dal sistema
a cultura mobile, parallelamente all’aumento di densità demografica.
Spesso si seminava cereali, il che favorì l’invenzione della falce. La
trebbiatura avveniva sull’aia, il grano veniva mietuto alto lasciando la
paglia sul campo. Furono terrazzati numerosi pendii di montagna,
soprattutto quando iniziò l’irrigazione dei terreni (Indocina). Nel mondo, il sistema a maggese, si è diversificato in una miriade
di forme, che possiamo raggruppare in:
- Aridocoltura, con la quale il maggese divenne
più accurato. Affinché
il suolo assorbisse le piccole quantità d’umidità e limitasse
l’evaporazione, si doveva dissodare il terreno con arature e zappature. L’allevamento era meno legato alla
coltivazione e il suolo era fertilizzato con paglia (Sinskaja, 1969).
L’aridocoltura, diffusa in Africa Settentrionale e in Asia, è applicata
anche nell’agricoltura moderna.
- Sistema a rotazione biennale, un anno di coltura e uno di
maggese. Quando dal Vicino Oriente l’agricoltura si diffuse nel
Mediterraneo (Grecia, Roma), essa trovò un clima più favorevole. La
rotazione biennale si basa su tre cardini: coltivazione delle piante
annuali (prevalentemente cereali), coltivazioni perenni (alberi da
frutto) e pastorizia. L’arrivo degli Arabi, soprattutto sulla sponda sud
del Mediterraneo, differenziò ancora le cose: il grano duro sostituì
quello tenero, s’introdussero la palma da dattero e il cotone; la canna
da zucchero e il riso comparvero nei territori irrigati, si limitò la
vite per divieti di natura religiosa. L’introduzione del mais ridusse
l’estensione del sistema biennale ai soli territori dell’Italia
settentrionale, della Spagna e di molte zone dell’Africa del nord
(Chevalier, 1939). La rotazione biennale permette la possibilità di una
coltura promiscua (olivo, noce, ciliegio, vite, pistacchio, mandorlo,
ecc.).
- Sistema a rotazione triennale, che si distinse dal sistema a
rotazione biennale, in ragione delle diverse condizioni naturali presenti
fuori dalle regioni a clima mediterraneo. Esso si basa sulla
contemporanea coltivazione di piante invernali e primaverili in due campi
distinti e il maggese nel terzo, secondo una successione delle colture
conciliabili tra loro. Il maggese era sempre accompagnato dal pascolo
degli animali. Fu necessaria l’invenzione dell’aratro a vomere. Con la
crescita della densità di popolazione e la riduzione delle terre
coltivate si rese necessaria un’attenta scelta della piante da coltivare:
colture invernali il primo anno con segale e frumento, colture
primaverili il secondo anno con avena e qualche leguminose e maggese il
terzo anno. All’esterno dei villaggi, si assegnavano le terre, in modo
che ognuno potesse avere tre campi, ciò permetteva l’utilizzo comune e
alternato degli attrezzi. Nel sistema a rotazione triennale fu decisivo
il legame tra terra e animali, utilizzati come forza trainante e come
fornitori di concime. Tale legame si è sciolto soltanto con l’avvento
dell’agricoltura industrializzata.
- Sistema infield-outfield (Gray, 1952), presente nelle regioni nord-occidentali dell’Europa, nelle quali non era possibile la rotazione triennale. Dal sistema a maggese puro, di sviluppò un sistema orientato sempre più sull’allevamento degli animali e nella coltura più o meno continua delle terre situate nelle immediate vicinanze dell’insediamento (infield), integrata con la coltivazione alternata al riposo, delle terre situate più lontano (outfield). Il frumento fu sostituito dall’avena, che una volta raccolta lasciava il posto per altre colture dal mese di ottobre fino a fine aprile. L’outfield talvolta manteneva il sistema a coltura mobile, mediante incendio di bosco. Il sistema infield-outfield si diffuse in tutta la Gran Bretagna, salvo la parte sud-est dove si praticava la rotazione triennale, poi in Irlanda, Bretagna e Norvegia. L’enclosures trasformarono i proprietari in affittuari, ponendo la parola fine all’outfield-infield, del quale restano soltanto delle piccole tracce.
- Resti dei sistemi a maggese nel paesaggio agricolo contemporaneo, si dividono in: sistemi a campi aperti, collegati con la rotazione
triennale e soprattutto con la rotazione triennale regolata (Francia di
nord-est, Germania, Polonia e Russia occidentale); sistemi a campi
chiusi, determinati da altre forme di coltivazione (nord della Spagna,
Francia occidentale, Gran Bretagna, nord-ovest della Germania, Danimarca
e Paesi scandinavi).
1.2.2. Sistemi d’agricoltura intensiva e continua
- Sistemi
intensivi con irrigazione. Il passaggio ad un’agricoltura intensiva su larga scala richiese che
si risolvesse il problema della fertilizzazione stabile e sistematica del
suolo. Ciò avveniva possedendo alla perfezione le tecniche d’irrigazione
del suolo con contemporanea concimazione, oppure, tramite un più razionale
avvicendamento delle colture e un più largo uso del concime animale.
Nell’agricoltura mista (piante e animali) l’elemento più importante è il
suolo, mentre in quella irrigua è l’acqua, la quale viene convogliata nei
campi mediante la costruzione di adeguate opere idrauliche. Si usa da
sempre nelle zone aride o semi-aride, nei paesi ad insufficienza
stagionale (clima monsonico) e per aumentare le rese nelle zone dove le
precipitazioni sono sufficienti (Kostrowichi, 1980).
- Sistemi sfruttanti le acque
alluvionali,
con i quali già in epoca pre-agricola si otteneva la raccolta di cereali
selvatici, concimati grazie al limo. Tali acque erano deviate mediante
l’uso di semplici bastoni o tramite la costruzione di piccoli argini di
contenimento e di deviazione. Questi sistemi venivano praticati nel
Vicino Oriente e nell’Africa del nord.
- Sistemi sfruttanti le acque del
sottosuolo, delle sorgenti o delle oasi, che sin da subito ebbero carattere
intensivo. Si costruirono pozzi e canali lunghi anche 10-15 km che
permettevano una migliore diffusione dell’acqua anche in territori
sprovvisti.
- Sistemi agricoli dei grandi fiumi, con i quali la conoscenza
dell’uomo si trasferì ”dall’idroagricoltura all’economia idraulica”
(Wissmann, 1956). La regione, per eccellenza, nella quale si svilupparono
tali sistemi fu la Valle del Nilo, dove l’acqua e il limo si depositavano
sugli argini. Il periodo fu tra il 3000 e il 2500 a.C. La recente
costruzione delle dighe ha obbligato l’utilizzo di concimi minerali,
poiché, regolando le piene impediscono al limo di svolgere la sua
funzione; inoltre si sono sostituite le coltivazioni di piante per il
mercato con altre più adatte all’esportazione. Gli Arabi, avendo imparato
la tecnica dell’irrigazione in Mesopotamia e in Egitto, la diffusero nel
nord dell’Africa e in Spagna meridionale, la quale divenne un fiorente
paese agricolo. L’irrigazione si compie mediante complicati sistemi di
canali e d’acquedotti, che si estendono ancora oggi lungo le coste della
Valencia, Murcia e Andalusia (Chevalier, 1939).
- Agricoltura irrigua dei paesi
monsonici, la
più grande regione si trova nel territorio della Repubblica Popolare
Cinese. È l’agricoltura con la più alta produttività marginale della
terra, ma non del lavoro. Il riso può arrivare ad essere piantato anche
quattro volte nello stesso anno. Una produttività dettata dalla fame,
dall’alto numero di lavoro e dall’ingegnoso riutilizzo d’ogni genere di
composto organico come concime. L’allevamento è secondario e il suo scopo
primo è procurare concime e forza trainante, ma solo pochi contadini
utilizzano attrezzi per arare, che spesso sono trainati dagli uomini
stessi. Il suolo è concimato con loess, fuliggine, cenere, terracotta
tritata delle stufe, ogni genere di rifiuti e 1/3 con deiezioni umane
(Kostrowichi, 1980).
- Sistemi d’agricoltura irrigua
dell’America indigena. L’irrigazione e il terrazzamento dei pendii erano noti anche in
alcune parti dell’America pre-colombiana. Sistemi d’irrigazione con
acquedotti e canali, risalenti al I millennio d.C., si sono ritrovati in
alcuni siti Inca, mentre i Maya pare non abbiano utilizzato l’agricoltura
irrigua, anche se rimane la questione di come siano riusciti ad essere
così evoluti e numerosi (Kosok, 1965). Nella Valle del Messico c’era la
più alta concentrazione d’agricoltura irrigua. Caratteristici del Messico
e del Perù, erano gli orti galleggianti o Chinampas, cioè isole
artificiali costruite sulle acque poco profonde dei numerosi laghi e
composte da fanghi tratti dal fondo e piante acquatiche.
Per migliaia d’anni, il 60-70 % della
popolazione del mondo è vissuta in condizioni caratterizzate dall’agricoltura
irrigua, garantendo un benessere sociale che, riflettendosi sul mondo
scientifico e artistico dell’epoca, ha permesso di raggiungere elevati livelli
di civiltà (Kostrowicki, 1980). L’agricoltura irrigua, specialmente quella cinese, ha raggiunto un equilibrio
e una stabilità mai vista prima, anche nei confronti dell’agricoltura
industrializzata.
Se ancora oggi la superficie di terre
irrigue sta continuando ad aumentare, lo si deve in principal modo alla regione
dell’Asia meridionale che è l’unica regione con un trend positivo (PNUE,
2002). Sui 255 milioni di ettari di terra irrigua che
conta il mondo, circa 180 fanno parte di tale regione, inoltre dai 25 ai 30
milioni di ettari hanno subito una degradazione pronunciata a causa della
eccessiva salinizzazione e circa 80 milioni di ettari soffrono in generale di
problemi di saturazione e salinizzazione (FAO, 1995). L’uso non sostenbile
della terra si porta seco, indirettamente, il problema della deforestazione,
necessaria per equilibrare le perdite di terreno e fertilità.
·
Sistemi
intensivi senza irrigazione. Già nei
sistemi ad agricoltura mobile, nei villaggi e nelle immediate vicinanze, si
ritrovano delle coltivazioni ad agricoltura continua. Il villaggio è pur sempre
un punto di concentrazione di materia organica che può essere impiegata per
concimare, consapevolmente o inconsapevolmente. I Kigazi, che vivono
nella parte sud-orientale dell’Uganda e nel Ruanda, grazie ad un’agricoltura
molto intensiva hanno raggiunto in una regione di circa 1000 km² una densità di
popolazione che va da 200 a 400 abitanti per km², anche in mancanza di
bestiame. I Kikuya del Kenia, grazie anche alla concimazione con
deiezioni ovine, mantengono circa 160 abitanti per km². I Chaga, alle
falde del Kilimangiaro, arrivano a 250 abitanti per km² (Gourou 1953).
L’agricoltura intensiva era presente anche nell’America pre-colombiana, oltre
che nei paesi monsonici. In Europa, dove le precipitazioni sono sufficienti, il
fattore riduttivo per l’agricoltura continua è stato soprattutto il suolo,
quindi la concimazione dei terreni. Si formava un circolo vizioso dato dal
fatto che, il bestiame serviva per concimare e che la terra doveva essere usata
soprattutto per coltivare le piante per sfamare gli uomini e non per foraggiare
gli animali. Un altro fattore che permise il passaggio dal maggese
all’agricoltura intensiva fu l’introduzione nell’avvicendamento di piante molto
produttive, come il mais e le patate. Un tipo di avvicendamento ancora presente
nell’Europa meridionale, USA, Asia sud-orientale, Africa e Vicino Oriente è
quello dell’alternanza tra frumento e mais. Un altro
sistema d’avvicendamento è formato da, in ordine cronologico, mais, maggese
nero, frumento, incolto (Meryland). Nei territori
più aridi: maggese, piante invernali, piante da tubero, piante primaverili. I
fattori che permisero il passaggio dal maggese all’agricoltura continua furono
molteplici: maggior impiego di lavoro umano, maggior impiego di capitale e le
condizioni naturali. La coltura intensiva non necessariamente significava rese
più alte e inoltre non esiste una via universale di progresso dell’agricoltura,
che tra l’altro non è sempre crescente. L’introduzione delle piante da tubero e
delle papillonacee, aumentò la quantità di foraggio per il bestiame, il quale
permise, per effetto del concime, rese maggiori. Soltanto un’agricoltura
fondata su fondamenti scientifici può assicurare la crescita della produttività
della terra, indispensabile in condizioni di crescita demografica accelerata.
·
Sistemi
d’agricoltura industrializzata. I primi ad
intraprendere degli studi sull’agricoltura furono i Greci e i Romani, poi solo
con l’Illuminismo si riprese l’indagine della natura e dell’agricoltura. Il
rapido incremento demografico e la fuga dalle campagne, lo imponevano, in modo d’assicurare
una produzione continua, ininterrotta e più abbondante, rispondente alle nuove
condizioni sociali. Tuttavia nel corso di questi ultimi cento anni il progresso
ha avuto un’evoluzione maggiore che nel corso dei millenni precedenti. La
conoscenza agricola si è dissociatà dalla pratica, dando ulteriore impulso allo
sviluppo della geologia, metereologia, climatologia, idrologia, agronomia,
chimica, biologia e infine dell’ingegneria genetica. Con la “rivoluzione
verde”, avvenuta nel Dopoguerra, l’agricoltura ha beneficiato di una
razionalizzazione e massimizzazione produttiva dovuta alla:
1.
Concimazione dei terreni. Nel 1840 Justus von Liebig scoprì che le piante hanno bisogno del
potassio, del fosforo, dell’azoto e di alcuni microelementi come il ferro, il
manganese, lo zinco, il rame, il cobalto, il molibdeno e altri. L’utilizzo dei
concimi chimici permise un aumento del 50-60 % della resa per ha, oltre che un
aumento dei costi materiali (Kostrowicki, 1980). Tuttavia tra concimi chimici e
letame, i risultati sono differenti, nel breve periodo migliori per i primi, ma
nel lungo periodo migliori per il secondo. Nell’insieme il secondo sembra avere
rese minori, ma è il solo a mantenere l’humus nel terreno, evitando fenomeni di
erosione e lisciviazione. I concimi chimici andrebbero usati in sinergia con i
concimi organici, senza mai sostituirli del tutto.
2.
Avvicendamento delle piante coltivate, con lo scopo di migliorare le condizioni di crescita e
d’utilizzazione dei suoli, e d’incrementare la fertilità. È l’elemento
fondamentale dell’organizzazione moderna della produzione vegetale per
l’azienda agricola. L’ordine si divide in elementi: il primo elemento
dell’avvicendamento non è un cereale, così da costituire una buona coltura di
rinnovo per le altre piante; l’ultimo elemento è un cereale. Inoltre esistono
anche seconde semine, che aumentando il grado di
flessibilità, favoriscono lo smercio. Non è
corretto raccomandare l’adozione di un unico sistema d’agricoltura a
prescindere dalle condizioni locali.
3.
Impianti idro-climatici, costruiti dapprima in Egitto e in Sudan, essi permisero, sia di aumentare
la coltura del cotone, sia di passare all’agricoltura continua: nel 1902 fu
costruita la prima diga di Assuan, sopraelevata nel 1912 e nel 1933 e
definitivamente riprogettata e ricostruita negli anni ’80. Al posto dell’antica
irrigazione per sommersione alluvionale, si praticano numerose irrigazioni a
solchi durante l’anno. Si sostituirono le colture, introducendo il cotone, il
riso e la canna da zucchero, migliori per essere smerciate sul mercato. Se
l’Egitto era, in passato, il paese delle eccedenze agricole, oggi non produce
una quantità di cibo sufficiente per la popolazione indigena. Unica pianta
alimentare introdotta fu il mais, che ha sostituito il frumento. I raccolti
inizialmente aumentarono, com’è naturale che avvenisse, grazie alla millenaria
riserva di fertilità del suolo mantenuta dall’irrigazione per sommersione, poi
però i raccolti cominciarono a diminuire e diminuiscono tuttora. Anche
nell’Indo e nelle regioni aride del Pakistan e dell’India l’irrigazione
continua mediante canali, non è rimasta senza effetti dannosi: saturazione
idrica e eccessiva salinizzazione del suolo; il che ha reso necessario lo scavo
di canali di scolo. Al momento attuale, la Cina possiede la maggior quantità di
terre irrigate del mondo. In USA l’utilizzo dell’acqua ha esaurito le falde
sotterranee, costringendo trivellazioni sempre più profonde, inoltre le acque
usate cariche di concime in eccesso, trasportate dal Mississippi fino al Golfo
del Messico, contribuiscono alla formazione delle maree nere d’infiorescenza
algale, famose anche nel nostro Adriatico (cfr par 3.3.4.). La moderna
agricoltura consente lo sfruttamento di regioni precedentemente troppo aride,
anche se talvolta i rapporti di conduzione della terra limitano la sua reale
efficacia. In quasi tutto il mondo si assiste alla sostituzione
dell’irrigazione per sommersione con quella a solchi con acqua di fiume, con
aumento della produttività e della complessità. Le bonifiche, infine, hanno
giocato un ruolo importante nell’agricoltura, effettuate per rendere
coltivabili determinate zone paludose e per strappare al mare terre coltivabili
(Polder).
4.
Miglioramento e difesa delle piante coltivate, attraverso la selezione e l’incrocio di piante. Già
negli anni ‘50 il frumento Norin, permise una resa di 60-90 q/ha. La sua
introduzione pose non poche difficoltà in termini di minore resistenza alle
malattie e ai parassiti, della necessità d’una forte concimazione minerale e di
un’accurata azione di difesa fitosnitaria, cosa che impose una ristrutturazione
del sistema agricolo e che accellerò quel processo di decomposizione del
villaggio rurale, nel quale i piccoli coltivatori, incapaci di adeguarsi al
nuovo sistema agricolo, vennero “scacciati” dai contadini benestanti meglio
adattati. Le conseguenze negative dell’uso dei pesticidi sono enormi, essi
eliminano molti animali che combattono i parassiti stessi e molti insetti che
impollinano le piante, lasciando abbondanti residui tossici nocivi (cfr. par
3.3.2.).
5.
La meccanizzazione dell’agricoltura si è diffusa soltanto là dove le condizioni naturali
sono favorevoli, dove le aziende sono grandi, dove la manodopera non è a buon
mercato e dove prevale la coltivazione dei cereali cioè in Canada, Argentina,
Australia, Stati Uniti, Russia e dopo la seconda guerra mondiale anche in
Europa. Il rapporto tra SAU (Superficie Agricola Utile) e trattori è maggiore
per Europa e USA, minore per la Russia e l’Europa dell’Est. L’azienda agricola
meccanizzata è sempre meno dipendente dalle variazioni del tempo e sempre più
dalle fluttuazioni del mercato. Oggi l’industria interviene direttamente nella
produzione agricola fornendo all’agricoltore macchine, energia, sostanze
chimiche e sementi. L’incremento della meccanizzazione porta ad una sempre
maggiore produttività del lavoro, ma con piccoli incrementi di produttività
della terra; senza dimenticare che già dagli anni venti ci si rese conto della
dannosità della monocultura. Nel mondo, tuttavia, continuano a predominare il
lavoro manuale e la forza motrice degli animali (Kostrowichi, 1980).
Come vedremo nei prossimi capitoli, la
troppo aggressiva attività agricola dell’uomo ha provocato assai spesso la
distruzione dell’ambiente di cui esso si serviva e il conseguente abbandono,
dell’agricoltura, dai territori precedentemente sfruttati e talvolta anche
d’interi popoli e civiltà. Ne sono testimonianza i nudi pendii collinari
distrutti dall’erosione su grandi estensioni di territori dall’Atlantico, ai
bacini fluviali cinesi, ricoperti un tempo di boschi, prati e pascoli o campi;
terreni dove l’insufficiente conoscenza delle condizioni naturali e/o
un’economia di rapina ai fini di profitto, hanno portato ad una sconfitta
dell’uomo, con effetti irreversibili. Negli USA già dal 1930 l’erosione fu
riconosciuta ufficialmente come un grave pericolo per la società (Wissmann,
1956).
1.3. Sistemi d’allevamento d’animali
Non si sa se l’allevamento provenga dalla caccia oppure dalla pastorizia.
Esistono varie conduzioni d’allevamento, in relazione all’utilità e al suo
rapporto con l’agricoltura:
·
marginale,
secondario rispetto alla coltivazione delle piante;
·
sentimentale,
non utilitaristico;
·
senza
coltivazione delle piante;
·
collegato alla
coltivazione delle piante
Ecco qui di seguito una classificazione abbastanza esaustiva delle forme
d’allevamento, anch’essa riprende quella del libro “Geografia
dell’agricolutra” del Kostrowicki (1980).
1.3.1. Sistemi domestici
Essi erano già presenti nell’agricoltura mobile ad incendio di bosco e in
quelli ad incendio di macchia. Gli animali venivano utilizzati per il traino e
come fonte di concime e avevano una grande libertà di movimento, potendo in
alcuni casi arrivare a pascolare intorno alle case.
1.3.2. Sistemi a pascolo
La caratteristica di tali sistemi è di far uso esclusivamente della
vegetazione spontanea per il nutrimento degli animali:
·
Pastorizia
nomade. Partendo dai confini della Cina,
attraverso la Mongolia, l’Asia centrale, il Vicino Oriente, l’Africa
meridionale atlantica e poi, partendo dall’India orientale, lungo i confini
delle grandi regioni boscose di Asia ed Europa, fino alla Polonia, la Moldavia
e alla pianura ungherese, si estendevano un tempo immense regioni di steppe,
circondate da radi boschi aperti, definiti come “steppe boscose” e interrotte
soltanto dai deserti. Dato che il clima passava dal secco estivo al freddo (con
presenza di neve) invernale, tipico del clima continentale, era necessaria la
migrazione del gregge. Quei popoli da sedentari divennero nomadi e la
nomadizzazione ebbe un effetto a catena, cosicché i popoli nomadi crebbero di
numero e in potenza, grazie anche ai saccheggi, alle scorrerie e
all’assoggettamento dei popoli sedentari. Successivamente accadde il processo
inverso, via via che si costituivano gli stati moderni che disponevano
d’eserciti e d’armamenti, si ridusse la preponderanza militare dei nomadi sui
sedentari. D’allora il numero dei nomadi è calato e quelli che sono rimasti
sono fortemente influenzati dai popoli sedentari.
·
Sistema
otgonny. Caratteristica di questo
sistema è il compromesso tra le esigenze dei popoli sedentari (ex-URSS) e le
esigenze di quelli nomadi (Kazachi). Conservando il pascolamento
migrante e utilizzando l’esperienza pluriennale della pastorizia nomade, tale sistema
unisce i dettami della scienza moderna alla tradizione. Nella pratica ci fu la
creazione, nei luoghi di svernamento degli animali, di scorte indispensabili a
causa del ghiaccio e della neve, la creazione d’abbeveratoi lungo le piste di
transito, la presenza di punti di assistenza sanitario e veterinaria, la
meccanizzazione della produzione (forniture di fieno, acqua, tosatura delle
pecore, mungitura delle mucche, macello e trasporto) e l’organizzazione di
condizioni culturali e di vita. Il sistema otgonny è la forma più razionale e
intensiva d’allevamento pastorizio (Kostrowicki, 1980).
·
Pastorizia
migrante stagionale, che a differenza degli altri
sistemi, utilizza alternativamente due pascoli, ciascuno dei quali nutre gli
animali che per una parte dell’anno. Nel gruppo solo una parte della
popolazione resta nomade, ma la maggior parte degli abitanti resta nelle loro
sedi, occupandosi della coltivazione dei campi. La transumanza è legata,
quindi, a determinate condizioni naturali, geografiche: l’esistenza di regioni
pianeggianti, temperature invernali sopra i sei gradi e presenza di montagne
per il pascolo estivo. In Spagna si sviluppò enormemente (la Mesta o la Dogana)
la transumanza, grazie alla quale si produceva la famosa lana merinos, alla
base dello sviluppo delle prime industrie tessili europee. La transumanza era
presente anche in Italia, in Francia, poi in Romania (durante la dominazione
turca), nell’ex-Yugoslavia, nei paesi balcanici, nel Maghreb, in Turchia, Iran,
Iraq, ma non nei paesi tropicali. Essa è ancora in via di sviluppo là dove si
sta sostituendo alla pastorizia nomade.
·
Pastorizia montana estiva, presente sulle Alpi e Pirenei. Caratteristica di questa pastorizia è la
breve distanza dei pascoli, situati ad altitudini differenti e di conseguenza
la marcata presenza dei bovini. Essa può essere coadiuvata dal turismo.
Presente anche sugli Appennini come pastorizia montana mediterranea.
·
L’allevamento
al pascolo di renne. Il suo addomesticamento è
posteriore a molti altri animali. L’allevamento delle renne è presente in
alcune zone dell’Eurasia. Molto è stato scritto sul fatto che le migrazioni
delle renne addomesticate coincidano con le migrazioni delle renne selvatiche,
che l’uomo ha osservato e che si è limitato a seguire. In altre parole è l’uomo
che si è “addomesticato” alla renna, seguendola nei suoi spostamenti. Come il
cammello nel deserto, così la renna è l’animale della provvidenza per l’Artide,
esse procurano il tiro per le slitte, il latte, la carne e gli abiti caldi.
Sulle acque ghiacciate del lago Baikal vive una popolazione nomade che si
sposta, assieme al gregge di renne, glissando su delle piccole casette di legno
slittate.
·
L’allevamento al pascolo del Nuovo
Mondo. Durante l’epoca precolombiana
s’inventarono nuovi sistemi di pascolo, nei quali le mandrie venivano lasciate
libere di pascolare. Gli animali erano marchiati e la raccolta delle carni era
fatta soltanto due volte l’anno. Successivamente si costruirono dei recinti e
si utilizzò il treno per trasportarli. Gli addetti ai lavori si chiamavano Cowboys, Rancheros, Vaqueros,
Gauchos.
1.3.3. L’allevamento sentimentale
L’allevamento sentimentale è effettuato senza precisi scopi di lucro, ma ha
semplicemente natura sentimentale. Si effettua nelle immediate vicinanze delle
case e serve per i bisogni degli abitanti della casa stessa. Se un tempo tale
tipo d’allevamento aveva come ragione d’esistere il fatto di limitare i costi e
talvolta rendere accessibile carne, uova, latte, lana e pelli senza la
necessità di acquistarli su mercati lontani, oggi le ragioni si sono spostate
sulla qualità, almeno nei paesi sviluppati. Il bisogno di poter disporre di
prodotti di qualità, che abbiano il gusto di una volta, spinge gli abitanti
delle campagne a dotarsi di un piccolo pollaio e/o un piccolo recinto nel quale
far pascolare qualche capo di bestiame.
1.3.4. L’allevamento pascolo-stalla
È il sistema d’allevamento prevalente in Europa, con il quale si ritrova
l’interdipendenza con la coltivazione delle piante. Esso sorge e si sviluppa là dove le condizioni climatiche invernali non
permettono il pascolo annuale e il mantenimento degli animali, i quali durante
l’inverno rimangono nella stalla, alimentati con le scorte di foraggio. In
questi ultimi anni è arrivato ad avere più peso della coltivazione delle
piante. Le aziende agricole a pascolo-stalla si
dividono a seconda dell’importanza data alla componente vegetale:
·
Aziende ad
indirizzo fito-zootecnico, che vendono sia prodotti vegetali che animali.
·
Azienda ad
indirizzo zoo-fitotecnico, che invece trasformano tutta la produzione vegetale
in foraggio per gli animali.
1.3.5. L’allevamento a stalla
Al livello più alto del suo sviluppo, l’allevamento perde quasi
completamente ogni legame con la coltivazione dei campi. La meccanizzazione e i
concimi minerali, hanno sostituito il traino e il concime naturale, e hanno
reso inutile la stretta interdipendenza che, per lungo tempo, esisteva tra
allevamento e coltivazione delle piante. I mangimi, concentrati o voluminosi,
si acquistano sul mercato. Spesso le aziende non possiedono neanche i pascoli,
ma solo locali al chiuso per gli animali, magari posti vicino alle città per
beneficiare della vicinanza del mercato. Tutti però ci ricordiamo le vicende
della “mucca pazza” e la febbre aftosa, dovute ad un utilizzo improprio di
mangimi d’origine bovino (ossa e carni frantumate) somministrato agli animali. Ci ricordiamo anche dei polli alla diossina. Molto
spesso gli animali sono costretti a soggiornare in gabbie piccolissime, senza
vedere mai la luce del sole e gli vengono somministrate quantità crescenti di
antibiotici. Ciò li rende sempre più deboli ed
esposti a malattie sempre più difficili da curare e, in alcuni casi,
trasmissibili all’uomo, non ultima quella della febbre dei polli, anche se le
ragioni della sua esplosione non sono ancora conosciute.
2. CARATTERISTICHE ECONOMICO-SOCIALI E
FORME DI PROPRIETÁ DELL’AGRICOLTURA
Le caratteristiche sociali e le forme di
proprietà nell’agricoltura definiscono chi è l’agricoltore e quale sia la sua
relazione con la terra sulla quale lavora e con le altre persone che lavorano
su di essa. Attraverso questa analisi possiamo di nuovo renderci conto della
grande varietà di conduzione della terra che esiste, quanto le consuetudini e
successivamente la legge si sono adattate all’agricoltura e quanto
l’agricoltura abbia in qualche modo subito l’influenza delle regole e delle
leggi.
Il Kostrovicki (1980) ci mostra, ancora
una volta, una schematizzazione molto efficace delle caratteristiche
economico-sociali delle forme di agricoltura, evidenziandone l’aspetto
geografico.
Iniziamo l’analisi dicendo che
l’agricoltore non è sempre il proprietario della terra.
2.1. Proprietà comune
Nella proprietà comune il diritto di
godere e disporre della terra spetta ad un determinato gruppo di persone, una
comunità, una tribù o una società. In essa il lavoro e la proprietà spettano a
tutta la comunità.
2.1.1. Società di raccolta e caccia
Abbiamo già visto che tali società erano
possibili soltanto entro certe condizioni demografiche. Si dava per scontato il
riunirsi in tribù, in quanto garantiva una maggiore possibilità di
sopravvivenza. Basti pensare ai vantaggi per la caccia degli animali selvaggi
di una certa stazza o semplicemente alla difesa all’interno del piccolo
accampamento. Soltanto armi e attrezzi erano di proprietà personale, ma il
resto era naturalmente in comune.
2.1.2. Società di pastori
Molto simili alle società di raccolta e
caccia, quelle di pastori estendono la proprietà individuale, oltre che ad armi
e attrezzi, anche agli animali. In Perù, per esempio, i lama, che pascolano
liberamente all’esterno dei villaggi, sono riconoscibili dai vari proprietari
grazie ad un piccolo ciuffo di lana colorata con colori diversi per ogni
proprietario e cucito sulla punta degli orecchi.
2.1.3. Comunità agricole
Con le società agricole, la proprietà
individuale si estende alle piante ed ai frutti delle piante di colui che le ha
piantate. Si crea un diritto all’uso dei terreni e, in alcuni casi, oggetto
d’eredità sono soltanto i beni mobili, mentre la terra dopo la morte ritorna di
proprietà della comunità.
Dove la legge di successione
trasferisce anche la proprietà della terra, si corre il rischio di una
parcellizzazione eccessiva degli appezzamenti. Soltanto la legge sul maggiorascato può limitare la degenerativa
polverizzazione delle proprietà.
In Kenya si stabiliscono i confini del
territorio che appartengono alla comunità agricola e poi si suddividono
successivamente in appezzamenti più piccoli, da assegnare a piccoli gruppi di 20-50
persone. Col crescere della popolazione tali territori vengono ridelimitati e
spetta ai sacerdoti e agli anziani tale compito (Chodak, 1963).
2.1.4. Ruolo attuale e futuro delle comunità agricole
La “Progress in Land Reform” (ONU, 1954-1976) suddivide i
paesi in tre categorie:
·
Paesi dove
le comunità agricole non occupano vasti territori. Esse sono scomparse in
maggioranza nel XIX sec. (Europa).
·
Paesi dove
prevale la proprietà individuale e dove una minoranza della popolazione conduce
le comunità agricole (indigeni): America del Sud, India, Asia centro orientale
e Oceania.
·
Paesi dove
tale condizione è dominante: Africa centrale.
In Italia tali comunità si estendevano
per tre milioni d’ettari (30.000 km²), pari al 10 % del territorio
(Kostrovicki, 1980).
Il massimo vantaggio delle comunità
agricole è l’esclusione dalla possibilità di speculare sulla terra e
l’esclusione dall’indebitamento, che sono delle vere e proprie piaghe per
l’agricoltura individuale. Quindi, sia per motivi sociali sia per motivi economici,
si deve tendere alla loro conservazione, fin quando è possibile e,
successivamente, trasformarle in aziende cooperative, conservando i lati buoni
delle comunità e modernizzando l’organizzazione e la tecnica agricola.
2.2. Proprietà individuale
Significa che la persona proprietaria
della terra possiede tutto il diritto di definire il modo e la portata del suo
uso, nonché il diritto di passare a terzi la proprietà di essa (America,
Australia, Europa, India e Giappone). La persona, giuridica o fisica, ha il
potere di godere e disporre in modo esclusivo del terreno in proprietà.
2.2.1. Le grandi proprietà terriere come residuo del feudalesimo
Le origini e le cause che hanno
formato le grandi proprietà, sono le più svariate:
·
usurpazione
di terre comuni ;
·
conquista
militare ;
·
assegnazione ;
·
concentrazione
tramite acquisto o costrizione.
Gli inizi dello sviluppo della grande
poprietà agraria (latifondo) cadono dalla dissoluzione della comunità
primitiva. Nell’evoluzione storica si distingue una grande proprietà terriera
di tipo schiavista, una grande proprietà di tipo feudale e una grande proprietà
individuale a carattere capitalistico.
La grande proprietà schiavista si
sviluppo dapprima in stretta relazione con l’agricoltura intensiva. Nella
proprietà schiavista il diritto del padrone si estendeva, oltre che alle terre
e agli immobili in essa costruiti, anche agli schiavi, dei quali aveva il
potere di vita o di morte. Dalle sue rovine e non solo, si sviluppò il
feudalesimo dell’Europa, determinando anche la nascita delle classi sociali. Il
padrone possedeva la terra e il lavoro dei contadini-sudditi, ma su di loro non
aveva più il potere di vita o di morte. La rendita da corvée fu
sostituita con quella naturale, con la quale il contadino pagava in natura.
Nonostante ciò, il contadino soffriva ugualmente la fame, in quanto le
percentuali di prelievo sul raccolto erano sempre troppo alte. Successivamente
la rendita naturale fu sostituita con la rendita pecuniaria.
La definitiva rimozione del sistema
feudale si ebbe con il capitalismo, secondo due differenti evoluzioni:
·
la via
americana, con una completa liquidazione
del sistema feudale (USA, Francia, Germania, Inghilterra e Olanda);
·
la via
prussiana, con un passaggio più graduale al capitalismo e con la sostituzione delle forme d’agricoltura feudale
(Russia, ex-Germania orientale, ma anche Italia, Spagna, Portogallo e America
del Sud).
Sistemi simili a quello feudale si sono
ritrovati in Africa tra gli Zulù, i Basuto, gli Ashanti e
gli Haussa-Fulani. I contadini Haussa, per esempio, costituivano una
classe di persone formalmente libere, tenute però alla prestazione di numerosi
servizi, corvèe, tributi e imposte a favore dei loro signori (Chodak, 1953).
In Vicino Oriente, Asia meridionale e
America Latina si è avuta una concentrazione della proprietà nelle mani di
poche categorie di grossi proprietari, accompagnata da una contemporanea
polverizzazione delle aziende agricole in piccoli possedimenti. Simile il
paesaggio in Spagna, Portogallo, Italia meridionale, Europa centrale.
Là dove domina la grande proprietà
terriera i proprietari, molto spesso, non si occupano della conduzione
dell’azienda, delegando a terzi la gestione. Anche la chiesa (Cattolica, Ebrea
o Musulmana) è proprietaria di molte terre.
2.2.2. La grande proprietà e l’affitto della terra
Una buona parte della grande proprietà
terriera privata è coltivata da piccoli agricoltori-fittavoli, che hanno
soltanto la facoltà di godere della terra che essi occupano. Si distinguono tre forme d’affittanza:
·
In cambio di determinati servizi.
Questa è la forma più primitiva del rapporto d’affitto ed è molto simile alla
rendita da corvée. Una forma ancora presente è l’encomienda dell’America
del Sud, con la quale in cambio dell’uso della terra, della difesa e dell’insegnamento
della fede, il contadino-fittavolo versa una piccola somma di denaro al
padrone. Malgrado ciò, l’encomienda si è trasformata ben presto in
un’organizzazione feudale. Altro esempio è dato dall’hacienda, simile
all’encomienda, che si è formata grazie all’espropriazione coatta dei territori
degli indigeni. Nell’hacienda, in cambio di un piccolo appezzamento di terreno
lontano e di bassa qualità, i membri delle comunità (Ayllu) sono
costretti a lavorare 3-5 giorni la settimana o tre settimane al mese sulla
terra dell’haciendero. Caratteristica comune delle due forme è che i
contadini-braccianti o fittavoli-braccianti ricevono, oltre alla terra, anche
una casa e dei prestiti ripagabili col lavoro e necessari per comprare gli
attrezzi, i vestiti e una parte del cibo (direttamente dall’haciendero). Molto
spesso i fittavoli finiscono in un circolo vizioso d’indebitamente dal quale
difficilmente riescono a liberarsi e grazie al quale l’haciendero riesce a
controllare meglio la sua forza lavoro (Flores, 1955).
·
In cambio di una parte della
produzione in natura o in denaro. La mezzadria è l’esempio più conosciuto con la quale il fittavolo è tenuto
a fornire al proprietario una quota superiore alla metà dei raccolti. Essa si è
diffusa nel Vicino e Medio Oriente, ma si ritrova anche in America del Sud,
Stati Uniti ed Europa meridionale, tuttavia le differenze sono enormi. In ogni
caso la mezzadria, inizialmente, era calcolata per lasciare al fittavolo il
minimo indispensabile per il mantenimento suo e della famiglia. Per esempio in
Iran il raccolto si divideva in quinti: un quinto per la terra, un quinto per
l’acqua, un quinto per le sementi, un quinto per i buoi e un quinto per il
lavoro e spesso al contadino non spettava che quest’ultimo quinto.
·
In cambio di un canone deciso in
anticipo.
Questa è la forma più vantaggiosa per l’affittuario, anche se uno svantaggio
risiede nell’eccessiva rigidità del canone. In alcuni, quando i contratti
prevedono lunghi periodi di locazione, gli affittuari provvedono a migliorare
le rese del suolo e ad impiantarvi colture di pregio. In alcuni contratti
enfiteutici di lunga durata, c’era un vero e proprio impegno da parte
dell’agricoltore ad apportare miglioramenti al fondo, che aveva avuto in
concessione. La diffusione dell’affittanza in
Europa ha avuto una certa logica geografica, tanto che oggi, se ci spostiamo da
Est verso Ovest rileviamo un graduale aumento percentuale delle forme
d’affittanza. Le densità maggiori si hanno in Gran Bretagna (intorno al 60%),
nella Francia nord-occidentale e nella Spagna sud-occidentale (Kostrovicki,
1980).
2.2.3. La grande proprietà come grande azienda agricola
Esistono esempi d’aziende agricole
basate sulla conduzione e gestione a carico del proprietario. Esse si
distinguono secondo i metodi di conduzione impiegati. Talvolta, tali aziende
sono gestite da fattori, oppure, come nel caso degli USA, da proprietari (side
walk farmers) che abitano in città e si recano in fattoria a lavorare o,
ancora, da proprietari (suitcase farmers) che abitano ancora più lontano
e si fanno vedere saltuariamente. Un altro esempio è costituito dalle grandi
piantagioni dell’America Centrale e Meridionale.
Oggi le grandi proprietà terriere
fanno capo a gruppi capitalistici, col vantaggio di poter investire ingenti capitali
nella ricerca, che spesso è indirizzata alla genetica, ma con lo svantaggio
sociale della conduzione anonima. La
coltivazione predominante è la monocoltura (caffè, banane, ananas, soya, mais,
ecc.), la quale, molto spesso, determina una rapida usura dei suoli, il che
tuttavia non infastidisce molto la proprietà che ha la possibilità di
trasferire i propri investimenti verso altri territori. Il risultato lo
conosciamo da tempo: impoverimento della terra, talvolta desertificazione, che
contribuiscono ad aumentare la dipendenza delle popolazioni autoctone verso le
grandi aziende agricole.
2.2.4. La piccola proprietà individuale
Arthur Young (1784) disse: “Date ad un
uomo una nuda roccia in proprietà e la trasformerà in giardino. Dategli in
affitto un giardino e in 10 anni lo trasformerà in deserto”. Questa frase
ci da un’idea dell’importanza che la diversa conduzione della terra determina
sui risultati dell’attività agricola.
La piccola proprietà individuale ha avuto
origine dalla frantumazione delle antiche comunità villaggio o dalla divisione
della grande proprietà (riforme agrarie). Oltre che in Europa essa è presente
nelle ex-colonie britanniche ed è molto rara negli altri paesi. In America
Latina s’incontra più frequentemente nel Brasile meridionale e nell’Argentina
settentrionale. Si trova anche in Giappone, dove costituisce la forma di
conduzione dominante. La piccola proprietà individuale è poco diffusa nei paesi
musulmani e in Africa. Nonostante il progresso tecnico e gli investimenti in R&S
delle grandi compagnie agricole, talvolta la conduzione familiare è preferita
dai consumatori per l’accuratezza del lavoro e per una serie d’argomenti di
carattere sociale, politico e psicologico.
L’ unico vero grande problema della
piccola proprietà è legato alla legge di successione che, col passare delle
generazioni, crea una polverizzazione delle proprietà. Ci sono dei casi di
proprietà sparpagliate sul territorio con una superficie di pochi m², invece,
là dove vale ancora la regola del maggiorascato le proprietà hanno mantenuto
una grandezza utile. La polverizzazione eccessiva crea infatti una difficoltà
sempre maggiore per il contadino che non riesce più ad ottenere una produzione
in grado di sostentarlo.
2.2.5. La cooperativa agricola
Tale assetto proprietario è stato creato
sia per far fronte alle difficoltà della piccola azienda individuale e sia per
godere d’alcuni vantaggi delle grandi imprese, prime fra tutte le economie di
scala. Inizialmente le prime forme di cooperativa si concentrarono sullo smercio
della produzione agricola, successivamente estesero le loro finalità al
credito, all’approvvigionamento, alla lavorazione, all’allevamento, alla
semina, ecc.
Essa si sviluppò moltissimo nei Paesi
scandinavi e, successivamente e in maniera minore, anche in Germania, Francia,
Italia e, negli ultimi decenni, nei paesi in via di sviluppo
2.2.6. Le riforme agrarie
Con il termine riforma agraria
s’intendono tutti i mutamenti dei rapporti agricoli introdotti in modo
evolutivo o rivoluzionario, per iniziativa del potere politico e/o
d’istituzioni private. Nei prossimi capitoli andremo a vedere da vicino la
nuova riforma agraria in Svizzera (par 4.3.).
La forma più semplice di riforma è la
trasformazione dell’affittuario in proprietario. Il suo fondamento è la ricerca
di un equilibrio tra bisogno di terra da parte della popolazione contadina e le
riserve di terra esistenti. La ridefinizione della dimensione delle terre varia
da riforma a riforma. In America Latina tutte le riforme si basano sulla
funzione sociale della proprietà, come principio cardine per una buona gestione
della terra. Secondo questo principio il proprietario ha l’obbligo nei
confronti della società di utilizzare la terra secondo metodi e modalità che
superino i rapporti sociali feudali. Le terre inutilizzate sono le prime a
subire l’espropriazione e, normalmente, si pone un divieto sull’affittanza in
cambio di lavoro.
In Italia meridionale nel secolo passato
vi fu l’espropriazione dei latifondi storici a favore dei contadini, malgrado
che molti di loro si trasferirono al Nord nel sogno di una vita migliore.
Tuttavia, le riforme che sono riuscite
ad uscire dalla burocrazia politica divenendo esecutive, non si sono realizzate
negli obiettivi che erano stati fissati e talvolta sono state un vero e proprio
fallimento (Kostrovicki, 1980).
Parallelamente là dove le proprietà
agricole si presenta polverizzata sul territorio, la commassazione dei fondi
rustici è una condizione essenziale per la modernizzazione dell’economia
agricola dei paesi in via di sviluppo.
Doreen Warriner afferma che la riforma
agraria nel mondo contemporaneo ha un’importanza pari alla liquidazione del
sistema feudale in Europa nei secoli passati (in Ellis,
1980, pag. 526).
2.3. La proprietà sociale
La proprietà sociale non significa
soltanto proprietà comune, assegnata ad un determinato gruppo o nazione, ma
estende il suo senso ad una conduzione di carattere sociale. La terra è
coltivata e usata in comune tra i membri del gruppo.
Furono le riforme agrarie socialiste ad
introdurre questa forma di proprietà all’alba della Rivoluzione Russa.
Inizialmente, tali riforme liquidarono il feudalesimo nelle campagne,
espropriarono la grande proprietà feudale o capitalistica e assegnarono le
terre espropriate ai contadini, stimolando le forme di cooperazione agricola,
con le quali si preparavano le basi dell’economia socialista. Il 1917 segnò
l’iniziò del passaggio dall’azienda contadina a quella socializzata. Nel
periodo che va dal 1924 al 1934 ci fu la fase della collettivizzazione forzata.
Nel 1940 il 99,3 % delle forme di proprietà rientrava nell’ambito dell’economia
socializzata (sovchoz e kolchoz) e negli anni a cavallo tra il
1950 e il 1962 tale politica si estese anche ai paesi satelliti del Patto di
Varsavia. Poco più tardi riforme radicali e spesso violente, si applicarono in
Cina. Anche lì la tendenza fu la medesima, cioè si formarono cooperative
agricole di grandi dimensioni.
La storia ci dimostra che, in realtà,
tali riforme furono lente nel migliorare la situazione socio-economica e le
rese in agricoltura, basti pensare che la Russia prima del 1917 era la più
grande esportatrice di grano e oggi è la più grande importatrice
(Rydenfelt, 1983). Non dimentichiamoci che da
cinque a dieci milioni di Russi morirono di fame a causa di ciò e sarebbero
stati il doppio se non fosse stato per gli aiuti internazionali (Smith, 1994).
2.4. Le aziende agricole
Secondo la definizione della FAO (1965),
per azienda agricola s’intende una superficie di terra utilizzata per intero o
parzialmente ai fini di produzione agricola, indipendentemente dal diritto
esercitato sulla terra, dalla forma giuridica della gestione, dalle sue
dimensioni, anche senza terra
(allevamento a stalla, coltivazioni fuori dal terreno, apicoltori). La
FAO ha cercato di trovare una definizione che contenesse tutti i casi
esistenti, utile per confrontare le diverse realtà presenti sulla terra.
L’azienda agricola con la sua autonoma
gestione delle risorse, delle scelte produttive, dell’organizzazione del lavoro
e della sistemazione del terreno costituisce dunque il primo e più piccolo
elemento geografico capace di esprimere globalmente e sinteticamente la
complessa problematicità della realtà agricola di una regione. È per questo
motivo che, nell’analisi dello spazio rurale, partire dall’esame dei caratteri
strutturali (superficie agricola utile, composizione della forza lavoro),
permette di evidenziare fin dalla fase iniziale dell’indagine le difficoltà e
gli squilibri presenti nell’area esaminata.
L’ampiezza della superficie aziendale è
un dato molto interessante per la descrizione geografica, ma non è sufficiente
all’interpretazione della realtà agricola, per la quale dovremmo analizzare
anche altri fattori come quello economico e quello fisico (fertilità, pendenza,
contaminazione, erosione o desertificazione).
2.4.1. I caratteri strutturali delle aziende agricole
Rispetto alle dimensioni, le aziende
dell’Africa, dell’Asia orientale e meridionale, sono quelle che in media hanno
le più piccole dimensioni, inferiori a cinque ettari per azienda agricola.
Anche le aziende agricole dei paesi mediterranei hanno piccole dimensioni,
comprese tra cinque ettari e 10 ha per azienda agricola. In Europa
Occidentale le superfici sono, in media, comprese tra 10 ha e 50 ha. Si hanno
aziende agricole molto estese in America Latina, USA e Canada, comprese tra i
50 ha e i 200 ha. Le massime estensioni si raggiungono in Bolivia, Argentina,
Australia e Russia, dove si superano i 200 ha per azienda agricola media
(Kostrowicki, 1980).
Partendo dal Giappone, esiste
una certa correlazione lineare tra la longitudine e la dimensione delle
aziende: se si escludono Russia e Australia, la dimensione delle aziende ha un
graduale incremento spostandosi da est verso ovest.
Guardando ancora più da vicino il caso
dell’Europa, i paesi si possono ordinare secondo la seguente classifica (Grigg
1966):
·
paesi nei
quali prevalgono le piccole aziende:
Spagna, Italia, Grecia, paesi dell’ex-Jugoslavia, Polonia e Norvegia;
·
paesi nei
quali prevalgono le aziende medio-piccole, comprese tra i cinque e i 50 ha: Austria, Svizzera, Finlandia;
·
paesi nei
quali prevalgono aziende di dimensioni superiori a 50 ha: sono i più numerosi.
Nel 1950 il 70 % degli agricoltori
lavorava in piccole aziende che ricoprivano 1/3 della superficie delle terre
coltivate (Kostrovicki, 1980). La seguente tabella mostra la percentuale dei lavoratori salariati rispetto al totale dei lavoratori
dell’agricoltura nel 1950:
Tabella 2.1. Rapporto tra salariati e lavoratori in
agricoltura
|
PAESI |
Belgio |
Grecia |
Austria e Irlanda |
Usa |
F, E, I CH, ND |
Canada |
Portogallo |
Gran Bretagna |
|
% |
7 |
8 |
10 – 20 |
24 |
20 – 30 |
35 |
61 |
64 |
Fonte: Kostrovicki, La Geografia
dell’Agricoltura, 1980.
In America Latina queste percentuali sono ancora più alte, mentre si
mantengono contenute in Africa e Asia.
2.4.2. I caratteri economici delle aziende agricole
·
Agricoltura
estensiva ed intensiva. Definite in
maniera talvolta diversa e non coerente dai diversi autori, le due agricolture
si differenziano prima di tutto per la densità colturale e cioè per il rapporto
tra superficie coltivata e superficie totale. Abbiamo visto, che tutte quelle
pratiche agricole che davano luogo ad un’occupazione incompleta o discontinua
dello spazio agricolo o quelle che imponevano periodi di riposo a maggese, erano
considerate di tipo estensivo. All’opposto, la continuità delle coltivazioni e
del lavoro umano nel tempo e nello spazio definiva l’agricoltura di tipo
intensivo. Successivamente, con la diffusione della meccanizzazione, dei
pesticidi, dei fertilizzanti e dei moderni strumenti di lavoro e
commercializzazione, la differenziazione tra agricoltura estensiva e intensiva
si è spostata sul rapporto tra capitale investito e resa. L’agricoltura
intensiva è diventata quella con alte spese di gestione e che richiede
un’elevata qualificazione professionale. Sono considerate intensive quindi,
anche le pratiche agricole delle grandi aziende capitalistiche, che impegnano
pochissima manodopera, notevoli capitali d’esercizio (acquisto di macchine,
concimi, pesticidi, lavoratori specializzati), anche se ottengono basse rese
per ettaro. Tuttavia, anche il rapporto tra investimento e ricavo sta
incontrando i suoi limiti nel distinguere agricoltura intensiva e estensiva,
visti gli impulsi sempre maggiori ad una “estensivizzazione” dell’agricoltura e
viste le politiche agricole ancora a sostegno delle colture facilmente
meccanizzabili. Dobbiamo quindi passare ad un nuovo dato, unitamente a quello
della densità delle coltivazioni, che è quello dell’intensità delle colture,
esprimibile nella Produzione Lorda Vendibile (PLV) media per ettaro di
Superficie Agricola Coltivata (SAC) (Grillotti, 1992).
·
Agricoltura
sotto l’aspetto commerciale. La qualità
delle scelte culturali e la loro combinazione sul territorio o nell’arco
dell’anno, esprimono anche il livello d’impegno richiesto all’agricoltore. La
policoltura piuttosto che la monocultura e la combinazione delle pratiche
culturali con l’allevamento, richiedono un impegno maggiore e si traducono in
una valorizzazione e rivitalizzazione del territorio. La policoltura promiscua
(cfr. par 1.2.1.) e l’integrazione dell’allevamento con le colture,
rispondevano prima di tutto alle esigenze dell’autoconsumo. L’agricoltura
moderna, fatta eccezione per alcune regioni dei paesi in via di sviluppo, è
invece del tutto svincolata dai bisogni essenziali del coltivatore e risponde
alle esigenze del mercato e degli scambi internazionali, arrivando talvolta a
condizionare gli scambi e a guidarli. Proprio
sotto l’aspetto commerciale s’individuano:
1.
L’agricoltura di sussistenza. La vera agricoltura di sussistenza, cioè quella monoculturale, è
praticata oggi solo da alcune popolazioni isolate della foresta Amazzonica,
della Nuova Guinea e dell’Africa nera. Più in generale l’agricoltura di
sussistenza comprende tutti i casi nei quali la popolazione rurale spende più
dei due terzi delle sue risorse (suolo, lavoro, capitale) per ottenere il
necessario per la sopravvivenza. Questa definizione estende questa forma agricola
a tutto il continente africano, all’India, alle Filippine, all’Asia
sud-orientale e all’Indonesia (Grillotti, 1992). È pur tuttavia un’agricoltura
della fame, molto fragile, date le difficoltà di controllo ed utilizzo delle
risorse naturali e di conservazione dei prodotti. Diversa, ma rivolta sempre
all’autoconsumo, la policoltura promiscua tradizionale dà al contadino una
forte autonomia sul piano alimentare. Praticata dai paesi non ancora
industrializzati e anche in alcune regioni d’Italia fino al primo dopoguerra,
la sua forza sta nella presenza di colture diverse tra loro che, anche in
condizioni climatologiche avverse, permettono di ottenere in ogni caso un
qualche risultato, oltre che destagionalizzare la produzione.
2.
L’agricoltura di mercato. Il forte dispendio di tempo e forza lavoro richiesto dalla policoltura
promiscua (bassa produttività del lavoro) ha spinto l’agricoltura verso la
specializzazione colturale e verso forme più razionali di produzione per il
mercato. Anche nell’Italia nel dopoguerra si svilupparono forme d’agricoltura
rivolte per più del 50% alla commercializzazione. L’agricoltura di mercato si
caratterizza proprio per l’esistenza del settore agricolo e del settore
commerciale. La parte di produzione destinata all’autoconsumo si riduce mano a
mano che l’impresa si apre al commercio. Le colture subiscono una variazione e
s’indirizzano verso quelle annuali facilmente riconvertibili. Anche nei paesi
socialisti ci si preoccupava della destinazione e dello sbocco dei prodotti
(cfr. par 2.3.)
3.
L’agricoltura di speculazione. Già presente nel XIX sec., le aziende che praticano
tale forma di agricoltura basano i loro obiettivi sul controllo del mercato
(Grillotti, 1992). In un sistema ad agricoltura di speculazione, non è più il
mercato ad orientare le scelte produttive, ma la scelta monocolturale, sulla
quale sono stati investiti ingenti capitali, a condizionare la domanda e i
consumi. Sono aziende dove terra e lavoro hanno costi molto bassi e,
paradossalmente, come nell’agricoltura di sussistenza monocolturale,
concentrano tutte le risorse su un singolo prodotto, il che le rende molto
fragili. Come tutte le monoculture, l’agricoltura di speculazione ha un forte
impatto ambientale, favorendo la desertificazione (un po’ come le primitive forme
d’agricoltura itinerante). Non sono i fattori fisici a penalizzare l’azienda,
che è sempre pronta ad investire in nuovi terreni fertili, ma il rallentamento
dei consumi, che la obbliga a delicate operazioni di stoccaggio o di marketing,
pena il crollo dei prezzi (Grillotti, 1992).
4.
I
sistemi agro-industriali. La caratteristica è la stretta
connessione tra agricoltura e industria definite e coordinate nell’ambito di un
unico gruppo societario. Si cerca di controllare verticalmente l’intero ciclo
di lavorazione. L’industria domina tutto il processo perché fornisce ai
coltivatori gli input (sementi, macchinari, fertilizzanti, pesticidi) e
assorbe gli output, cioè il raccolto. La produzione, concentrata
orizzontalmente, è collocabile sul mercato anche grazie alla concertazione di
numerosi settori: trasporti, commerciale, editoriale, pubblicitario, riuniti
nello stesso gruppo. Anche il sistema agro-industriale
si basa sulla monocoltura, che viene, tuttavia, diversificata sul territorio.
La terra che sfruttano, a differenza dell’agricoltura di speculazione, diventa
un bene da conservare (Grillotti, 1992)
Per ultimo è interessante precisare che
le aziende a conduzione e proprietà familiare sono quelle che hanno la
produttività della terra più alta, cioè, in altri termini, sono in grado di
sfruttare in maniera più redditizia e di ottenere risultati migliori dalla
medesima superficie di terreno. Tuttavia sono le grandi piantagioni, guidate da
multinazionali, ad ottenere la migliore produttività del lavoro, anche grazie
alla pressione economica e politica esercitata sui governi e alle comunità
locali.
3. TRANSIZIONE DALL’AGRICOLTURA
TRADIZIONALE A QUELLA MODERNA. L’IMPATTO SULL’AMBIENTE
3.1. Agricoltura tradizionale e moderna
3.1.1. L’aiuto della geografia
In questi primi due capitoli abbiamo analizzato come si è
evoluta l’agricoltura, almeno fino agli anni ’70. Fatta esclusione per l’ultimo paragrafo (2.4.), molte fonti e riferimenti
sono precedenti agli anni ’70, per rendere evidenti le forme d’agricoltura
tradizionale presenti all’epoca, visto che poi esse hanno cominciato a perdere
quel carattere territoriale espresso in precedenza. A quel tempo a mio avviso,
le forme di agricoltura tradizionale, hanno raggiunto una completezza
quantitativa massima. Talvolta le considerazioni di questi capitoli si
riferiscono a dati del 1950. Inoltre, la scelta di riferimenti geografici
evidenzia l’evoluzione dell’agricoltura tradizionale nei suoi molteplici
aspetti.
L’ausilio della geografia, nell’analisi
dell’agricoltura, è stato molto utile per mettere in evidenza la complessità e
la territorialità delle differenti forme di agricoltura tradizionale, e la
completezza del “sistema agricolo tradizionale mondiale”. Un’analisi in
equilibrio tra una geografia determinista e possibilista, proprio perché
l’agricoltura rappresenta il punto d’incontro, nel tempo e nello spazio, tra
uomo e natura; in particolare l’agricoltura tradizionale. Un rapporto, quello
tra uomo e natura, né causale, né casuale, ma interdipendente e coerente con le
scelte che quel gruppo umano ha operato in quel determinato frangente
spazio-temporale.
Con la geografia determinista tali
scelte sono state predefinite dalla natura, per l’agricoltura tradizionale
(determinismo ambientalista) o dall’economia, per l’agricoltura moderna
(determinismo funzionalista).
Con la geografia possibilista, invece,
si considerano le scelte dell’uomo, non come predefinite, ma coerenti con la
realtà storica, realtà che per l’agricoltura tradizionale si limitava agli
aspetti naturali, ambientali e culturali, ma che per l’agricoltura moderna si è
arricchita degli aspetti economici, tecnologici, politici ed etici.
Dunque, l’agricoltura si è evoluta in
equilibrio tra possibilismo e determinismo. Ancora all’inizio del XX secolo
l’attività agricola era pesantemente condizionata dai caratteri dell’ambiente
naturale, quindi la geografia si limitava ad individuare limiti e potenzialità
delle colture e delle componenti fisiche del territorio. Nella seconda metà del
XX secolo lo sviluppo dell’agricoltura moderna, ha ridotto i vincoli ed i
condizionamenti naturali, permettendo di coltivare al di là delle condizioni
morfologiche, climatiche e della stessa disponibilità di suolo agricolo
(Grillotti, 1992).
Si parlò allora di “rivoluzione verde” e
l’uomo in quel momento credeva veramente di poter estendere il suo dominio
agricolo sull’intero pianeta, superando ogni carenza o problema di carattere
alimentare. A tal fine sembrò più opportuno concentrare l’analisi e le
decisioni sui settori secondario e terziario (chimica di sintesi,
commercializzazione, meccanica, biologia, ecc.), piuttosto che sugli esiti che
tali interventi provocavano sulle campagne; dall’ambiente naturale l’attenzione
si è spostata agli strumenti tecnologici, scientifici ed economici.
3.1.2. Tradizione, diversificazione e territorialità.
Sin dalla notte dei tempi le forme
d’agricoltura non hanno cessato di differenziarsi, d’intrecciarsi,
d’interagire, di specializzarsi, di evolversi ed è nel secolo scorso che si è
avuta la massima estensione delle forme d’agricoltura tradizionale.
Riprendendo l’ipotesi posta nel
paragrafo 1.1., avevamo scelto il rombo come forma geometrica che meglio
rappresenta graficamente l’evoluzione dell’agricoltura da un punto di vista
tecnico-organizzativo. Alle origini l’agricoltura contava poche forme
distintive (vertice del rombo), poi nel tempo, esse si sono moltiplicate e
siamo arrivati nel secolo scorso alla massima estensione (segmento di massima
estensione del rombo), successivamente secondo il Kostrovicki (1980) le forme agricole sono destinate a ridursi a poche forme
realmente distintive. In realtà vorrei fare una
precisazione e cioè che questo è vero per le forme di agricoltura tradizionale,
ma non per le forme di agricoltura in generale (v. sotto).
L’agricoltura tradizionale è il
risultato d’innumerevoli aggiustamenti da parte dell’uomo, nel tentativo di
trovare la forma d’agricoltura più consona (cfr cap 1) ad un determinato tipo
di società e di ambiente (oltre che il rapporto giuridico migliore per ogni caso
concreto, cfr cap 2). Ma se è vero che adesso siamo
nella fase regressiva del rombo, cioè in una fase nella quale le forme
d’agricoltura tradizionale si stanno riducendo di numero, non è altrettanto
vero che l’agricoltura stia riducendo la sua varietà. Si riducono le forme d’agricoltura tradizionale, ma non le forme
d’agricoltura.
La novità di questi ultimi anni è che la
diversità agricola sta avanzando su un piano diverso. Se prima la diversità
agricola si evidenziava in scala locale, nella quale ogni forma tradizionale
rispondeva a quel principio di territorialità espresso in precedenza (cfr. par.
1.1.), oggi e sempre di più la diversità si esprime su un piano globale,
giacché le forme d’agricoltura tradizionale hanno perso una buona parte della
spinta evolutiva che avevano fino agli anni 50. È un gioco di scala nel quale
globale e locale interagiscono tra loro diversificando ulteriormente le forme
di agricoltura. Immaginiamoci una matrice dove s’intrecciano da una parte le
varie forme d’agricoltura tradizionale e dall’altra le nuove forme
d’agricoltura moderna. Modernità e tradizione, in agricoltura, s’intrecciano
ulteriormente, talvolta si scontrano, ma sicuramente creano i presupposti per
una sinergia tra passato e futuro.
La tradizione è un qualcosa che procede in
maniera autonoma, attraverso la quotidianità, dove conoscenza e pratica sono un
tutt’uno. Attraverso la trasmissione, molto spesso orale o semplicemente
dell’esempio pratico, la tradizione si affina e si trasferisce nel tempo, di
generazione in generazione. È un delicato equilibrio, attraverso la
quotidianità, fatto di prove ripetute, errori, fallimenti e di successi che nel
tempo perfezionano la tradizione. La tradizione, in particolare la tradizione
agricola, diviene il vettore temporale per la trasmissione d’esperienze
memorizzate e accumulate, con l’obiettivo di accumulare sempre maggiori
garanzie di sopravvivenza, attraverso la conoscenza e la pratica. Nel suolo
agricolo interagiscono tre logiche diverse (v. Introduzione): biologica, ecologica
e antropologica, cosicché la tradizione è il messaggero nel tempo dell’incontro
di queste tre dimensioni. Talvolta, bastava un cambiamento climatico (mutamento
ecologico) per rendere una determinata forma d’agricoltura tradizionale
inefficace; la pratica, fino allora coronata di successo, poteva entrare in
crisi. Oppure un cambiamento politico (mutamento antropologico) metteva fuori
gioco altre forme d’agricoltura, si pensi all’enclosures per il sistema infield-outfield.
La quotidianità diveniva tragica
perché gli usi e le tradizioni non davano più i risultati sperati, fino allora,
dati per scontati. I cambiamenti repentini di
quell’equilibrio descritto poco sopra (biologico, ecologico e antropologico),
obbligavano la tradizione agricola ad un violento adattamento, che avveniva
spesso nel lungo periodo, o ad una vera è propria rottura con il passato. La
tradizione difficilmente e con molta rigidità si adatta all’imprevisto, proprio
a causa della territorialità che la lega così fortemente ad un ben determinato
territorio, limitando al minimo gli scambi extra-territoriali (Raffestin,
Bresso, 1982).
Con l’avvento dell’agricoltura moderna
si è avuta una de-territorializzazione delle forme d’agricoltura. In maniera
generale, essa è adattabile a qualsiasi territorio e s’inserisce
nell’equilibrio ecologico, biologico e antropologico non più (e non solo)
tramite il rigoroso rispetto delle tradizioni, ma (anche) secondo logiche
legate al futuro e non più al passato. La modernità vede la definitiva
scissione della pratica dalla conoscenza. Sempre più spesso l’evoluzione
dell’agricoltura avviene nei laboratori o nelle università, mentre la pratica
rimane nelle mani dei contadini. Si cercano delle teorie applicabili al maggior
numero possibile di casi concreti e di territori agricoli, teorie il più
possibile standardizzabili e meccanizzabili, il più possibile vendibili e
accessibili al numero più elevato di coltivatori. Le forme agricole moderne
sono libere dalla territorialità e per questo più flessibili.
La deterritorializzazione tiene conto
dello spazio in maniera conforme alle leggi dell’economia. L’apertura crescente
dell’agricoltura ai mercati, iniziata in Europa centro-settentrionale già dal
XIX sec, riorganizza il territorio agricolo in relazione della vicininanza del
centro urbano (mercato di sbocco). Già nel 1826 von Thünen (Tinacci, 1990)
individuò un modello, con il quale evidenziò che le coltivazioni si disponevano
in cerchi concentrici distanziati dal mercato centrale in ragione delle
tecniche di produzione e della composizione della domanda. Questo modello,
applicabile ad ogni territorio, ci da un idea di quanto le dinamiche economiche
deterritorializzino un sistema agricolo tradizionale.
3.1.3. Modernità, omologazione e de-territorializzazione.
La modernità segna la definitiva
divisione tra conoscenza e pratica (Raffestin, Bresso, 1983). Con l’avvento
dell’agricoltura moderna, la conoscenza esce dai campi coltivati ed entra nei
laboratori, omologandosi e deterritorializzandosi. In quale
epoca situare questo cambiamento? Difficile
dirlo con certezza, poiché le variabili non sono soltanto temporali, ma anche
spaziali. In alcuni paesi la scissione tra
conoscenza e pratica si è avuta subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. La
rivoluzione verde vide la nascita dell’agricoltura moderna. Quel periodo segnò
l’inizio della meccanizzazione e del consumo di massa di pesticidi e di concimi
chimici, oltre che l’aumento della produttività. Nuove discipline, fino allora
estranee all’agricoltura, cominciarono a fornire preziosi aiuti alla conoscenza
agricola. La chimica, la biologia, l’agronomia, l’economia s’inserirono nel
processo di produzione agricolo in maniera sistematica, sostituendosi al ruolo
attivo svolto fino allora dalla tradizione.
Se la conoscenza agricola in buona parte
del mondo, si è dissociata dalle tradizioni, l’agricoltura mantiene nella
pratica talvolta degli usi antichi di secoli. In altri termini la conoscenza
non ha più bisogno d’essere territorializzata, perché molto spesso risponde a
dei modelli matematici valevoli per tutti gli ambienti, tuttavia la pratica
mantiene ancora vivo il suo rapporto con un determinato territorio a causa
della complessità del sistema.
Per essere più chiaro, è indubbio che
per la sintesi di un pesticida o per la riproduzione d’insetti predatori, non
serve né riferirsi a quel determinato ambiente né riferirsi alle tradizioni,
mentre per praticare quel determinato tipo di sovescio o scegliere la data
migliore per la semina potrebbe risultare molto utile riferirsi alle tradizioni,
alla territorialità o al calendario lunare.
La tradizione non è il contrario della
modernità, ma è semplicemente una tappa per arrivare a quest’ultima, attraverso
la scissione che abbiamo visto poco sopra. Per aiutarci a capire, potremo
vedere la differenza tra due casi estremi:
·
Agricoltura
tradizionale pura. Che ha una produttività del
lavoro bassa (pensiamo per esempio alle forme di agricoltura discontinua a
maggese), un impatto sull’ambiente relativamente modesto e una stabilità nel
tempo maggiore.
·
Agricoltura
moderna pura. Nella quale la produttività del
lavoro è elevata, ma (pensiamo alle grandi piantagioni ad agricoltura intensiva
e di mercato) la stabilità nel tempo è ridotta e ci sarà un elevato impatto
ambientale.
Per questo, in agricoltura, modernità e
tradizione sono in un rapporto di complementarità, talvolta sinergico. I
risultati migliori da un punto di vista di efficienza sociale (cfr. par 4.4.2.)
si hanno dove l’agricoltura moderna si è inserita in maniera complementare
all’agricoltura tradizionale; è il caso dell’agricoltura biologica, nella quale
la modernità (conoscenza) si sposa con le tradizioni (pratica).
3.1.4. Interazione tra modernità e tradizione in agricoltura: il
caso Italiano
Considerando l’agricoltura
convenzionale, si assiste molto spesso ad un’invasione, con relativa estinzione
delle forme d’agricoltura tradizionale, come nel caso delle grandi piantagioni
di proprietà di società di capitali, che s’inseriscono nel territorio in
maniera talvolta prepotente, con un’agricoltura di speculazione. Generalmente si adopera un’agricoltura standardizzata che
non tiene praticamente conto delle condizioni locali, della territorialità. In
alcuni casi tuttavia, là dove le tradizioni sono forti e dove generalmente è
presente la piccola proprietà individuale o cooperativa, l’agricoltura
convenzionale non ha fatto che diversificare maggiormente l’agricoltura. Tale
diversificazione è avvenuta in misura del diverso utilizzo della modernità.
Modernità espressa in termini d’utilizzo di pesticidi, concimi chimici,
macchinari, cosicché ci sono state una serie abbastanza completa di sfumature
tra agricoltura tradizionale e agricoltura moderna. Se prendiamo il caso
dell’Italia, notiamo delle zone dove, salvo un’utilizzazione maggiore di
macchinari, l’agricoltura tradizionale ha mantenuto la sua integrità. Il caso
dell’Italia è emblematico, a causa della sua struttura socio-economica, e ci
permetterà di illustrare alcune combinazioni fra tradizione e modernità. Il
processo di sviluppo che ha conosciuto l’Italia, molto rapido in certe regioni
e relativamente lento in altre, ha determinato la compenetrazione e la
diversificazione tra agricoltura tradizionale e moderna. L’importanza dei
rilievi montuosi dell’Arco Alpino e l’asprezza di quelli Appenninici si erano
piegate dinanzi alla tenace insistenza dei coltivatori, attraverso
terrazzamenti, bonifiche e opere idrauliche. Nel passato la superficie
coltivabile è stata allargata grazie alla fame di terra e grazie al
latifondismo storico (Grillotti, 2000).
Il brillante sviluppo del settore
industriale negli anni Settanta ha messo in ombra la solida tradizione agricola
ancora oggi impressa nelle forme del paesaggio rurale.
L’articolazione regionale dei sistemi
agricoli italiani esprime i contrasti che oggi vive il nostro paese nel settore
primario. Col passare del tempo questa dicotomia ha creato una serie ben
completa di sfumature tra un’agricoltura competitiva, che punta sulla quantità
e l’altra elitaria, impegnata nel recupero di modelli e prodotti tradizionali
di qualità. Questa dicotomia prende come rispettivi modelli di riferimento
quello nord-atlantico e quello mediterraneo (Grillotti, 2000):
·
il primo, più
forte (ma anche più fragile), fonda sull’aumento della produzione e sulla
massimizzazione dei profitti le scelte colturali e produttive, come pure il
rapporto con gli altri settori produttivi (commerciale e industriale).
·
Il secondo,
minoritario (ma ben radicato) include la componente estetica, ludica ed
ecologica dell’agricoltura della quale scopre anche nuove funzioni (turismo,
salvaguardia dell’ambiente e salute).
Dunque le trasformazioni dei sistemi
agricoli italiani negli ultimi decenni sono il risultato di tendenze evolutive
contrapposte. Negli spazi agricoli ad elevata densità colturale si possono
trovare contemporaneamente due tipi estremi d’agricoltura, quella intensiva
(arboricoltura e orticoltura specializzate), praticata in genere dalle aziende
medio-piccole e quella estensiva, generalmente adottata dalle imprese di più
grandi dimensioni. La presenza della grande o della piccola azienda non
costituisce un indicatore esaustivo di produttività o di sviluppo agricolo. Per
esempio l’adozione d’ordinamenti colturali intensivi non è maggioritaria nella
fascia centrale della Pianura Padana, tra Lombardia ed Emilia Romagna. Mentre
l’intensità delle coltivazioni (PLV/SAC, cfr. par 2.4.2.) nelle province
italiane sottolinea quanto essa si elevi nelle province in cui è più ridotta la
disponibilità di terra coltivabile, tanto da essere stata suddivisa in aziende
di dimensioni medio-piccole (Imperia, Genova, Bolzano, Trieste, Pistoia e
Napoli) e daidentificarsi spesso con l’orticoltura, la floricoltura, il
vivaismo e l’arboricoltura specializzata (Grillotti, 2000).
Nonostante l’aumento del numero e della
dimensione delle grandi aziende, si assiste ad un sensibile indebolimento
dell’intensità produttiva, a causa della scelta di pratiche monocolturali
annuali. Dall’altro lato l’accentuarsi della già elevata intensità colturale da
parte d’aziende medio-piccole, anche in presenza di elevate densità
demografiche, abitative e colturali (Napoli), sottolinea le contraddizioni e
allo stesso tempo le infinite sfumature della realtà agricola italiana.
Sfumature o contraddizioni che nascono da una dicotomia storica, originaria,
che si trasmette anche all’agricoltura (tradizionale e moderna). Da una parte
sta la tendenza alla valorizzazione e al rafforzamento di storiche attività
colturali di pregio e qualità (viticoltura, olivicoltura, ecc.) e dall’altra il
confronto col mercato internazionale o la tendenza verso uno sfruttamento
agricolo di tipo nord-atlantico, che abbatte costi d’esercizio e affronta la
competitività commerciale sul piano quantitativo. L’Italia agricola sembra
proprio il teatro di una diversificazione dalle infinte combinazioni di questi
due modelli, nei quali quantità e qualità, regionale e internazionale,
valorizzazione territoriale e produzione competitiva interagiscono tra loro,
partecipando a rendere ancora più solida e complessa la nostra realtà (Grillotti,
2000).
Si potrebbe ancora scrivere a lungo
sulla tradizione e sulla modernità, ma mille parole non potrebbero mai
eguagliare la degustazione di uno dei nostri vini, nei quali il tempo si sposa
con l’ambiente e la cultura, nei quali tradizione e modernità si sposano in una
sinergia di aromi e profumi che allietano le altrettanto prelibate vivande.
3.2. Agricoltura e ambiente culturale
L’agricoltura si è sviluppata
e si è evoluta seguendo e interagendo con la realtà umana, in un rapporto di
stretta collaborazione: dai tempi della raccolta, nei quali l’uomo provvedeva
ai suoi bisogni alimentari sfruttando direttamente ciò che la natura produceva
spontaneamente, fino alla scoperta dell’agricoltura, con la quale l’uomo riuscì
a capitalizzare una ricchezza attraverso la tecnica e la filosofia agricola. Tale ricchezza è chiamata anche “surplus
agricolo”. L’uomo scoprì che
facendo interagire il proprio lavoro, quello degli animali e quello della
natura otteneva un risultato che, oltre a sfamare lui e gli animali, gli
forniva un’eccedenza. Un’eccedenza che poi imparò a vendere e a
commercializzare.
La scoperta dell’agricoltura
fu un passo fondamentale della vita dell’uomo sulla terra, una scoperta
inevitabile, ma necessaria a compiere quel salto di qualità che gli permise di
non essere più simile ed un animale che si ciba di caccia e raccolta; gli
permise di intraprendere la strada per diventare essere umano.
La scoperta dell’agricoltura,
infatti, portò con sé un aumento demografico importante, oltre che il passaggio
dal nomadismo alla sedentarietà. Con questa rivoluzione cambiarono le
abitudini, si formarono i primi villaggi e soprattutto, si fu costretti a porre
attenzione al tempo, a calcolarlo, a misurarlo. La scoperta dell’agricoltura,
inoltre, influenzò notevolmente la religione[3].
Da un punto di vista culturale si assistette all’introduzione di un elemento
nuovo come la sessualità e ad un aumento d’importanza crescente di elementi
come la fecondità, la fertilità, i miti legati alla comparsa d’ogni cereale e i
rituali (magici, culturali e religiosi) necessari per avere un raccolto
propizio.
Alla rivoluzione agricola
seguì un inarrestabile processo di diversificazione delle forme d’agricoltura
(cfr. cap 1.). Ogni popolo, nel tempo, ha adattato la propria filosofia
agricola in ragione del clima, del terreno della regione che abitava e della
cultura che aveva. Erich Otremba, un geografo dell'agricoltura, affermava che
“non è possibile considerare il paesaggio agricolo separatamente dal paesaggio
culturale” (in Kostrowicki, 1980). Con la dovuta cautela, aggiungerei, che
considerare il paesaggio agricolo (saperlo leggere e interpretare) aiuterebbe a
conoscere meglio il paesaggio culturale ed economico e potrebbe essere
un’ulteriore chiave di lettura per capire la società d’oggi.
Se diamo un’occhiata alle
diverse impostazioni che l’agricoltura ha assunto nel mondo, vediamo che ci
sono dei punti nel Pianeta, nei quali l’assetto sociale e l’equilibrio
ecologico sono precari o altre zone nelle quali il surplus agricolo è
più che annullato dalle esternalità negative e nelle quali le conseguenze di
tale perdita di equilibrio si fanno sentire anche nei territori confinanti,
talvolta nell’intera antroposfera. Ma ci sono altri territori nei quali tale
equilibrio si è mantenuto e si sta mantenendo, non soltanto per un fatto di
tradizione, ma anche per un fatto di equilibri e di armonia di quel triplice
rapporto (cfr. introduzione e par. 3.1.2.) tra tre differenti logiche:
biologica, ecologica e antropologica.
3.2.1. Un’ipotesi intrigante
Per quanto mi riguarda ho
notato una certa simmetria con la musica, “ogni popolo ha la sua musica, cosi
come ogni popolo ha la sua agricoltura”. Potrebbe sembrare una frase un po'
azzardata, magari senza senso e soprattutto che non ci porta lontano, ma
cercherò di spiegarmi.
La musica caratterizza ogni
popolo, essa è il risultato di un perfezionamento avvenuto nel tempo, che in un
attimo ci consente di “ascoltare la territorialità” di ogni musica
tradizionale, vivere quella determinata cultura. In essa c’è l’incontro della
componente umana con quella territoriale. Gli strumenti musicali utilizzati
sono spesso legati ad una ben determinata regione e quindi territorializzati.
Con la deterritorializzazione
della musica, pensiamo ai canti nei campi di lavoro degli schiavi d’America, la
componente umana, costituita dalle tradizioni ritmiche degli schiavi che
venivano dall’Africa e la componente ambientale, costituita dall’incontro con
altre culture (deterritorializzazione), dette vita al Blues oppure al Jazz,
nato dall’incontro della componente ritmica dell’Africa con quella armonica
europea.
La deterritorializzazione è
avvenuta all’interno della componente armonica europea, in quanto nella musica
occidentale per far tornare le armonie di differenti tonalità, si sono dovute
“temperare” le note, in pratica abbiamo aggiustato matematicamente gli
intervalli nelle scale, cosi da poter creare tutta una serie di combinazioni
che poi hanno sviluppato la musica occidentale che conosciamo. Quelli che erano
degli intervalli naturali con precisi rapporti di frequenza, sono stati
alterati (se pur minimamente) per permettere un rigore logico perfetto tra le
varie 12 tonalità. Le musiche tradizionali del resto del mondo invece, sono
rimaste su scale naturali, impossibili da suonare con strumenti temperati,
salvo un’alterazione delle armonie.
Con il temperamento della
scala si è involontariamente trovato un linguaggio comune a tutte le diverse
musiche presenti sulla terra, un linguaggio parziale ma comune, in grado di
“leggere” le differenti culture. Il pianoforte non sarebbe mai potuto essere inventato se non fosse stato
per la scala temperata, cosiccome il sintetizzatore. Le ragioni del temperamento sono due :
- la
possibilità di avere 12 tonalità che tornino sotto un rigore logico, cioè
dopo 12 intervalli di quinta (sette semi toni x 12= 42 toni) si ritrova la
stessa tonalità, mentre prima ciò non avveniva;
- la
possibilità di ricondurre tutte le molteplici scale presenti nelle musiche
tradizionali ad una di riferimento, la scala maggiore.
Successivamente ci fu la diffusione
degli strumenti temperati (pianoforte, chitarra moderna, sax) e quindi anche di
quelli sintetici, che hanno in parte sostituito gli strumenti tradizionali.
In agricoltura è avvenuto un
processo similare: quando l’agricoltura moderna è entrata sulla scena, si è
avuto un “linguaggio agricolo” comune, un linguaggio talvolta dai toni
arroganti e imperialisti, come è il caso di certe musiche lanciate per il solo
scopo commerciale, ma potenzialmente capace d’interpretare le diverse realtà
presenti sulla terra, di misurarle, di globalizzarle e d’inglobarle.
Questo non è un processo contro
l'agricoltura convenzionale, ma semplicemente un tentativo di capirla alla luce
della cultura nella quale si è diffusa. Con la scala temperata in musica c’è
stata una deterritorializzazione della musica tradizionale. Se prestassimo un
po’ più d’attenzione nell’ascoltare la musica etnica o tradizionale, noteremmo
che talvolta essa viene suonata con strumenti sintetici (sintetizzatori,
ascillatori e filtri), sono rari i pezzi commerciali di musica tradizionale nei
quali non si trovano i sintetizzatori. Questa è una semplice constatazione per
avere un’idea di quello che sintetico e modernità rappresentano in musica.
Anche in agricoltura sintetico e modernità hanno rivoluzionato i modelli
tradizionali.
Nell’agricoltura moderna, attraverso
una semplificazione della percezione della realtà, si è cercato di trovare un
modello su cui poter massimizzare la produzione e aumentare il benessere. Si è
trovato un modello il più standard e uniforme possibile che potesse permettere
la massimizzazione della produzione e del benessere. In agricoltura, la scoperta e l'utilizzo dei
prodotti sintetici e dei macchinari più svariati generò un notevole amunento di
benessere, analogamente in musica, il temperamento degli intervalli nelle scale
ha permesso un’esplosione di nuove e favolose melodie e possibilità armoniche
fino allora impossibili da realizzare (Rock, Folk, Soul, Funk, Rap, ecc...) e
la possiblità di registrazione dei suoni favorendone l’ascolto (potenzialmente)
per le generazioni presenti e future.
Tali aumenti di benessere di notevole
entità inizialmente, si sono ridotti col tempo, soprattutto alla luce del fatto
che l'agricoltura influisce notevolmente con l'ambiente. Mi chiedo se anche per
la musica sia avvenuto la stessa cosa!
3.3. Agricoltura e ambiente fisico
3.3.1. I prodotti sintetici
Niente può essere più comune dei
prodotti sintetici. Essi hanno trasformato così radicalmente il nostro
paesaggio domestico e urbano che non ci rendiamo più conto della loro presenza.
Ogni cosa che ci circonda, del nostro mondo costruito, ha a che fare con dei
prodotti sintetici: i film che vediamo al cinema o la musica che ascoltiamo
sono registrati con l’uso di materiali sintetici, la porta del nostro bagno
sarà ricoperta da solventi e vernici sintetiche, la maglietta che indossate, se
anche non fosse di poliestere, sarà fatta di cotone trattato con pesticidi e
anche la rivoluzione informatica, quindi anche Internet, è stata preceduta da
una rivoluzione nella produzione chimica di sintesi, senza parlare dei farmaci
e dei materiali medici.
La scoperta della tecnologia della
chimica di sintesi ha origine nella metà del 19° secolo, con la creazione dei
primi prodotti organici di sintesi come anestetizzanti e disinfettanti (un
prodotto organico è un prodotto
che contiene nella sua composizione chimica del carbonio). Il DDT, il più famoso pesticida del
mondo, fu sintetizzato per la prima volta nel 1874 da un chimico tedesco, ma
non venne impiegato fino al 1939. La prima materia plastica fu sintetizzata
dalla cellulosa negli anni 90 del 19° secolo (Mc Ginn, 2000) . Ma la vera
rivoluzione avvenne nel 1900, quando si cominciò ad usare come materia prima il
petrolio, che commercialmente sostituì la canapa indiana (più ecologica), che
divenne illegale. Il petrolio consentiva la sintesi di prodotti chimici a
prezzi più economici dei prodotti tradizionali, come legno, gomma, metalli,
vetro e fibre vegetali. Il vinile da un punto di vista commerciale sostituì la
gomma naturale.
Nonostante il suo straordinario
successo, il settore della chimica di sintesi è sempre stato un’industria
misteriosa, che se da un lato è stata utile all’uomo dall’altro ha creato non
pochi disastri: prima si produce, poi ci si chiede quale sia l’impatto sulla
natura, quindi sull’uomo.
Nel 2001, un trattato elenca i 12
prodotti di sintesi più pericolosi al mondo; nove di essi sono pesticidi e
erbicidi: il DDT, l’aldrin, il mirex, l’endrin, il dieldrin,
l’heptachlor, il chlordane, l'hexacloro-benzene, il texaphene.
Chiamati anche POP (persistent
organic pollutants), alcuni di essi sono già stati banditi da alcuni paesi,
ma l’UNEP (Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite) si è proposta di eliminarli
in tutti i paesi. Altri studi stimano che in realtà i POP sarebbero centinaia e
anche migliaia. La definizione del termine POP (non troppo diversa dalla musica
POP, anch’essa presente un po’ in tutto il mondo, cfr. 3.2.) è la seguente:
- P, nel senso di persistente, molto stabile esso rimane nella natura per
decenni, è soggetto a bioaccumulazione (un processo ecologico di
concentrazione nei tessuti degli essere viventi). Da 2,7 a 22,9 anni per
HCB, 10-15 per il DDT, endrine 12 anni, mirex 10 anni[4], quanto basta per dare un’idea.
- O, nel senso di organico, cioè composto da molecole di ossigeno,
idrogeno, carbonio, tuttavia con l’aggiunta generalmente del cloro.
- P, nel senso di forte inquinante proprio per la sua caratteristica di
bioaccumulazione e liposolubilità, che può causare danni a lungo termine,
cronici, ormonali, immunologici e cancerogeni.
3.3.2. I pesticidi
Nel 1935 (prima della rivoluzione
verde), prima che l’agricoltura fosse sconvolta dalla seconda guerra mondiale,
la produzione cerealicola era di 650 milioni di tonnellate, alcune stime ci
dicono che sarebbe stata circa 30 % più elevata se non fosse stato per le
malattie, gli insetti infestanti, i parassiti, le erbacce, i roditori, gli
uccelli, ecc…Oggi nel mondo sono usati 2,5 milioni di tonnellate di pesticidi
l’anno (Mc Ginn, 2000), il che ci fa
pensare che l’agricoltura moderna, quella convenzionale sia semplicemente
“drogata”.
Nel 1939, il chimico Svizzero Paul
Müller, scoprì che il diclorodifenil-tricloroetano, in arte DDT, poteva essere
utilizzato in agricoltura come pesticida. Vinse il premio Nobel per la sua
scoperta nel 1948. Durante la guerra, il DDT fu usato per combattere i
pidocchi, successivamente divenne il più usato pesticida in Europa, in America
settentrionale e successivamente nel resto del mondo. Culturalmente fu un
cambiamento importante poichè l’uomo pensò di essere diventato in grado
risolvere i suoi problemi con i parassiti, che fin dalla notte dei tempi lo
infestavano e non solo in agricoltura!
Il DDT fu seguito da altri pesticidi
della stessa famiglia (Mc Ginn, 2000):
- Nel 1945 entrò sul mercato il chlordane come potente erbicida e l’hexachloro-benzene o HCB venne introdotto come fungicida;
- Nel 1948
l’heptachlor, un componente del Chlordane, venne introdotto ed era quattro
volte più tossico e nello stesso anno il toxaphene divenne il pesticida migliore per il
cotone e per il bagno degli animali;
- Tra
il 1948 e il 1951 altri tre insetticidi arrivarono sul mercato: l’aldrin,
il dieldrin e l’endrin, nell’ordine di cinque fino a centinaia di volte
più tossici del DDT, in ragione dell’organismo considerato. Il loro
obiettivo non era soltanto l’eliminazione degli insetti, ma anche
roditori, storni e altri uccelli e mammiferi;
- Il
1951 fu l’anno del mirex, usato contro i roditori, ma anche come
ritardante negli incendi. Il suo momento di gloria arrivò nel 1967, quando
un’infestazione di formiche rosse colpì il sud-est degli USA. Ciò obbligò
le autorità locali ad un accurato programma di spruzzo aereo di 510.000
km³. Il mirex è uno dei più persistenti e stabili che ci sia.
Nel 2001, un trattato
dell’UNEP (programma per l’ambiente dell’ONU), conosciuto ufficialmente come: “The International Legally Binding
Instrument for Implementing International Action on Certain Persistent Organic
Pollutant”, individua 12 POP tra i quali nove sono proprio i pesticidi
trattati qui sopra. Gli altri
tre sono i PCBs, la diossina (presente tuttavia in alcuni polli), e i furani.
Questi nove sono l’essenza dei POP, estremamente persistenti, bioaccumulabili,
mobili e altamente tossici. Tutti vietati ufficialmente in almeno 60 paesi,
tranne il DDT ancora usato per disinfestare le zanzare della malaria, ma
vietato in agricoltura.
Nonostante ciò, essi fanno
ancora parte del nostro mondo (circa sette milioni di tonnellate per sei di
loro) e ne fanno parte in modo globale, visto che ce n’è traccia nella
corteccia degli alberi di un po’ tutto il mondo (DDT, chlordane e dieldrin),
oltre che nell’uomo. Il DDT rimane uno dei più comuni pesticidi che si trovano nel
latte materno.
Fino al 1962, l’opinione
pubblica andava nella stessa direzione dell’interesse economico delle industrie
chimiche e di quelle alimentari, si pensava che il nemico fosse la natura
stessa, con i suoi numerosi infestatori ed era logico combattere tutti gli
animali che limitavano e parassitavano il raccolto con qualsiasi arma. Nel
1962, un famoso libro, Silent Spring (CARSON, 1962), svela l’altra faccia della medaglia: “Gli interessi della
produzione alimentare sono da bilanciare con altri interessi come la salute,
l’acqua potabile e le possibilità ricreative”. Un libro rappresentativo che
denuncia gli orrori commessi dai composti chimici utilizzati in agricoltura.
Esso diventa un punto di riferimento per molte persone che cominciano a rendersi
conto degli effetti collaterali e indesiderati di queste sostanze.
Le industrie chimiche si
sforzarono di cambiare rotta, inventando nuovi prodotti meno tossici; in
pratica però, esse ripresentarono dei prodotti simili con l’aggiunta d’elementi
di zolfo o fosforo, il che in sostanza cambiò il pelo, ma non il vizio dei
pesticidi. Il Methosychlor e il dicofol sono molto simili al DDT,
alcuni organofosfati sfuggiti all’utilizzo durante la guerra come armi chimiche
vennero riciclati come pesticidi: chlorpyrifos, diazinol, malathion
e il parathion. Essi non sono classificati come POP, in quanto non molto
persistenti, ma tendono ad essere acutamente tossici. I contadini esposti a
queste sostanze possono sviluppare seri problemi neurologici (Global Pesticide Campaign, 1999). Gli organofosfati hanno avuto un enorme
successo economico: negli USA essi rappresentano circa la metà di tutti gli
insetticidi usati. Questo dato si può riscontrare anche nella frutta e nella
verdura in vendita nei supermercati (USA), che spesso eccede il limite di
sicurezza indicato dall’EPA (agenzia per la protezione dell’ambiente in USA)
per i bambini (Kaplan, Morris, 2000). In Giugno 2000, l’Accademia Nazionale
delle Scienze stimava che il 25 % dei problemi dello sviluppo e del comportamento
dell’infanzia negli Stati Uniti fosse causato dalla combinazione di fattori
genetici e dall’esposizione a sostanze chimiche, neurotossiche, inclusi il
piombo, i PCB e gli organofosfati (Groth, Benbrook, Lutz
Karen, 1998).
In risposta a ciò, l’EPA sta riesaminando
diverse decine di organofosfati sul mercato e in luglio 2000 l’agenzia ha
annunciato il piano di eliminazione di alcuni di essi, tra cui il famoso chlorpyrofos,
un ingrediente attivo nel Dursban
(provate a cliccarlo su Internet su qualche motore di ricerca!). Anche in altri
paesi come Gran Bretagna, Argentina, Indonesia e Filippine sono stati banditi
dal mercato diversi organofosfati.
Tuttavia circa 600 diversi
prodotti chimici sono usati come ingredienti attivi nei pesticidi e il mercato
di questi ingredienti attivi è passato da 60.000 tonnellate nel 1945 a 2,5
milioni nel 1995. Globalmente circa 34 milioni d’euro in pesticidi sono usati
nelle fattorie, nelle imprese agricole, dai privati per i loro orti e prati
all’inglese e per ragioni di salute pubblica, in caso d’infestazione d’insetti.
Oltre ad un aumento in
quantità c’è stato anche un aumento in qualità, nel senso che la tossicità dei
pesticidi d’oggi è da 10 a 100 volte maggiore rispetto a quella degli anni ’70.
In altri termini, quantità e tossicità sono aumentate in sinergia tra loro. Il vantaggio è che oggi i
pesticidi rimangono attivi per un periodo più corto che in passato e decadono
nel giro di pochi giorni in sottoprodotti inerti o, soltanto, minimamente
tossici. Cina, India e Brasile hanno piani per costruire nuove industrie e il
commercio internazionale è decuplicato.
Dall’altra parte della bilancia, l’impatto sociale ed ecologico di questa industria rimane insufficientemente definito, adombrato. Il WHO (Organizzazione Mondiale della Sanità), in accordo con altre organizzazioni, stima che più di 500 persone muore ogni giorno a causa dei pesticidi e altre 8000 rimangono avvelenate (anche se una buona parte si avvelena volontariamente a seguito del fallimento del raccolto). Le persone esposte ad alti livelli di pesticidi hanno più facilità di sviluppare problemi cardiaci, oncologici e del sistema immunitario.
Dopo
circa 40 anni dalla pubblicazione di “Silent Spring” (Carson, 1962), i
pesticidi continuano a danneggiare il mondo intero; i biologi stimano che 67
milioni d’uccelli muoiono ogni anno soltanto negli Stati Uniti, inoltre creano
deformazioni a molti cuccioli d’animali selvatici come le aquile dei Grandi
laghi nel Nord America, i coccodrilli in Florida, i pesci in Gran Bretagna e
gli avvoltoi in India.
I POP hanno un effetto
perturbatore sul sistema ormonale, giocando un ruolo importante su diversi
problemi della riproduzione e dello sviluppo, cosi come altri problemi di
disfunzione neurologica e immunologica sull’uomo e su alcuni animali (PNUE,
2000).
Abbiamo visto con il buco
dell’ozono [e con l’effetto serra[5]]
che gli effetti possono avere un impatto globale; anche con l’agricoltura
quello che avviene in una precisa zona geografica può causare degli effetti
negativi anche a migliaia di km di distanza. La signora Watt-Cloutier[6],
vicepresidente della conferenza circumpolare Inuit ci dice: “ A causa del
regime alimentare tradizionale del loro paese, i bambini assorbono un’alta
quantità di POP (inquinanti organici persistenti) tramite la placenta e il
latte materno. Questo è sia un problema di sanità pubblica che di sopravvivenza
della nostra cultura. Se noi non possiamo più mangiare i nostri alimenti
tradizionali è inevitabile che il nostro modo di vita scomparirebbe”.
Questi prodotti chimici
minacciano ugualmente anche la fauna; studi effettuati dall’Istituto Polare
Norvegese nelle isole Svalbard hanno messo in evidenza che un numero
significativo di orsi polari ha subito una mutazione dell’apparato sessuale a
causa di questi prodotti chimici. Fabbricati e utilizzati a centinaia e
migliaia di km di distanza, questi prodotti (ed anche altri), trasportati dalle
correnti, dai venti e dagli stessi animali per bioaccumulazione, si riversano
sull’Artico entrando nella catena alimentare fino a raggiungere l’uomo.
In India, oltre alla nube
tossica che uccise migliaia di persone nel 1984 a causa della fabbrica di
pesticidi Union Carbide ®, a Bophal sono critiche anche le condizioni
dell’acqua potabile ormai contaminata dai rifiuti tossici lasciati nello stesso
sito abbandonato[7].
Si potrebbe parlare dei
pesticidi ancora molto a lungo, sia perché i testi che trattano l’argomento non
mancano, sia perché il dibattito che si portano dietro molto spesso sconfina in
un dibattito politico, tra ecologisti e economisti, tra globale e locale,
oppure tra multinazionali e commercio equo e solidale, tra il bene e il male,
ecc., un dibattito che crea tutti i presupposti per il classico dualismo da
quattro soldi, che serve generalmente a disperdere le energie ed a non
affrontare il problema in maniera efficace. Un dibattito che utilizza
l’argomento “pesticidi” come pretesto per schierarsi con l’una o con l’altra
fazione.
Senza estendere il problema
alle condizioni di vita degli animali allevati nei grandi stabilimenti, ai
concimi minerali e alla biotecnologia applicata all’agricoltura, il problema
dei pesticidi è lungi dall’esser risolto e molto spesso la componente
psicologica gioca un ruolo fondamentale.
Nel 1998 è stata adottata la
Convenzione di Rottherdam (ONU, 1998), che dovrebbe proteggere la salute delle persone e l’ambiente,
attraverso l’incoraggiamento all’assunzione delle responsabilità e di una linea
di cooperazione nel commercio internazionale di sostanze chimiche, oltre che
promuovere un’uso ecologicamente razionale e un’informazione più trasparente
degli stessi.
Il problema maggiore,
tuttavia, rimane sempre l’eccesso nell’uso dei pesticidi.
3.3.3. Resistenza naturale ai pesticidi
L’aspetto più cruciale è il fatto che
gli agenti infestanti che si combattono con i pesticidi si sono adattati al
nuovo ambiente. Il continuo stress da essi subito ha creato in loro una resistenza. Il pesticida, infatti, non
colpisce al 100%, permettendo alle specie immuni la piena libertà di dominare
sulle altre specie. Allo stesso tempo, lo stress indotto dal pesticida induce
le specie infestanti a creare un certa resistenza. Se il pesticida è usato
regolarmente, l’agente infestante ha tutto il tempo di difendersi da esso,
sviluppando geneticamente una resistenza che lo porta a diventare immune.
Ovvero l’uso dei pesticidi crea una profonda alterazione dell’equilibrio delle
specie. La resistenza naturale al DDT appare sin dal 1946 e oggi la resistenza
ai pesticidi è stata riscontrata in circa 1000 specie infestanti e un crescente
numero di esse sono resistenti ad un notevole numero di pesticidi. Questo pone
un problema non solo di carattere sanitario, ma anche di carattere funzionale.
In altri termini i presupposti che esistono per l’utilizzo dei pesticidi sono
sempre meno validi, in quanto il pesticida riesce sempre meno a svolgere la sua
funzione primaria. Ciò crea un circolo vizioso nel quale, da una parte, per
mantenere una certa efficacia del prodotto l’industria chimica è obbligata ad
aumentare la forza del pesticida, quindi la sua tossicità, e dall’altra il
consumatore del pesticida (il coltivatore), vedendo ridurre gli effetti, è
costretto ad aumentarne le dosi. Arrivati però ad un certo livello soglia anche
la pianta stessa comincia a risentire delle alte dosi, e comincia a resistere,
fino al caso limite oltre il quale muore. Vedremo che le biotecnologie hanno in
parte ovviato a tale problema (cfr par 3.5.).
Il problema, però, sta anche su altre
direzioni. La malaria è anche la ragione per la quale difficilmente si può fare
a meno del DDT. Le 60 specie di zanzare che trasportano la malaria vengono
combattute con l’utilizzo del DDT. La malaria uccide un milione di persone e ne
contagia mezzo miliardo ogni anno; allo stesso tempo, il parassita Plasmodium
(all’origine della malaria) ha sviluppato una buona resistenza a molti farmaci,
così come le zanzare che lo trasportano hanno fatto con molti insetticidi.
Tutto questo succede nelle zone equatoriali e sub-tropicali dove le zanzare
hanno il loro habitat naturale.
Sin dal 1955 il WHO o l’OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità) propone il DDT come la migliore arma, ma
col passare del tempo questa convinzione è cambiata (Mc
Ginn, 2000). Non ci sono dubbi che la
malaria faccia più vittime del DDT, ma nell’ultima campagna contro la malaria,
l’OMS ha precisato che il DDT deve essere usato in condizioni d’emergenza e di
reale necessità. Bisogna partire prima dall’opzione meno tossica e solo
successivamente utilizzare quella più invasiva. La malaria è anche un problema
d’educazione sanitaria, che consiste nell’utilizzo di zanzariere imbevute in
sostanze repellenti, nel drenaggio delle acque ristagnanti o nella copertura
delle latrine a cielo aperto. Già questo riduce dal 30 al 60 % la trasmissione
della malaria. Soltanto dopo aver usato tutte queste precauzioni (ed altre), si
partirà con l’uso di pesticidi alternativi al DDT, in maniera strategica e
mirata, studiando la specie di zanzara e il suo comportamento.
Sotto un’altra ottica, dunque, limitando
l’uso di pesticidi in agricoltura, possiamo preservare il loro impiego e
l’efficacia per la funzione sanitaria di disinfestazione da virus e batteri
patogeni per l’uomo.
3.3.4. I concimi minerali
Un paese da solo, qualsiasi sia la sua
diligenza, non può risolvere il proprio problema d’inquinamento dovuto
all’agricoltura convenzionale, per la semplice ragione che gli effetti
sull’ambiente sono spesso planetari. Prendiamo il Golfo del Messico: importante
per la pesca, il turismo, riserva del 75 % degli uccelli acquatici migratori dell’America
del Nord, esso è anche uno dei punti caldi nel mondo per quanto riguarda gli
ecosistemi marini. Esso riceve un’eccessiva quantità di sostanze nutritive
provenienti dal ruscellamento dei concimi portati dal Mississippi, il cui
bacino raccoglie le acque del 40% della zona continentale degli Stati Uniti.
Tutto ciò contribuisce a creare nel golfo una zona morta (dagli anni ’90)
coperta dalle alghe, le quali consumano l’ossigeno necessario ai pesci e
coprono i raggi del sole, provocando la morte o la migrazione di massa su una
superficie di 1688 km². Una cosa simile è avvenuta in Italia negli anni ’90,
sulla riviera Adriatica, ma con un impatto ambientale minore, giacché nella
zona costiera della Carolina del Nord morirono milioni di pesci.
I concimi minerali si dividono in tre
tipi: quelli a base d’azoto, quelli a base di fosforo e quelli a base di
potassio, senza contare il carbonio. Ognuno di essi, soprattutto quando
l’utilizzo è in eccesso, ha un effetto diverso e talvolta cumulativo
sull’ambiente. Per quanto riguarda i problemi d’eutrofizzazione descritti poco
sopra, per esempio, i tre composti cumulano il loro impatto.
Inoltre la solita causa provoca
molteplici effetti negativi, in altre parole il ruscellamento di concimi
chimici lungo il Mississippi è anche il principale responsabile
dell’inquinamento dell’acqua nelle zone agricole degli USA (60 % della
lunghezza dei corsi d’acqua e il 57 % della superficie dei laghi, oltre che
delle acque sotterranee. Circa 950.000 km² tra USA e Canada sono interessati
dalla degradazione del suolo e l’erosione (PNUE, 2000). Questo per ribadire che
gli effetti dei diversi concimi minerali si differenziano e si cumulano tra
loro.
Andiamo a vedere, per esempio, quali
sono le conseguenze per l’ambiente dell’enorme aumento del carico d’azoto:
·
eutrofizzazione delle acque dolci: infiorescenza d’alghe, morte dei pesci, diminuzione
dell’ossigeno;
·
diminuzione della diversità vegetale a causa dell’adattamento di alcune specie meglio
preparate ad utilizzare l’azoto come fattore di dominio sulle altre;
·
il deposito d’azoto, ugualmente una causa di degrado importante del suolo: il livello
elevato d’azoto nel suolo aumenta la lisciviazione dei minerali quali il
potassio e il calcio che favoriscono la crescita delle piante e sono elementi
essenziali per la protezione dall’acidità del suolo;
·
ossidazione dell’azoto attraverso i batteri del suolo e le acque di superficie diventa un
fattore d’aumento dell’effetto serra, dell’ozono atmosferico oltre che
d’impoverimento dell’ozono stratosferico, seppur in minima parte;
·
aumento della concentrazione d’azoto nell’acqua potabile nei suoi composti
chimici come nitriti e nitrati.
Gli scienziati
sono sempre più convinti che l’ampiezza della perturbazione del ciclo
dell’azoto potrebbe avere delle conseguenze mondiali comparabili a quelle del
ciclo del carbonio. L’unico dato a favore, se pur non facilmente misurabile,
sta nell’interazione con il ciclo del carbonio. L’aumento dell’azoto globale,
favorendo l’accrescimento della biomassa
totale, genera un ampliamento del potenziale di stoccaggio del carbonio (PNUE,
2000), con conseguente riduzione dell’effetto serra.
Tuttavia i concimi minerali assieme ai
pesticidi permettono di ottenere un produzione agricola almeno del 30%
maggiore. Il problema anche qui sta nell’eccessivo uso dei concimi chimici, che
non riuscendo a fissarsi nelle piante si disperdono nell’ambiente per:
·
ruscellamento superficiale;
·
evaporazione atmosferica;
·
infiltrazione sotterranea;
·
fissazione dell’azoto, del fosforo
e del potassio a beneficio delle piante infestanti.
Un’utilizzazione mirata e ben bilanciata
garantisce una totale fissazione da parte delle piante, senza dispersione
nell’ambiente.
3.3.5. Il suolo agricolo
Le attività umane hanno degradato circa
2 miliardi di ettari di suolo, cioè il 15 % delle terre emerse del globo. Le
principali forme di degrado del suolo sono: l’erosione idrica (56%), l’erosione
eolica (28%), il degrado chimico (12%) e il degrado fisico (4%). I principali
fattori di degrado sono: il sovrapascolamento (35%), la deforestazione (35%),
le attività agricole (27%), il sovrasfruttamento della vegatazione (7%) e le
attività industriali (1%) (GACGC, 1994). Le zone urbane occupano soltanto l’1%
delle terre emerse (PNUE, 2002, pag 67).
Il degrado dei suoli genera una
riduzione della capacità produttiva della terra. In agricoltura le attività
umane che contribuiscono al degrado sei suoli sono: l’uso inadeguato delle
terre agricole, la cattiva gestione dell’acqua, la deforestazione, la riduzione
della vegetazione naturale, l’utilizzo frequente delle pesanti macchine
agricole, il pascolamento eccessivo, una cattiva rotazione delle colture e
un’irrigazione senza canali di scolo. A queste si aggiungono le catastrofi
naturali come l’aridità, le inondazioni e il dissesto idro-geologico, per i
quali l’uomo rimane pur sempre parzialmente e indirettamente responsabile.
All’inizio degli anni ’90, circa il 23% dell’insieme delle terre utilizzabili
(esclusi quindi montagne, deserti, paludi, ecc...), hanno una produttività agricola
potenziale ridotta: circa 910 milioni di ettari sono stati classificati a
“degrado moderato” e 305 a “forte degrado” (Oldeman, Hakkeling e Sombroeck,
1990; PNUE , 1992).
Il suolo agricolo è alla base del 90 %
dello stock di cibo per l’umanità, oltre che dello stock di fibre e d’altri
fattori produttivi. Il suolo agricolo non è
rinnovabile, se non in migliaia di anni. La sua
resilienza e la sua capacità di filtrare ed assorbire gli stress esterni
vengono percepiti soltanto alla luce di uno stato avanzato di degrado e
soltanto, successivamente, al superamento di certi livelli soglia. Inoltre c’è
un chiaro collegamento tra cambiamento climatico, sviluppo sostenibile, qualità
dell’ambiente e degrado del suolo.
Figura
3.1. Contaminazioni agricole nell’UE 15 e contaminazioni ambientali in Europa
dell’Est

Fonte:New Cronos and Regio databases, EC (1997); FAO
(1997)
La tendenza verso un’agricoltura
estensiva riduce anche le emissioni di metano (secondo responsabile
dell’effetto serra in valore assoluto, ma primo in valore relativo), degli
ossidi d’azoto (responsabili dell’ozono troposferico) e di NH4 (ammoniaca) (Swiss Agency for the Environment Forest and Landscape, 1997). A livello Europeo la diversità e la multifunzionalità
del terreno contribuisce alla varietà culturale dell’Europa, oltre a garantire
uno sviluppo sostenibile.
La desertificazione è un esempio
estremo d’effetto sinergico tra clima e non sostenibile uso dell’acqua e del
terreno; ma la desertificazione non è soltanto un problema delle regioni
soggette ad un clima secco, bensì anche dell’area del Mediterraneo. Un po’ in
tutta Europa si assiste ad una contaminazione più o meno importante dell’acqua
di falda da parte di pesticidi vecchi e nuovi, come pure ad un aumento
dell’eutrofizzazione dei laghi, dei fiumi e d’alcune zone costiere: ci
ricordiamo ancora le alghe nel mare Adriatico?!
La gestione non sostenibile del
terreno è uno dei problemi principali dell’agricoltura in Europa, ma non in
tutta l’Europa e non per le stesse ragioni. Se guardiamo la fig. 3.1., notiamo
delle aree geografiche nelle quali l’agricoltura intensiva è molto presente e
nelle quali l’uso di pesticidi e di fertilizzanti chimici è notevole ed altre
nelle quali l’ausilio chimico è molto più ridotto. La figura 3.1. individua, in
base alla quantità e qualità di sostanze chimiche usate, i terreni a alta e
bassa intensità chimica nell’agricoltura secondo la seguente tabella (3.2.):
Tabella 3.2. Classificazione delle sostanze chimiche
apposte in figura 3.1.
|
Tipo di sostanza |
BASSA
(LOW) |
MEDIA |
ALTA
(HIGH) |
|
Fertilizzanti |
<
50 kg/ha |
50
- 100 kg/ha |
>
100 kg/ha |
|
Pesticidi |
< 1 kg/ha |
1
- 2 kg/ha |
>
2 kg/ha |
|
Azoto |
<
50 kg/ha |
50
- 100 kg/ha |
>
100 kg/ha |
Fonte: New Cronos and Regio databases, EC (1997); FAO (1997)
Nella figura 3.1. appaiono anche altri tipi di contaminazione
relative all’Europa dell’Est (radioattiva, da metalli pesanti, da idrocarburi)
ciò per indicare che il livello di gravità tra le diverse forme di
contaminazione e l’uso elevato di composti chimici in agricoltura non sono
molto distanti sulla scala dei rischi ambientali.
Oggi, tuttavia, l’agricoltura è
orientata sempre più verso forme meno intensive e l’utilizzazione di concimi
sta diminuendo un po’ in tutta Europa, grazie anche agli incentivi posti per
favorire questo cambiamento. Da qualche anno in Europa c’è una graduale
riduzione dell’apporto di concimi chimici e di pesticidi. In questo, la
Comunità Europa ha giocato sicuramente un ruolo decisivo nell’invertire la
tendenza (cfr par 4.2.).
3.4. Agricoltura e ambiente politico
3.4.1. La Politica Agricola
Comune
Prendiamo come esempio il caso
europeo per capire come si è evoluta, in politica, la percezione
dell’agricoltura a partire dagli anni ’50, proprio perché è molto simile al
caso svizzero. Sono stati degli anni fondamentali del passaggio da
un’agricoltura tradizionale ad un’agricoltura moderna ed il contributo offerto
dalla politica non è stato da meno. Un contributo, che però, si è focalizzato
troppo sull’aspetto economico e produttivo, deterritorializzando l’agricoltura
attraverso un’esaltazione delle leggi della concorrenza e della competitività,
e poco sugli aspetti di valorizzazione territoriale, regionale e
multifunzionale (Grillotti, 1992).
La Politica Agricola Comune (PAC) venne creata dai sei paesi firmatari
per raggiungere tre scopi essenziali individuati dal Piano Mansholt alla Conferenza
di Stresa del 1958 (Com 60/105):
·
incrementare
la produzione agricola (inizialmente dei cereali);
·
assicurare un
tenore di vita equo agli agricoltori;
·
garantire la
stabilità del mercato e l’approvvigionamento dei consumatori a prezzi
ragionevoli.
Gli strumenti da utilizzare erano
sostanzialmente due: la riorganizzazione dei mercati agricoli e la politica dei
prezzi. Nella stessa conferenza furono invece trascurati altri scopi, poi
rivelatisi importanti, messi in evidenza dal Piano Mansholt:
·
risolvere il
problema di eventuali eccedenze che l’aumento della produzione avrebbe
favorito;
·
tentativo di
regionalizzazione dell’agricoltura tramite dei piani di sviluppo regionale per
migliorare strutture e modernizzare le imprese, in particolare quelle a
conduzione familiare;
Successivamente (Consiglio dei Ministri,
1962), venne approvata la creazione di un Fondo Europeo di Orientamento e
Garanzia (FEOGA) che avrebbe finanziato tutte le iniziative della PAC. Negli
anni ’70 si estese la politica dei prezzi e dei mercati agricoli ad altri
prodotti (vino, tabacco, latte, ortaggi e frutta) favorendo specificatamente
quei prodotti dell’agricoltura nord europea (modello nord-atlantico) e si riconobbe
la necessità di ridurre le eccedenze e gli interventi strutturali (Grillotti,
1992).
I limiti della PAC e gli effetti
negativi della politica dei prezzi vennero messi in risalto dal notevole
incremento del costo dei fattori produttivi impiegati per la modernizzazione
dell’agricoltura (mezzi chimici e meccanici), dall’aumento della produzione e
dall’inerzia dei redditi degli agricoltori. Con gli anni ’80, per effetto anche
di congiunture internazionali sfavorevoli, tali problemi cominciarono ad arrivare
al pettine:
·
Il sostegno
dei prezzi arriva ad i suoi limiti di spesa, obbligando le amministrazioni ad
un giro di vite, riguardante il tetto massimo di produzione garantita per ogni
prodotto entro il quale sostenere i prezzi.
·
Si rese finalmente necessaria una
regionalizzazione della politica delle strutture, come previsto dal Piano
Mansholt del 1958.
·
La diminuzione
della domanda interna ed esterna, a fronte di un aumento della produzione
ottenuto a dispetto di una diminuzione di ben il 35 % della popolazione
agricola dal 1975 al 1989, produsse delle eccedenze.
·
I “prezzi
garantiti” hanno spinto artificialmente la produzione, provocando sia un
aumento impressionante delle spese d’assorbimento e stoccaggio delle eccedenze,
sia un avvelenamento crescente dell’agricoltura (impiego massiccio di
fertilizzanti e antiparassitari).
Nella seconda metà degli anni ’80 e
particolarmente negli anni ’90 l’attenzione si sposta dal sostegno alla
produzione, a quello alle aziende; dagli incentivi per la cessazione e modernizzazione
dell’attività agricola, a quelli per il rimboschimento e al mantenimento degli
agricoltori delle aree marginali soggette ad esodo agricolo; dalla resa
unitaria all’ambiente (v. par 4.2).
Il paradosso rimane pressochè il solito:
cercare un modello di sviluppo puntando su
imprese che ne adottano un altro (Grillotti, 2000), cioè si cercava di favorire
un modello di sviluppo per le piccole imprese, ma in realtà furono soltanto le
grandi imprese a beneficiare degli aiuti.
3.5. Agricoltura e biotecnologie
3.5.1. L’impatto socio-ambientale
Fino a qualche anno fa, i contadini erano coloro che avevano la mansione di lavorare la terra e di produrre attraverso l’agricoltura gli alimenti per la nostra società. Il lavoro era duro e soltanto i contadini conoscevano i segreti della terra e il modo col quale far nascere e crescere una pianta o un frutto. Un po’ come i dottori in medicina, gli avvocati nel diritto, i politici in politica e i cuochi in cucina. Col passare del tempo le cose sono cambiate: i contadini, sempre meno numerosi, sono stati “rimpiazzati” dai chimici e dai biologi. La fuga dalle campagne e l’ininterrotta diminuzione degli addetti nel settore primario, hanno creato un vuoto che è stato parzialmente colmato da un sostanziale aumento della produttività del lavoro, con peggioramento della qualità del prodotto. Basterebbe ascoltare le nostre nonne per renderci conto di ciò!
Con il passare del tempo in agricoltura si è guardato più
al margine economico che alla qualità. Il duro lavoro del contadino è stato rimpiazzato con il razionale lavoro
degli agronomi, dei biologi e anche degli ingegneri genetici sulla nuova
frontiera della biotecnologia. Oggi con gli OGM (Organismi Geneticamente
Modificati) ci troviamo in una situazione analoga a quella degli anni ‘50,
quando i pesticidi sintetici furono scoperti; oggi, come negli anni ’50, non
conosciamo molto del reale impatto ambientale dei nuovi OGM; ma oggi, come
negli anni ’50 sappiamo degli interessi economici legati a questa nuova
frontiera, anche perché, alcune delle “anziane” multinazionali (Dupont, Dow e
Monsanto) che producevano prodotti chimici come l’Agent Orange o i PCB
hanno riconvertito i loro investimenti verso il nuovo “miracolo”
dell’ingegneria genetica (Lappè, Baley, 1999).
Il primo raccolto
geneticamente modificato fu prodotto nei primi anni ’70: in California venne
creata una fragola resistente al gelo. Il risultato, per quanto riguarda la
resistenza al gelo, fu insoddisfacente, ma nuovi geni più robusti e nuovi
organismi vennero testati. Il gene di una noce dal Brasile ricco in metionina
fu inserito nella soia per aumentarne il tenore in proteine, sfortunatamente un
gruppo di scienziati scoprì che la “nuova” soia conteneva le proprietà
allergiche della noce del Brasile, rendendola difficilmente commerciabile.
Questa tendenza, che è andata
avanti per anni, vede l’agricoltura come uno strumento di accumulazione
economica e non come una finalità della multifunzionalità in agricoltura. Ci
sono dei casi nei quali il raccolto viene “programmato” a partire da una
provetta in laboratorio, con la quale si è sintetizzato il seme che meglio si
adatterà ad un determinato pesticida. Questa tendenza vede il contadino
diventare un attore privato della sua saggezza e del suo “amore per la terra”,
grazie al quale per secoli l’agricoltura tradizionale si è evoluta in
equilibrio tra società e territorio, tra uomo e natura (cfr par 3.1.2.).
Su logica opposta, il
contributo dato dalle scienze naturali all’agricoltura è stato necessario per
colmare la vertiginosa riduzione dei contadini (che ancora è in atto nei paesi
in via di sviluppo) e il repentino incremento demografico. La fuga dalle
campagne e l’urbanizzazione hanno creato un vuoto di risorse umane che è stato
colmato dalla meccanizzazione, dalla tecnologia e dalle scienze agrarie e
naturali, applicate all’agricoltura. In altri termini il progresso ha
incrementato notevolmente la produttività del lavoro di coloro che sono rimasti
nel settore primario. Le domande che sorgono spontanee a questo punto sono:
Anche le biotecnologie stanno realmente dando
all’agricoltura un contributo analogo?
L’utilizzo delle biotecnologie crea veramente un
beneficio per la società?
Per rispondere a questi quesiti, sarebbe molto
utile leggere il libro di Anna Meldolesi (2001) “Organismi geneticamente
modificati. Storia di un dibattito truccato”.
3.5.2. La questione politica
La questione OGM si gioca attorno ad
un dibattito globale che interessa la scienza, l’economia e la politica,
relegando l’agricoltura su un piano marginale. Un dibattito globale che si
contrappone a quel carattere locale (cfr par. 2.5.) tipico dell’agricoltura
tradizionale, che la vedeva attrice incontrastata dell’ecogenesi territoriale.
Il dibattito sulle biotecnologie
applicate all’agricoltura ha la generica dualità propria dei dibattiti
politici:
·
da
una parte c’è chi nelle moderne biotecnologie verdi vede la leva per far
compiere all’agricoltura un nuovo salto di qualità, investendo sempre maggiori
capitali e energie;
·
dall’altra
c’è chi vede nei prodotti geneticamente modificati (Ogm) che ne derivano, un
pericolo per la salute umana, per l’equilibrio degli ecosistemi e per le
economie dell’Europa e del Terzo Mondo.
Si tratta di un dibattito
globale che coinvolge governi, diverse agenzie delle Nazioni Unite, le
multinazionali agro-alimentari e della chimica, partiti, scienziati, movimenti,
associazioni, nonni, il variegato mondo dei No-global ed anche importanti
autorità religiose. Coinvolge
tutti, perché tutti ne sono interessati. Come spesso
avviene nei casi di discussioni di così largo raggio, anche in questo caso i
fatti hanno subìto una distorsione mediatica. In altri termini, il confronto delle parti si basa
su una sistematica distorsione dei fatti (scientifici, tecnici ed economici) e
spesso i veri motivi che muovono tale dibattito si ritrovano nella dualità tra
locale e globale, tra scienza e politica, tra innovazione e conservazione, tra
economia ed ecologia, tra bene e male, senza realmente preoccuparsi
dell’agricoltura (cfr. fine par 3.3.3. sui pesticidi).
Da una parte il movimento
ecologista (o almeno una parte di esso), vittima del suo stesso
fondamentalismo, ha alterato i fatti scientifici creando intorno agli Ogm un
generico alone tenebroso. Dietro a certe prese di posizione, talvolta, si
nasconde quell’idealismo ecologico che ha come effetto la rigida cecità nei
confronti della realtà. Il movimento ecologista che si oppone agli Ogm è
riuscito a far passare, non solo a livello di massa, ma anche a livello di
governi (soprattutto in Europa) e addirittura di Nazioni Unite (Protocollo di
Cartagena sulla Biosicurezza) una visione delle biotecnologie verdi (sulle
piante), e dei rischi che comportano, lontana da ogni principio di realtà
(Meldolesi, 2001)
Le biotecnologie verdi sono
già una realtà e converrebbe tentare di governarle per sfruttarne le
potenzialità e garantire la sostenibilità, piuttosto che cercare inutilmente di
esorcizzarle. La distorsione mediatica che ne deriva è quella di considerare
come “male” ogni tipo di biotecnologia, verde o rossa (produzione di farmaci)
che sia. Questo crea non poche contraddizioni, visto che non sono pochi i casi
di persone che si curano con medicinali prodotti grazie alla biotecnologia
rossa (prendiamo l’esempio dell’insulina prodotta attraverso un batterio modificato),
ma che non accettano di vestirsi con una camicia di cotone geneticamente
modificato.
Dall’altra parte le
multinazionali hanno tratto profitto da tutto ciò, gettandosi a capo fitto in
investimenti faraonici già agli inizi degli anni ’90, aumentando consapevolmente
la distorsione dei fatti. Con plateale arroganza le multinazionali hanno
sviluppato le biotecnologie verdi indirizzate alla massimizzazione dei loro
profitti, senza apportare alcun beneficio ai consumatori, né tanto meno
all’ambiente. Attraverso un’attenta pianificazione e programmazione esse hanno
indirizzato gli investimenti secondo una logica ben precisa, quella della
sinergia aziendale. In altri termini le stesse aziende produttrici di pesticidi
o le aziende da esse controllate, hanno riconvertito gli investimenti verso le
biotecnologie verdi, allo scopo di creare delle sementi che abbiano una
resistenza maggiore agli stessi pesticidi (cfr. fine par 3.3.3.). Il risultato
è palese: da una parte l’azienda incrementa i profitti dati dalla vendita dei
pesticidi e dall’altra ottiene dei nuovi guadagni derivanti dalla vendita delle
sementi.
3.5.3. L’impatto economico-ambientale
La nuova industria della biotecnologia è strettamente legata a quella dei pesticidi e erbicidi, cosicché la Monsanto ha dominato la produzione mondiale di erbicidi con 26 milioni di sterline anche grazie al fatto che ha creato la soia Roundup® capace di resistere al potente erbicida Roundup® prodotto dalla stessa multinazionale, i cui effetti sull’uomo non sono ancora completamente conosciuti. Un altro esempio ci è dato dal Liberty Link TM sviluppato dalla AgrEvo (la 4° più grande industria chimica del mondo), una tecnologia genetica studiata per essere immune all’erbicida Dupont’s Liberty®. Il sistema STS® brevettato dalla Dupont Agricultural Products è in correlazione con gli erbicidi della Synchrony® e Reliance®. La tecnologia genetica del cotone BXN® è stata sviluppata dalla Calogene (acquisita adesso dalla Monsanto insieme alla Rhône Poulenc), ciò permette di spruzzare un’alta dose dell’erbicida bromoxynil, poiché il cotone ha un gene che lo rende tollerante. Oltre alla soia Roundup®, il cotone Roundup® esistono il mais Yieldgard®, il cottone Bollgard®, le patate Newleaf®, il pomodoro Flavr-Savr® e il pomodoro Endless Summer® e altri ancora, per un fatturato complessivo dovuto all’uso delle invenzioni agrobiotecnolgiche di 46 miliardi di dollari nell’anno 2000 (Les Clés du Monde, 2003).
Dunque i più popolari prodotti agricoli geneticamente modificati contengono dei geni che li rendono immuni o più tolleranti a quegli specifici erbicidi; ciò permette un uso ancora più massiccio degli erbicidi prodotti dalle stesse multinazionali. Sotto un’altra prospettiva, il valore in termini di varietà genetica, di salute umana e d’impatto ambientale si trasforma in profitti derivanti dalla vendita dei semi geneticamente modificati e dalla vendita dei pesticidi ed erbicidi stessi.
Si è quindi creato un circolo vizioso, nel quale nuove tecniche genetiche servono per rilanciare
“vecchie” sostanze antiparassitarie. Il risultato è una tendenza all’aumento
dell’uso della tecnica genetica, in sinergia, con l’aumento della vendita dei
pesticidi e degli erbicidi sintetici. Nel 1997 negli Stati Uniti i due terzi
delle colture geneticamente modificate sono state espressamente concepite per
resistere agli erbicidi (USDA/APHIS, 1997).
Non abbiamo ancora parlato dei
danni direttamente derivanti dall’alterazione genetica dei prodotti agricoli
sulla salute dell’uomo, ma credo che ci troviamo in una situazione analoga a
quella degli anni ’50, quando i pesticidi e gli erbicidi furono utilizzati in
agricoltura per la prima volta, e, come in quel tempo, i reali effetti della
nuova tecnologia sono ambigui e saranno scoperti soltanto tra qualche anno.
L’avvento dell’agricoltura
genetica sta cambiando i metodi di produzione agricola, ma bisogna chiedersi
anche quanto questo cambiamento aumenti veramente lo stock di cibo per
l’umanità e quanto invece aumenti soltanto lo stock di capitale delle
multinazionali del settore. Alcuni rappresentanti della Caregen e della
Monsanto, infatti, giustificano l’avvento dell’agricoltura genetica come
risposta all’aumento della popolazione e come possibile soluzione alla
crescente richiesta di cibo mondiale. Purtroppo i prospetti odierni
contraddicono le loro affermazioni, perché la maggior parte del raccolto di Ogm
è usata per l’allevamento e altri usi e non per le persone, il che rende priva
di valore ogni affermazione che suggerisce le biotecnologie verdi come la
tecnica agricola necessaria all’uomo per risolvere i problemi di fame nel
mondo. Inoltre il raccolto per l’allevamento ha dei limiti d’utilizzo e di
residui negli alimenti ben minori rispetto al raccolto destinato alle persone
(Mc Ginn, 1992).
In realtà là dovremo fare una
precisazione molto importante, separando con estrema cura le biotecnologie
verdi, che apportano un certo beneficio collettivo, da quelle che limitano il
loro beneficio ad un piano prettamente privatistico e soltanto dal lato dei
produttori. Ci accorgeremo che tutta quella paura per gli Ogm non è sempre così
giustificata, anzi talvolta è proprio questa paura che mantiene viva la
distorsione dei fatti.
Quello che è interessante
analizzare è la motivazione che sta dietro alla coltivazione di prodotti Ogm.
Non è un caso che il golden rice, il riso ricco di beta-carotene, il
riso ricco di ferro e i nutriceuticals (sostanze che sono insieme
alimenti e farmaci), che promettono di migliorare la dieta povera di vitamina A
e/o di ferro, dando un contributo diretto e visibile a risolvere i problemi di
cecità e anemia di milioni di persone nel Terzo Mondo, siano stati messi a
punto in un laboratorio pubblico della apparentemente scettica Europa (quello
del Politecnico federale di Zurigo), grazie anche al finanziamento di
un’organizzazione americana che non ha fini di lucro, come la Rockefeller
Foundation.
Importante è riuscire a capire quale è la
motivazione principale degli investimenti, quali sono gli obiettivi aziendali
che incentivano il finanziamento in ricerca & sviluppo delle biotecnologie
verdi. Una prima divisione, che riprenderemo nel prossimo capitolo (cfr. cap.
4.) è quella tra motivazioni di carattere privatistico e motivazioni di
carattere collettivo.
Un’azienda spinta da obiettivi
d’ordine privatistico cercherà, nel migliore dei modi, di massimizzare i propri
profitti e di ottenere un beneficio privatistico dagli investimenti in R&S
effettuati. Lavorando sull’immagine aziendale e su attenti piani marketing,
si adopererà per conquistare sempre nuovi mercati, massimizzando i profitti,
mentre un’azienda spinta da obiettivi di carattere collettivo, generalmente con
un’efficienza minore, cercherà di realizzare gli obiettivi statutari attuando
investimenti che arrechino benefici alla collettività, verso progetti
generalmente senza scopo di lucro.
Già l’assetto
proprietario ci aiuta a distinguere le due differenti motivazioni. Una società
di capitali, generalmente una s.p.a. quotata in borsa già attiva da tempo in
qualità d’azienda chimica o agrolimentare multinazionale, con molta più
facilità sarà spinta da motivazioni di carattere privatistico, mentre una
fondazione, un’associazione senza fini di lucro o un’azienda pubblica sarà
spinta da motivazioni di carattere collettivo e non cercherà di sfruttare, ai fini
aziendalistici, le sinergie che ci sono tra produzione di pesticidi e sviluppo
delle biotecnologie.
Questa distinzione,
apparentemente scontata, ci permette di effettuare una prima importante
constatazione, alla luce anche dell’impreciso e sconosciuto effetto delle
alterazioni genetiche e del ben conosciuto impatto dei pesticidi sulla salute
dell’uomo e sull’ambiente.
Motivazioni di carattere
privatistico delle aziende biotecnologiche verdi arrecano un danno certo
all’ambiente dato dal maggior uso dei pesticidi, mentre motivazioni di
carattere privatistico delle aziende biotecnologiche rosse (produzione di
farmaci) non necessariamente aumentano il carico di pesticidi nell’ambiente.
L’unica eccezione è quando anche le aziende farmaceutiche hanno il controllo di
qualche azienda chimica produttrice di pesticidi o hanno un certo interesse nel
promuovere la vendita dei pesticidi.
In altri termini, quando nelle
aziende biotecnologiche oltre all’interesse privatistico sussiste un
collegamento con aziende chimiche produttrici di pesticidi, è molto probabile
che la ricerca e la produzione siano mirate alla vendita di pesticidi. È un
classico esempio di bolla speculativa a danno dell’ambiente, potenzialmente
assimilabile dalle aziende chimiche e/o biotecnologiche come “sinergia
aziendale”.
La generica demonizzazione dei
prodotti Ogm reca vantaggio soltanto alle multinazionali, le quali hanno potuto
acquisire quasi il monopolio delle moderne biotecnologie, con quella forsennata
corsa ai brevetti e quel carillon vertiginoso d’ingegneria finanziaria e
aziendale che Anna Meldolesi (vedi nota 15) ha scrupolosamente documentato.
Questa plateale arroganza ha generato preoccupazioni non solo nel grande
pubblico, ma anche nei governi. Si tratta di preoccupazioni politiche ed economiche
legittime, anche se troppo spesso hanno suscitato reazioni scomposte, che hanno
finito per inquinare anche il dibattito scientifico.
Non è un caso che le biotecnologie
di seconda generazione, quelle che mirano a produrre vantaggi diretti per i consumatori
(e magari per i consumatori poveri), stiano emergendo solo ora e fuori dai
laboratori delle multinazionali. Tutte le indagini in tutto il mondo dimostrano
che la gran parte delle persone ha un'immagine positiva delle biotecnologie
rosse proprio perché vede un beneficio diretto per la propria salute, mentre
nutre dubbi sulle biotecnologie verdi perché quel beneficio diretto non riesce
ancora a vederlo. Tre quarti degli europei si dichiarano scettici e poco
fiduciosi degli Ogm, senza distinzioni tra Ogm verdi o Ogm rossi (Les Clès du
Monde, 2003).
Negli Stati Uniti le biotecnologie
verdi hanno più successo, tanto che 39 milioni di ha (390.000 km²), una
superficie più grande dell’Italia, sono ufficialmente coltivati con Ogm. Segue
l’Argentina con 13,5 milioni di ha, il Canada con 3,5 milioni di ha, la Cina
con 2,1 milioni di ha, l’Africa del Sud con 300.000 ha e l’Australia con
100.000 ha (Les Clés du Monde2003). Per quello che riguarda la qualità delle
piante coltivate, il 61% delle colture transgeniche riguarda la soia, il 21% il
mais, il 13% il cotone e il 5% la colza (Les Clés du Monde, 2003).
Nel 2002 la Zambia, dove la fame
minaccia 2,4 milioni di persone, ha ufficialmente rifiutato l’aiuto alimentare
americano, in quanto conteneva dei prodotti Ogm.
Tuttavia, numerosi farmaci (prodotti
con le biotecnologie rosse) sono già in commercio, oltre l’insulina, l’ormone
della crescita, un vaccino contro l’epatite B, ecc….. Alcuni batteri Ogm sono
utilizzati per smaltire certi inquinanti dai suoli contaminati. Senza contare i
biocombustibili, gli alberi per una produzione di carta meno inquinante,
coltivazioni batteriche, ecc….
In definitiva, però, non conosciamo
gli effetti sull’uomo nel lungo periodo della somministrazione ripetuta di
alimenti geneticamente modificati. Chissà se anche qui potremo dire che dipenda
dalla quantità (cfr. par 3.3.)?
3.6. Agricoltura moderna
L’agricoltura moderna provoca quindi
un’alterazione globale dell’ambiente, in alcuni casi in modo cronico e/o acuto.
Questo capitolo serve a dare un’idea generale del reale costo collettivo da
imputare all’agricoltura moderna e prende in considerazione molte delle
esternalità negative che essa si porta seco.
Un’altra conseguenza diretta legata
all’agricoltura moderna convenzionale è il gran consumo d’acqua, soprattutto se
lo si considera alla luce dell’incremento demografico e dei bisogni idrici
extra-agricoli (consumi domestici e industriali). Il professor Pretty
ed altri (2001) hanno stimato che il
costo annuale della contaminazione di acqua potabile con pesticidi sia, per la
sola Gran Bretagna, approssimativamente 190 milioni di euro all’anno! In realtà solo
questi dati dovrebbe bastare per riindirizzare l’agricoltura verso la
sostenibilità, ma come spesso accade in economia, anche l’agricoltura ha
sofferto e soffre di miopia temporale; in altri termini, il “tasso di sconto di
un evento causa d’impatto ambientale futuro” è generalemente troppo alto, il
che rende minimo il suo valore atteso ad oggi, sottostimando i possibili
scenari già prospettati dal Club di Roma (Meadows, 1972).
Ricordiamo, tuttavia, che ogni forma
d’agricoltura ha un impatto sull’ambiente e che le piante stesse, per
difendersi dall’ambiente naturale, secernono dei pesticidi naturali. Ames
(Morandini, 2000) ci dice: “il 99,99 % dei pesticidi che noi ingeriamo sono
naturali”. Secondo lui i composti chimici di sintesi sono appena una goccia nel
mare rispetto ai composti chimici naturali a cui siamo esposti. Tostando il
caffè, per esempio, vengono prodotti circa 1000 composti ugualmente tossici. Le
piante sono piene di pesticidi naturali (composti che hanno la funzione di
proteggere la pianta dai suoi parassiti) e la quantità di pesticidi di sintesi
che realmente assorbiamo in qualità di consumatori è minima.
Questa tesi va bilanciata con il fatto
che negli Stati Uniti i ricercatori (biologi, chimici, biochimici, ecc...)
hanno più fortuna e vengono finanziati meglio, se non si mettono in contrasto
con gli interessi delle grandi società chimiche e agroalimentari. Una curiosa
coincidenza mi ha portato a conoscere la figlia del prof. Linjiski, famoso
biochimico americano, che indagava sulle cause dell’insorgenza dei tumori. Lei
mi ha raccontato, che suo padre studiava la responsabilità dei residui dei
pesticidi negli alimenti, nell’insorgenza dei tumori. Il suo eterno rivale B.
Ames, con il quale ha partecipato a trasmissioni televisive tipo “LINJISKI
versus AMES”, invece, indaga sulla tossicità dei pesticidi naturali, quelli
prodotti dalle piante in maniera spontanea (v. sopra) e, in linea generale, non
mette in dubbio l’utilità e l’assenza di rischio dei pesticidi sintetici sulla
salute dell’uomo. Il risultato è stato che, il prof. Linjiski è dovuto andare
in pensione, mentre il prof Ames continua ad essere finanziato e sponsorizzato
per le sue ricerche che non contrastano le grandi società, nonostante che essi
siano coetanei.
Alla luce di ciò, possiamo ricavare tre importanti
informazioni:
- Una
selezione naturale del mercato verso quei ricercatori che si dimostrano
“vicini” agli interessi privatistici delle aziende che finanziano la
ricerca.
- Una R
& S, molto a favore degli interessi privatistici, ma non
necessariamente mirata all’obiettivo di benessere sociale. Soprattutto in
que paesi, come gli USA dove R & S è finanziata principalmente da
capitali privati.
- Allo
stesso tempo il mito del “naturale è meglio”, deve comunque essere preso
con la dovuta cautela, come pure la demonizzazione della chimica che ne
deriva, visto che il problema non sta nella sostanza, ma nella quantità. Il
problema è di natura psicologica, perché la parola sintetico (cfr. par.
3.3.1.) spaventa più della parola naturale.
Le cose cambiano se invece di
considerare l'impatto sulla salute dell'uomo direttamente imputabile alla
somministrazione degli alimenti agricoli, ci concentriamo sull'impatto
sull'ambiente. L’impatto sull'ambiente dell'agricoltura biologica rispetto a
quella convenzionale è da 6 a 7 volte minore, ma ciò non significa che non ci
sia. Questa è una stima imprecisa e che si basa sulle medie dei valori, ma
comunque sia ci dice che con l’agricoltura biologica c’è una riduzione da 6 a 7
volte del danno ambientale, che si traduce in una riduzione dei costi sociali e
del carico degli inquinanti sulla salute dell’uomo.
Infine, va ricordato che, sulla
“scala del rispetto dell’ambiente”, esiste una forma di agricoltura ancora più
in sintonia con l'ambiente (intero universo): l' agricoltura biodinamica (v. par 4.1.2.). I principi su cui si fonda
furono formulati da Rudolf Stainer (1973), il fondatore dell’antroposofia,
una concezione dell’uomo e del mondo che ha portato, nel primo quarto di questo
secolo, un rinnovamento fertile nel campo della medicina, della pedagogia,
dell’arte e della scienza in genere.
Dal sito sull’agricoltura biodinamica si può ricavare
il seguente pensiero[8]: “La coltivazione biodinamica implica
tutto un modo di vivere, osservare e lavorare la terra. Il suo scopo non è di
lasciar fare alla natura, ma di fare oltre la natura, cioè di aiutare la natura
per ottenere una terra sempre più fertile, della quale possano beneficiare
anche le generazioni future, e alimenti vivi di qualità piena che nutrano
l'uomo e gli diano salute. Coltivare biodinamicamente non vuol dire applicare
in modo meccanico un metodo fisso. Piuttosto si può parlare di un indirizzo per
il nostro pensare e agire, che poi svilupperemo secondo le condizioni e i
problemi che incontreremo sulla nostra terra”.
4. TRANSIZIONE DALL’AGRICOLTURA MODERNA A
QUELLA SOSTENIBILE.
IL CASO-STUDIO : L’AGRICOLTURA SVIZZERA
4.1. Agricoltura sostenibile
4.1.1. Definizione di sostenibilità in
agricoltura
La definizione classica
d’agricoltura sostenibile, definisce: “Un’agricoltura che permette di fornire
indefinitivamente i beni e i servizi che gli sono demandati, a dei costi
economici e ambientali socialmente accettabili” (OCDE, 1997). La definizione di
sostenibiltà in agricoltura, non si limita a riconoscere una forma
d’agricoltura con un impatto sull’ambiente ridotto, che garantisca l’uso dei
terreni coltivati anche per le generazioni future, un’agricoltura sostenibile
ha una portata ben diversa, più complessa e più completa.
Dalla definizione di sostenibilità
notiamo che, oltre all’aspetto ambientale, devono essere presenti l’aspetto
economico e l’aspetto sociale. Inoltre, i benefici dati da essa si dovrebbero estendere all’intera società
presente e futura. In altri termini, tutti gli abitanti del pianeta, genazione
presente e generazione futura, dovrebbero essere considerati equamente come
destinatari dei benefici che ne derivano.
I benefici come vedremo (cfr. par.
4.3. multifunzionalità), sono molteplici, in quanto all’agricoltura sostenibile non spetta soltanto la funzione
di produzione di alimenti per l’umanità (presente e futura), ma anche quella di
mantenere la base genetica delle colture, di conservare la diversità biologica
delle specie (selvatiche o addomesticate) che vivono nell’ambiente agricolo, di
mantenere il terreno in condizioni di fertilità, di garantire un’occupazione
decentrata, di sviluppo di zone sfavorite e ricreativa per gli abitanti. Da un
punto di vista economico, inoltre, questi benefici devono andare di pari passo
con quelli di natura economica, cioè un agricoltura sostenibile è
un’agricoltura economicamente efficiente (cfr. par. 4.4. e 4.6.).
La sostenibilità permette una
classificazione delle forme di agricoltura moderna :
- Da un
punto di vista ambientale la differenza è tra una coltivazione convenzionale, biologica o a
produzione integrata:
- La coltivazione convenzionale, nella sua forma più pura,
non si cura troppo delle caratteristiche proprie di ciascuna
coltivazione, al contrario si attua una pianificata e standardizzata
protezione fitosanitaria e concimazione, senza la necessaria
conoscenza del terreno, del clima, delle tradizioni, delle stagioni,
della posizione geografica. L’impatto sull’ambiente è molto alto.
- Nella coltivazione a PI, si minimizza l’utilizzo dei
pesticidi e concimi chimici alle precise esigenze della coltivazione.
- Nella coltivazione biologica si riduce l’utilizzo dei
concimi chimici e si sostituisce
quello dei pesticidi con sistemi alternativi altrettanto rigorosi
sul piano scientifico (alterazioni ormonali, insetti predatori, semina di
piante protettive, rispetto delle tradizioni contadine, mantenimento
dell’humus del terreno, ect…).
- Nella coltivazione biodinamica si arriva a considerare la
coltivazione come un essere vivente in tutto e per tutto.
- Sotto
l’aspetto socio-economico esistono agricolture efficienti, nelle quali l’allocazione dei
fattori massimizza i benefici per la società (presente e futura), e
agricolture inefficienti, dove sono massimizzati soltanto gli interessi
privatistici. Vanno considerati anche i benefici per l’occupazione, ma
soprattutto nella sostenibilità vanno considerate anche le esternalità.
L’impatto sull’ambiente è diverso
per ognuna di esse, ma tutte, se pur in misura diversa, ricorrono alla
meccanizzazione. Inoltre, non basta, e non è poi cosi strettamente necessario,
che un’agricoltura sia biologica per essere definita sostenibile. Vedremo nei
prossimi paragrafi che l’agricoltura si sta dirigendo verso la sostenibilità e
l’agricoltura biologica sta giocando un ruolo importante per questo
cambiamento, un ruolo trainante. Perciò è un buon esempio da prendere in
considerazione.
Abbiamo anche esempi di agricolture
tradizionali che hanno portato interi popoli alla rovina ; ad esempio nella
Mezza Luna Fertile attraverso l’elevato sfruttamento dei suoli e la mancanza di
conoscenza, le terre divennero improduttive e successivamente desertiche, forse
proprio perchè la tradizione agricola ancora non era matura.
Generalmente l’agricoltura tradizionale ha una
bassa produttività del lavoro, il che l’allontana dalla sostenibilità.
L’agricoltura tradizionale, però, non ha necessariamente una bassa produttività
della terra (cfr. cap 1).
Come vedremo nel paragrafo 4.1.3. un
modo per capire la sostenibilità in agricoltura è quello di riferirsi alla
territorialità. Mentre nel paragrafo 4.3. e successivi, andremo a vedere che
l’agricoltura svizzera è sulla strada della sostenibilità. Ma cosa c’entra la
Svizzera in tutto ciò? Perché ho scelto la Svizzera come esempio di paese verso
la sostenibilità?
Il caso-studio della Svizzera è
emblematico per almeno cinque ragioni fondamentali :
·
la
sua dimensione demografica e geografica ridotte le permettono di mantenere la flessibilità e
l’agilità politica necessaria per le decisioni di una certa portata;
·
sistema
politico più diretto,
dove lo strumento del referendum popolare è molto usato;
· una buona situazione economico-finanziaria pubblica, che le permette di trovare le risorse necessarie;
· la sua posizione di neutralità, che la obbligherebbe moralmente ad essere neutrale anche su un piano ambientale;
·
la
sua immagine storica di paese che rispetta l’ambiente, riflessa sia verso gli altri paesi, sia verso
essa stessa, che costituisce motivo di orgoglio nazionale.
4.1.2. Breve storia dell’agricoltura
biologica e biodinamica
- I precursori :
- Rudolf STEINER (1913) l’antroposifia e l’agricoltura biodinamica
(Steiner, 1975). L’agricoltura biologica ha
le sue origini in Germania, all’inizio del secolo. Essa nasce della
teoria filosofica di Steiner, il quale considera l’uomo facente parte
d’un equilibrio cosmico, da dover interpretare per poter vivere in
armonia con il mondo che lo circonda. Con l’antroposofia Steiner dice che
l’uomo deve trovare un
equilibrio tra lo spirituale e il materiale. H. Pfeiffer applica queste
teorie all’agricoltura e da vita all’agricoltura biodinamica, una branca
dell’agricoltura biologica ancora più rispettosa dell’ambiente. Essa si sviluppa poi dagli
anni venti in Germania, Svizzera, Inghilterra, Paesi Bassi e Danimarca. Attualmente questa corrente e
commercializzata dalla marca Demeter ® (che personalmente acquisto
abbastanza regolarmente). Oggigiorno l’agricoltura biodinamica si
differenzia dalle altre correnti per un certo idealismo, un lato
filosofico e delle pratiche culturali specifiche che associano alle
attività agricole i cicli lunari e astrali.
- H. MULLER (1930), uomo politico svizzero che
sviluppò una nuova corrente di pensiero. I suoi obiettivi erano sia
economici che sociopolitici: autarchia dei produttori, breve circuito tra
produzione e consumo. Un medico Austriaco Hans Peter RUSH[9]
concretizza queste idee in un metodo basato sull’utilizzazione massima
delle risorse rinnovabili.
- Sir
Albert HOWARD e l’Inghilterra degli anni ’40,
l’agricoltura organica. Dopo la seconda guerra
mondiale questo movimento, che prenderà il nome successivamente di Soil Association, pone al centro
dell’agricoltura l’humus, che diviene il fattore principale. Si
pone massima importanza alla fertilità della terra, si studiano quali
sono i fattori che la mantengono “viva” e capace di apportare non solo
“crescita alle piante”, ma anche salute e forza. Si basa sulle teorie che
Sir Albert HOWARD scrisse nel suo “Testamento
Agricolo” del 1940 (Howard,
1953).
- Lo
sviluppo :
- Gli anni ’50, la
bipolarizzazione. Durante questi anni l’agricoltura biologica emerge in Francia
grazie a medici e consumatori preoccupati per gli effetti degli alimenti
sulla salute umana. Molto presto si delineano due direzioni: una legata
ad alcune aziende commerciali che approvvigionano i produttori (la
società Lemaire-Boucher) e
l’altra indipendente da tutte le logiche commerciali (l’associazione Nature et Progrès)[10].
- A partire dal 1968, ci fu un cambiamento ideologico e
una sensibilizzazione crescente per l’ecologia. Il contesto
socioculturale e i movimenti ideologici hanno largamente influenzato lo sviluppo dell’agricoltura biologica.
- Gli anni ’70 :caratterizzati dai movimenti contestatori, dagli ecologisti attivisti e dalla strutturazione dell’agricoltura biologica. Il movimento ecologico moderno si sviluppa, incoraggiato dallo shock petrolifero del 1973. In Inghilterra la Soil Association crea il suo logo; parallelamente anche la fase pratica viene meglio definita e ufficialmente organizzata e tutelata con garanzie e controlli. In Francia, gli agricoltori biologici si uniscono in seno ad un sindacato professionale, raggruppati in un federazione tale quale la FNAB (Fédération Nationale d’Agriculteurs Biologiques), in Italia si costituisce l’AIAB Le principali organizzazioni nazionali di agricoltura biologica nel mondo si raggruppano in seno ad una federazione internazionale: l’IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements).
- Gli anni ’80 e ’90 : aumento della domanda di prodotti
biologici e scoperta da parte del grande pubblico. Una forte domanda di
prodotti biologici e l’arrivo dei paesi in via di sviluppo nel mercato
globale allargano definitivamente il mercato biologico, così come la
varietà dei prodotti. Inoltre si sta assistendo all’uscita del mercato di
prodotti biologici dalla sua posizione marginale.
4.1.3. Territorialità e sostenibilità
Attraverso l’analisi della
territorialità, avevamo meglio compreso l’importanza dell’agricoltura
tradizionale come elemento caratterizzante dell’ecogenesi territoriale (cfr.
par 1.1.2. e 3.1.2.), essa modella in modo specifico i paesaggi. Il principale
fattore produttivo di tale forma è il lavoro, dell’uomo (feudalesimo, schiavitù
o liberi contadini) e degli animali, che nel tempo ha amplificato la
specificità territoriale già esistente prima dell’invenzione dell’agricoltura.
Abbiamo altresì visto che pratica e conoscenza erano tuttavia percepite come un
tutt’uno.
Successivamente abbiamo indagato
sulla deterritorializzazione data dall’agricoltura moderna (cfr. par 3.1.3.),
soprattutto là dove essa si era potuta sviluppare nella sua forma più pura,
rendendo i paesaggi agricoli uniformi e conformi. Abbiamo anche sottolineato il
forte impatto che essa ha sull’ambiente. Il fattore produttivo “nuovo”
dell’agricoltura moderna è diventato il capitale (macchinari, agenti chimici,
ecc…), sia nei paesi socialisti o sia in quelli capitalisti. Con l’agricoltura
moderna si ha la definitiva scissione tra pratica e conoscenza, quest’ultima si
trasferisce dal paesaggio rurale (tradizione) ai laboratori di R & S
(scienza).
Abbiamo poi considerato, attraverso
l’esempio dell’Italia, tutti quei casi nei quali modernità e tradizione si sono
compenetrate, dando alla territorialità un significato più ampio e specifico
(cfr. par 3.1.4.), un significato nel quale agricoltura tradizionale e moderna
partecipano, su due piani diversi (locale e globale), a rendere l’agricoltura
ancora più ricca e ancora più varia. In Italia convivono il modello
nord-atlantico e quello mediterraneo. Anche i fattori produttivi capitale e
lavoro si sono equilibrati tra loro; a riprova di ciò consideriamo l’alta
percentuale degli attivi nel settore primario rispetto agli altri paesi
sviluppati, intorno al 5,5 %, con punte regionali di oltre il 10%.
Andremo a considerare, adesso, il
caso dell’agricoltura sostenibile (che non esiste ancora nel suo significato
più ampio), come insieme di forme agricole che garantiscono a tutte le
generazioni presenti e future la sopravvivenza e la possibilità di godere della
multifunzionalità (cfr. par 4.3.1.).
La definizione classica
d’agricoltura sostenibile definisce: “Un’agricoltura che permette di fornire
indefinitivamente i beni e i servizi che gli sono demandati, a dei costi
economici e ambientali socialmente accettabili” (OCDE,1997), vale a dire con
una produttività del lavoro e della terra elevata, nella quale siano state
computate anche le esternalità negative. Per semplicità considereremo come
esternalità anche gli effetti esterni.
Poniamo che P sia la produzione
annua, L sia il lavoro nel settore primario espresso in Unità di Lavoro Annuale
(ULA), T sia la quantità di terra espressa in ettari di Superficie Agricola
Utile (SAU), E siano le esternalità negative annuali, PSL sia la produttività
sociale unitaria media del lavoro e PST sia la produttività sociale della
terra. Avremo:
- PSL
= (P-E) / L = P/L – E/L sia P/L
la produttività del lavoro
- PST
= (P-E) / T = T/L – E/L sia T/L
la produttività della terra
Queste equazioni misurano il grado
di autonomia di un sistema territoriale chiuso (def. di territorialità,
Raffestin, cfr par 1.1.2.). Sia C il consumo di prodotti agricoli presente e
futuro. Una prima condizione necessaria di sostenibilità è che la produzione,
dedotte le esternalità, soddisfi i consumi presenti e futuri. Dunque non
diventa più un problema di massimizzazione della produzione, ma:
- PSL·L
= C ovvero C = P – E
- PST·T
= C ovvero C = P – E
L’agricoltura moderna ha una PSL
molto più alta dell’agricoltura tradizionale. Abbiamo visto con l’avvento della
meccanizzazione quanto il lavoro di ogni singolo contadino sia stato
massimizzato. Parallelamente la PST non ha seguito la stessa dinamica,
soprattutto se il confronto si effettua tra un’agricoltura tradizionale come
quella cinese e un’agricoltura moderna estensiva, con notevoli esternalità
negative (cfr. par 2.4.2.). Con la transizione dall’agricolura tradizionale a
quella moderna la PSL ha conosciuto un notevole aumento, mentre la PST talvolta
è anche diminuita.
La territorialità,
abbiamo visto, esprime le relazioni che intercorrono tra i soggetti e
l’ambiente, tramite l’aiuto di mediatori come l’agricoltura, nel tentativo di
ottenere la più grande autonomia possibile, compatibile con le risorse del
sistema (Raffestin 1986, cfr. par 1.1.2.). Queste equazioni misurano, dunque,
il grado di autonomia del sistema territoriale, compatibile con le risorse del
sistema. Ma con l’ipotesi della sostenibilità il sistema territoriale si
estende anche nel tempo (generazioni future) ed è per questo che le esternalità
devono essere internalizzate.
Prendiamo la definizione di esternalità del Baumol (1965), il quale parla “d’interferenza prodotta dalle attività di un soggetto sulla funzione di utilità di un altro soggetto, senza che per questo avvenga una qualsiasi transazione economica”. Le esternalità possono essere considerate “the dark side (la faccia scura)” dell’economia; esistono (che si creda o meno nell’effetto serra), influiscono non solo nell’economia, ma non si vedono ed è difficile darle un valore.
La definizione di territorialità del Raffestin, viene
quindi arricchita dell’ipotesi della sostenibilità ovvero, si estende nel tempo
e diventa: “l’insieme
delle relazioni che intercorrono nel tempo e nello spazio, tra i soggetti e
l’ambiente tramite l’aiuto di mediatori come l’agricoltura, nel tentativo di
ottenere la più grande autonomia possibile, compatibile con le risorse del
sistema”. L’agricoltura è il mediatore tramite il quale i soggetti nel tempo e
nello spazio intrattengono delle relazioni, e sono proprio le esternalità (cfr.
par 5.3.) a costituire tali relazioni nel tempo.
In realtà, altre azioni
costituiscono il vettore nel tempo di tali relazioni, giacchè anche il lavoro
di selezione delle specie, il mantenimento e il dissodamento delle terre, le
bonifiche, i terrazzamenti, le modifiche dei corsi d’acqua, hanno apportato
benefici che si estendono nel tempo, e che in qualche modo si possono
ricondurre ad esternalità positive. Attraverso le esternalità e le migliorie
(che possono essere considerate esternalità temporali positive), l’agricoltura
si fa messaggera nel tempo e nello spazio di tali relazioni.
Oggetto di tali
relazioni sono i soggetti e l’ambiente. Il fine è quello di ottenere la più
grande autonomia possibile, ma tale autonomia deve essere compatibile con le
risorse del sistema, da qui l’esigenza di migliorare l’efficienza sociale (cfr
par 4.4.2.), che è un aspetto della sostenibilità, e che si traduce nella
verifica delle seguenti equazioni:
- PSL
= C/L ossia i consumi per ULA
(Unità di Lavoro Annuale)
- PST
= C/T ossia i consumi per ettaro di
SAU (Superficie Agricola Utile)
Tuttavia, sia A il
numero totale di abitanti del sistema; L/A = a, cioè il coefficiente delle Unità
Lavorative degli addetti in agricoltura rispetto alla popolazione totale,
compreso tra 0 e 1; sia T/S = b, cioè il coefficiente della
Superficie Agricola Utile rispetto alla superficie totale, anch’esso compreso
tra 0 e 1, allora:
·
PSL
= C/aA
ossia il consumo pro capite, aggiustato col coefficiente α.
·
PST
= C/bS
ossia il consumo per ettaro di superficie totale, aggiustato col
coefficiente β.
Andiamo a vedere cosa
succede nella transizione da un sistema territoriale ad agricoltura
tradizionale ad uno ad agricoltura moderna: il coefficiente a si riduce notevolmente, vista la diminuzione
degli addetti nel settore primario, inoltre aumentano i consumi (C) e la
popolazione (A) e anche la PSL aumenta. La stessa cosa non si può dire per la
seconda equazione, in quanto b diminuisce appena (PNUE, 2002) e
l’aumento di PST è frenato dall’aumento delle esternalità (E).
Si arriva quindi su una più precisa definizione di territorialità applicata all’agricoltura sostenibile: “L’insieme di relazioni che intercorrono tra i soggetti presenti e futuri e l’ambiente, attraverso l’agricoltura, nel tentativo di ottenere la più grande autonomia possibile, attraverso l’aumento di produttività sociale delle risorse, terra e lavoro”. Dunque si parla di un insieme di relazioni tra i soggetti e l’ambiente, ma anche di relazioni che partono dai soggetti e arrivano ai soggetti stessi, oppure partono dall’ambiente per arrivare all’ambiente stesso. Sono relazioni che creano e fanno evolvere il sistema, nel tentativo di una più grande autonomia possibile.
Come ci ricorda lo
stesso Raffestin (1986): “Il paradigma della territorialità apre una serie di
problematiche, dimenticate dalla maggioranza degli studi sullo sviluppo locale,
nonostante che essi siano direttamente legati a dei problemi pratici molto alla
moda, come lo sviluppo sostenibile e la sopravvivenza delle identità locali.
Queste problematiche nascono da una contraddizione: lo sviluppo di un
territorio si fonda sulla percezione che gli attori si rappresentano di quel
luogo (Berque 1980), ma lo sviluppo di un territorio (che trasforma
l’ecosistema) avviene anche aldilà di qualsiasi rappresentazione degli attori”.

Figura 4.1.
Evoluzione dell’agricoltura
Estendendo
all’agricoltura quest’affermazione, ci rendiamo conto che la relazione tra uomo
e ambiente non è univoca e che l’agricoltura dovrebbe essere il risultato
dell’incontro dei due, in maniera biunivoca. Nei casi in cui l’uomo si è
imposto sulla natura, senza “ascoltarla” (monocultura intensiva, agricoltura di
speculazione, ma anche alcune forme d’agricoltura tradizionale), si sono avuti
i risultati peggiori dal punto di vista della sostenibilità; ma anche dove
l’ambiente si è imposto sull’uomo (pestilenze, alluvioni, malattie relative
agli animali, siccità, inquinamento già presente), in parte come reazione all’azione
dell’uomo, la sostenibilità si rivela più lontana. Prendiamo come esempio il
recente caso d’epidemia sugli animali, la “febbre dei polli” e ci rendiamo
conto che certi eventi, che alterano notevolmente l’ecosistema, avvengono
aldilà di qualsiasi rappresentazione degli attori (v. sopra).
Detto questo possiamo
adesso avere un’idea più chiara e schematica dell’evoluzione dell’agricoltura,
alla luce della territorialità. Nella figura 4.1. ho rappresentato l’evoluzione
dell’agricoltura cercando d’inserire i fattori che l’hanno creata, sviluppata e
la fanno tendere verso la sostenibilità. La sostenibilità, infatti, non va
ricercata soltanto nel futuro e nei nuovi progetti, ma soprattutto in una
migliore conoscenza del passato, delle forme d’agricoltura tradizionale e di
come esse si sono incontrate con quelle moderne, in altre parole l’agricoltura
sostenibile non è una nuova forma di agricoltura, bensì un’agricoltura che si
fonda su un migliore incontro tra agricoltura tradizionale e agricoltura
moderna.
4.2. Transizione dell’agricoltura in
Europa: aspetto politico
4.2.1. Gli anni ‘90
Il cammino dell’agricoltura negli ultimi tre
decenni può dunque essere riassunto come “un percorso che prima portava l’uomo
all’ambiente e ora conduce dall’ambiente all’uomo” (Grillotti, 1992). Nel 1985
in Europa si pubblicò il “Libro Verde”, nel quale l’UE riconosceva il carattere
multifunzionale dell’agricoltura per la conservazione e la tutela del
territorio e delle risorse agroalimentari.
Già negli anni ’90 la politica agricola europea
aveva indirizzato il suo interesse dall’economia all’ecologia, dalla produzione
all’ambiente. Il “Quinto programma d’azione ambientale” del 1992 e il Trattato
sull’Unione Europea” considerava l’agricoltore come il “custode” dei suoli e dell’ambiente
rurale. Nel rispetto delle risorse territoriali e nel tentativo di recupero
ambientale, l’intervento legislativo per il settore primario dei paesi europei
prevedeva:
·
la
riduzione del sostegno dei prezzi e la compensazione per ettaro alle aziende produttrici;
·
l’obbligo
del ritiro dei seminativi e l’indennizzo delle superfici lasciate a riposo (set-aside);
·
gli
incentivi per l’eliminazione dei mezzi chimici e per la destinazione, almeno
ventennale, dei terreni un tempo coltivati a scopi non agricoli (parchi,
riserve, ecc.);
·
il
sovvenzionamento delle spese di forestazione e il compenso annuale per il
mancato guadagno;
·
il
prepensionamento a 55 anni dei coltivatori disposti a lasciare i loro terreni
ad uno sfruttamento non intensivo.
La politica del set-aside, di fatto,
ha escluso le imprese che producono meno di 92 tonnellate di cereali (20 ha di
superficie) dagli indennizzi. I piccoli proprietari, non potendo accedere a
tale tipo di aiuti, si trovano in una posizione competitiva sfavorevole,
inoltre si vedono anche congelato o addirittura ridotto il sostegno alla
produzione diversificata.
In Italia la politica dei prezzi ha
premiato le grandi aziende estensive altamente meccanizzate, contraddicendo
nell’applicazione i principi che la muovevano. Anche sotto l’aspetto geografico
è mancata una conoscenza approfondita e accurata della realtà geografica e
della territorialità, necessaria al fine di permettere alle differenze
geografiche di esprimere la loro sinergia.
4.2.2. La recente riforma della PAC (Luglio 2003)
Dopo tre negoziati ministeriali
durati quindici giorni e alla conclusione di diciassette ore ininterrotte di
trattative, nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno, i Ministri
europei dell'agricoltura (con il solo parere contrario della delegazione
portoghese) hanno approvato una radicale riforma della politica agricola comune
(PAC), che rivoluzionerà il modo in cui l'Unione europea sostiene il settore
agricolo.
Nel commentare la decisione, il
commissario europeo all'agricoltura Franz Fischler ha dichiarato: "Si
tratta di una decisione storica, che segna l'inizio di una nuova era. La nostra politica agricola cambierà
profondamente. Oggi l'Europa si è dotata di una politica agricola nuova,
moderna ed efficiente. Il
grosso dei pagamenti diretti non sarà più legato alla produzione. Si tratta di
una politica che contribuirà a stabilizzare i redditi degli agricoltori e
permetterà loro di produrre ciò che chiede il consumatore. Dal canto loro, consumatori e contribuenti
beneficeranno di una maggiore trasparenza e di un miglior rapporto
qualità/prezzo. Questa riforma manda anche un segnale forte al resto del
mondo”.
Ancora è presto per poter dare un
parere sulla reale positività di tale riforma, soprattutto, dal punto di vista
dei risultati, dunque ci limiteremo ad enunciare quello che è il nuovo
programma. Gli elementi salienti della
riforma della PAC sono, in breve:
·
Pagamento unico per azienda agli agricoltori
dell'UE, indipendente dalla produzione (disaccoppiamento); alcuni elementi
degli aiuti accoppiati possono essere mantenuti, in misura limitata, per
evitare l’abbandono della produzione.
·
Pagamento condizionato (eco-condizionalità)
al rispetto delle norme in materia di salvaguardia ambientale, sicurezza
alimentare, sanità animale e vegetale e protezione degli animali, come pure
all'obbligo di mantenere la terra in buone condizioni agronomiche ed
ecologiche.
·
Potenziamento della politica di sviluppo rurale, cui verranno
destinati maggiori stanziamenti, nuove misure a favore dell'ambiente, della
qualità e del benessere animale, nonché per aiutare gli agricoltori ad
adeguarsi alle norme di produzione UE a partire dal 2005.
·
Riduzione dei pagamenti diretti alle grandi aziende (modulazione)
allo scopo di finanziare la nuova politica di sviluppo rurale.
·
Introduzione di un meccanismo di disciplina finanziaria inteso ad impedire che venga superato il bilancio
agricolo fissato fino al 2013.
·
Ritocchi
alla politica dei mercati agricoli:
1. Riduzione asimmetrica dei prezzi nel settore lattiero-caseario: il prezzo d’intervento del burro sarà ridotto del 25% in quattro anni, il che rappresenta un ulteriore taglio del 10% rispetto all’Agenda 2000, mentre per il latte scremato in polvere è stata decisa una riduzione del 15% in tre anni, come convenuto in Agenda 2000.
2. Incrementi mensili nel settore dei cereali dimezzati, con il mantenimento dell’attuale prezzo d’intervento.
3. Riforme nei
comparti riso, frumento duro, frutta in guscio, patate da fecola e foraggi
essiccati.
Con la nuova PAC un pagamento unico per azienda sostituirà la maggior parte dei premi previsti dalle varie organizzazioni comuni di mercato; inoltre, la maggior parte dei pagamenti diretti dell'UE non sarà più legata alla produzione, ma basata su un importo riferito al periodo compreso tra il 2000 e il 2002.
Gli Stati membri che ritengono necessario ridurre al minimo il rischio di abbandono dei terreni agricoli, potranno mantenere fino al 25% degli attuali pagamenti per ettaro nel settore dei seminativi, legati alla produzione. Come alternativa, il 40% dei premi supplementari per il frumento duro può essere mantenuto legato alla produzione. Per quanto riguarda il settore delle carni bovine, gli Stati membri possono decidere di mantenere fino al 100% dell'attuale premio per le vacche nutrici e il 40% del premio alla macellazione, oppure mantenere fino al 100% del premio alla macellazione e il 75% del premio speciale per i bovini maschi. Un massimo del 50% dei premi per pecore e capre, incluso il premio supplementare per le zone svantaggiate, può rimanere legato alla produzione. Questo ci da un’idea che la Politica Agricola Comune sembra aver qualche timore in più per il passaggio dai contributi legati alla produzione a quelli all’ecologia, rispetto alla Riforma in Svizzera, il che si giustifica in parte a causa della grandezza del territorio europeo rispetto a quello svizzero e alla diversa situazione economico-finanziaria.
Gli Stati membri potranno erogare ulteriori contributi ai propri agricoltori fino a un massimo del 10% dei pagamenti unici per azienda, per incoraggiare colture specifiche che rivestono importanza per l'ambiente, la produzione di qualità e la commercializzazione.
Ma andiamo a vedere le disposizioni a favore dell’ambiente e che meritano di essere considerate un buon punto di partenza verso la sostenibilità:
· Norme in materia di tutela ambientale, sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali. La piena erogazione del pagamento unico per azienda e di altri pagamenti diretti sarà subordinata al rispetto di un certo numero di norme vincolanti in materia ambientale, di sicurezza alimentare e fitosanitaria e di benessere e salute degli animali. Anche la condizionalità ecologica contribuirà al mantenimento del paesaggio rurale. In caso di inadempimento dei requisiti di condizionalità ecologica, i pagamenti diretti verranno ridotti proporzionalmente al rischio o al danno causato.
· Un nuovo sistema di "consulenza per le aziende agricole". Il sistema di consulenza aziendale sarà facoltativo per gli Stati membri fino al 2006. A partire dal 2007 gli Stati membri dovranno offrire un sistema di consulenza aziendale ai propri agricoltori. La partecipazione di quest'ultimi avverrà su base volontaria. Nel 2010, sulla scorta di una relazione della Commissione sul funzionamento del sistema, il Consiglio deciderà se rendere obbligatorio per gli agricoltori il sistema di consulenza. Questo servizio fornirà, attraverso un meccanismo di feedback, consulenza agli agricoltori su come applicare le norme e gli esempi di buone pratiche nel processo produttivo. Gli audit aziendali comporteranno inventari strutturati e regolari e la contabilità dei flussi di materiali e dei processi all'interno dell'azienda considerati importanti per determinate finalità (tutela dell'ambiente, sicurezza alimentare e benessere degli animali). Gli aiuti per gli audit aziendali verranno finanziati nel quadro delle misure di sviluppo rurale.
· Sviluppo rurale. Le risorse UE a disposizione dello sviluppo rurale verranno significativamente aumentate e la portata del sostegno allo sviluppo rurale da parte della UE verrà ampliata mediante l'introduzione di nuove misure. Tali cambiamenti entreranno in vigore nel 2005. Spetterà agli Stati membri e alle regioni decidere se inserire queste misure nei loro programmi di sviluppo rurale.
· Incentivi alla qualità. Verranno versati dei contributi agli agricoltori che partecipano a programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e dei procedimenti di produzione (max 3.000 € e 5 anni). Verranno altresi incentivate le attività di informazione dei consumatori su tali prodotti fino ad un massimo del 70 % dei costi del progetto.
· Aiuti temporanei di adeguamento alle nuove norme. Per aiutare gli agricoltori ad adeguarsi alle rigorose norme previste dalla legislazione comunitaria nei settori dell’ambiente, della sanità pubblica, animale e vegetale, è previsto un aiuto temporaneo e decrescente.
· Benessere degli animali. Sono previste sovvenzioni a favore degli agricoltori che s’impegnano, per un periodo di almeno cinque anni, a migliorare le condizioni di vita degli animali. L’aiuto sarà proporzionale alle spese supplementari da essi sostenute (max 500 € per capo di bestiame).
· Sostegno agli investimenti per i giovani agricoltori. Ci sarà un aumento degli aiuti ai giovani agricoltori.
Per finanziare le misure addizionali di sviluppo rurale saranno ridotti del 3% (per il 2005) i pagamenti diretti alle aziende di maggiori dimensioni. Tali riduzioni saliranno al 4% nel 2006, fino al 5% per il periodo 2007-2013 e saranno giustificate anche dai vantaggi che beneficiarono le imprese di una certa dimensione negli anni ’90, grazie alla politica del set-aside (cfr. per. 4.1.1.).
4.3.
Cambiamento del sistema territoriale svizzero per la riduzione dell’impatto
sull’ambiente nell’agricoltura
Nel
1900, il 31% delle persone attive lavoravano nel settore agricolo, oggi esse
sono appena il 3% (Italia 5,5%). I contadini sono diventati una piccola
minoranza in una societá di servizi. Tuttavia questa minoranza gestisce,
utilizza e cura il 40% del territorio nazionale. La Svizzera è un paese alpino,
il clima e la topografia favoriscono l’allevamento bovino, infatti i contadini
svizzeri producono essenzialmente latte
e carne, anche se in certe regioni l’agricoltura permette di ottenere anche
ottimi raccolti di cerali.
Nel
1995, la taglia media delle aziende agricole in Svizzera era di 14 ha di SAU
(superficie agricola utile), rispetto ai 41 ha della Francia e ai 31 ha della
Germania e ai 15 ha dell’Austria.
4.3.1.
Aspetto politico: la riforma agraria
La politica
Svizzera già da tempo riconosce il carattere multifunzionale
dell’agricoltura cioè:
·
Alimentare la popolazione: quasi 2/3 delle derrate alimentari consumate sono
prodotte in Svizzera.
·
Conservare la diversità biologica: numerose specie animali e vegetali vivono
nell’habitat agricolo e sono quindi sotto la protezione dei contadini.
·
Mantenere una base genetica della produzione
alimentare: la
diversità genetica degli animali d’allevamento e delle piante coltivate
costituisce una base sulla quale dipende l’esistenza dell’umanità. Le banche
del seme non possono in alcun modo sostituire la selezione naturale dei
contadini, come custodi della diversità delle razze e delle specie.
·
Offrire uno spazio ricreativo: un bisogno fondamentale dell’uomo moderno quello di
passare del tempo in contatto con la natura. L’agricoltura mantiene e preserva
i paesaggi delle praterie e dei campi in prossimità dei centri abitati.
·
Assicurare un’occupazione decentrata sul territorio e
proteggere i paesaggi di montagna nelle regioni turistiche: la mucca resta il segno distintivo della Svizzera,
paese di vacanza. Infatti i paesaggi alpini sono caratterizzati dall’economia
rurale ed essa ben s’inserisce nell’insieme dell’attrattive turistiche delle
regioni di montagna.
Qui,
come in altri paesi (UE cfr par 3.4.), per decenni l’agricoltura è stata
sostenuta da ingenti capitali statali, sotto forma di una politica dei prezzi
alla produzione, ma tale politica ha mostrato sin dagli anni ‘70 i suoi limiti
sia di natura ecologica, che di natura economica :
·
Costi incontrollabili: la politica dei prezzi aveva come primo effetto quello di
perdita di concorrenza. I prodotti agricoli, che lo Stato acquistava dai
contadini a prezzo garantito, venivano venduti sul mercato a prezzi inferiori,
causando quindi delle perdite. Nel 1993, solo la valorizzazione del latte costò
alle casse dello Stato 1,1 miliardi di franchi, circa 750 milioni di euro.
·
Misure protezionistiche in favore dell’agricoltura
sempre meno accettate sul piano internazionale: la Svizzera, in quanto paese esportatore, è interessata alla
liberalizzazione del commercio.
·
Problemi ambientali sempre più visibili
nell’agricoltura: nitrati
nell’acqua potabile, eutrofizzazione dei laghi, emissioni d’ammoniaca
nell’aria, contribuzione al cambiamento climatico, residui di sostanze tossiche
nel suolo e l’erosione sono stati la dannosa conseguenza dell’aumento delle
rese in agricoltura. Inoltre il tentativo di controllare i problemi ambientali
con obblighi e divieti legislativi non portò ai risultati auspicati.
·
Impoverimento della flora e fauna: il paesaggio rurale tradizionale degli anni 50 era
suddiviso in maniera capillare e ricco di nicchie. Per razionalizzare la
produzione, venne trasformato in un territorio agricolo che permetteva
l’impiego di macchinari, ciò provocò la riduzione di ben 2/3 della superficie
di ambienti naturali ecologicamente in equilibrio.
·
Grande differenza di prezzo rispetto all’estero: dal 30 al 60% in più, ripetto ai prezzi europei, il
che ha creato il fenomeno del “turismo della spesa”, con un impatto di 2
miliardi di franchi svizzeri, pari ad 1/10 delle spese complessive per le
derrate alimentari.
·
Proliferazione di regole e leggi nel settore
alimentare: la politica
dei prezzi alla produzione provocò una moltiplicazione eccessiva dei
regolamenti e degli ordinamenti statali in tutto il settore agroalimentare.
Conseguentemente
il 9 Giugno 1996 la popolazione svizzera ha approvato, con una maggioranza del
77,6%, un nuovo articolo costituzionale sull’agricoltura, che prevede, per
l’agricoltura, il concetto di multifunzionalità per uno sviluppo sostenibile
(v. sopra). La nuova politica agricola si basa su due punti: da una parte una
produzione agricola sostenibile rispondente all'esigenze del mercato e
dall’altra il mantenimento e la conservazione del paesaggio e delle risorse
naturali a titolo di patrimonio pubblico.
Per
ottenere questo obiettivo inizialmente si sono soppresse le politiche dei
prezzi, riducendole del 20% rispetto ai primi anni 90. Ciò ha favorito i
consumatori, ma ha ridotto drasticamente il reddito dei contadini. Tuttavia per
compensare (per lo meno in parte) tali perdite sono stati aumentati i pagamenti
diretti, legati a determinate prestazioni ecologiche. Queste misure hanno
permesso di migliorare significativamente gli standard ambientali dell’agricoltura
svizzera.
La seconda tappa consiste nel mantenere tali
standard, migliorando la competitività dell’agricoltura. Sicuramente la
riduzione degli interventi statali ha dato maggior libertà di movimento ai
contadini, ai quali è stato accordato lo statuto di imprenditori indipendenti.
Quindi, il passaggio dalla politica dei prezzi alla
produzione (incentivi indiretti e diretti) agli incentivi diretti, condizionati
al rispetto di certi parametri ecologici (eco-condizionalità, cfr nuova PAC par
4.2.2.), ha aperto un nuovo mercato e una nuova opportunità, quello dello
standard ecologico. Lo standard ecologico è il nuovo criterio con il quale è
possibile ricevere gli incentivi.
Oggi,
sono sempre più numerosi i consumatori che ricercano la qualità, una qualità
intesa in senso pieno, diretta oltre che al gusto e alla genuinità, anche al
rispetto della natura e degli animali. In quest’ottica, una clientela sempre
crescente è disposta a pagare un prezzo maggiore per la qualità. Affinchè i
beni prodotti in modo sostenibile possano trovare degli acquirenti sul mercato,
devono essere riconoscibili e rintracciabili, quindi un punto centrale della
riforma agraria (conseguente al voto del 9 Giugno 1996) è una regolamentazione
chiara sulla caratterizzazione dei prodotti. Le denominazioni di origine e le
informazioni sui metodi di produzione sono protette e la legge garantisce la
certificazione e il controllo.
La
riforma mantiene quindi i pagamenti diretti, in quanto nel commercio agrario
non vige alcuna verità dei costi. I pagamenti vengono riorientati non più alla
massimizzazione della produzione, ma alla riduzione delle esternalità negative,
condizione necessaria per massimizzare l’efficienza sociale. In altri termini
se i reali costi sociali (cioè quelli che comprendono le esternalità negative)
fossero calcolati nel prezzo di vendita, i prodotti Bio diventerebbero molto
più competitivi o addiririttura meno costosi.
La
riforma della politica agricola si fonda sulla costituzione del ruolo
multifunzionale dell’agricoltura, essa ha impresso un nuovo orientamento
giuridico agli obiettivi della Confederazione in materia di politica dei
redditi. Conformemente all’art. 5 L agr: “I provvedimenti di politica agricola
hanno lo scopo di permettere alle aziende con una gestione ecologicamente
sostenibile e redditizia di conseguire in media su vari anni redditi
comparabili a quelli della rimanente popolazione attiva della stessa regione. I
nuovi cardini della politica reddituale sostituiscono il principio del salario
paritetico ancorato alla vecchia legislazione (OFAG, 2001)”.
4.3.2. Aspetto economico. I prodotti biologici
Uno
sforzo e una scommessa sono stati compiuti anche nella commercializzazione, se
si pensa che il gruppo COOP Svizzero (fatturato di 11 miliardi di franchi, 1000 punti vendita, secondo distributore in Svizzera
e primo per i prodotti Bio) realizza, grazie ad una politica di promozione e
vendita dei prodotti Bio, un tasso di crescita annuo del 40 % in questo
settore. Tra il 1993 e il 1998 COOP ha decuplicato le sue vendite di prodotti
Bio. Già negli anni ’80, Felix Wehrle (responsabile del progetto Bio NATURAplan presso
COOP) rifletteva sulle possibiltà della commercializzazione su larga scala dei
prodotti Bio. Ancora nel 1993, quando il progetto NATURAplan è stato lanciato,
lo scetticismo era forte e i contadini che si dirigevano verso la produzione
biologica guadagnavano meno degli altri. Tuttavia, tra il 1993 e il 1998, COOP
ha decuplicato le sue vendite di prodotti Bio. Nel 1998 la cifra d'affari dei
prodotti NATURAplan ha superato i 320 milioni di franchi (210 milioni di euro),
registrando un aumento del 45% rispetto all'esercizio precedente. Inoltre COOP
controlla direttamente la qualità dei prodotti provenienti dall’agricoltura
biologica e dall’allevamento. La gamma NATURAplan si compone esclusivamente di
prodotti sottoposti alle severissime norme di Bio Suisse. Il latte Bio venduto
da COOP occupa il 30 % del volume complessivo e 2 uova vendute su 5 portano il
label NATURAplan[11]. Quasi
tutti i prodotti alimentari COOP a breve conservazione rispondono ai criteri
della produzione integrata.
Il
mercato svizzero della grande distribuzione è oligopolizzato da due cooperative
(Migros e COOP) e anche Migros ha sviluppato una buona commercializzazione di
prodotti biologici e a produzione integrata. La volontà di passare ad
un’agricoltura ecologica si fa sentire anche nella grande distribuzione, il che
ci dà la conferma della sua economicità.
4.3.3.
Aspetto produttivo: una produzione rispettosa
dell’ambiente
In
Svizzera l’ordinanza sull’agricoltura biologica è in vigore dal 1° gennaio
1998. Essa fissa i criteri che devono essere soddisfatti affinchè un prodotto
possa essere definito Bio. Questi rigorosi parametri si applicano alla
produzione, alla trasformazione, alla definizione e al controllo dei prodotti,
conformemente ai termini stessi
dell’ordinanza: “Sono presi in considerazione cicli e processi naturali, è
evitata l’utilizzazione di materie ausiliare e di ingredienti
chimico-sintetici, si rinuncia all'utilizzazione di organismi geneticamente
modificati e dei loro derivati, i prodotti non sono sottoposti a radiazioni
ionizzanti e non vengono utilizzati prodotti irradiati” (cfr. Articolo 3
dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la
designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologiche)[12]. Tale
ordinanza elenca i prodotti fitosanitari e i concimi chimici, oltre che i
prodotti di lavorazione ammessi; inoltre è presente un elenco dei paesi
importatori e per ogni paese i prodotti ammessi al rango di prodotti biologici
per la Svizzera.
Dal
1999 ogni azienda che vuole ottenere pagamenti diretti deve fornire la prova di
rispettare certe esigenze ecologiche richieste dallo Stato. Queste esigenze
corrispondono ampiamente agli standard della produzione
integrata (PI):
·
Detenzione di animali da reddito
conforme alla specie ammesse dalla legge sulla protezione degli animali.
·
Bilancio di concimazione equilibrato, il
surplus deve potere essere assorbito dal raccolto.
·
Quota adeguata di superfici di compensazione
ecologica, almeno il 7 % (set-aside).
·
Avvicendamento disciplinato delle colture, cioè
alternanza ottimale delle piante nella campicoltura e orticoltura, per la
fertilità del suolo e la salute delle piante.
·
Protezione adeguata del suolo, riducendo
il pericolo di erosione e del carico di sostanze chimiche.
·
Utilizzazione mirata dei prodotti per il
trattamento delle piante; i parassiti vengono tenuti a bada dai loro nemici
naturali, che devono quindi essere messi in condizione di esercitare la loro
funzione.
Il
risultato di questa politica è stato che, se nel 1993 soltanto il 14% della
aziende agricole svizzere coltivava la sua superficie agricola secondo i metodi
della produzione integrata, oggi, praticamente tutti contadini dimostrano di
rispettare i parametri ecologici della produzione integrate (v. tab 6 in
appendice), poichè pochi possono permettersi di rinunciare ai pagamenti
diretti. Una espressione tipica tra gli agricoltori è quella di “coltivare le sovvenzioni”. Infatti,
nonostante la riforma agraria, i sussidi in Svizzera sono sempre molto alti, se
si pensa che essi arrivano al 35 % rispetto alla produzione agricola. Una quota
scandalosamente elevata che va contro tutte le leggi della competitività e del
libero mercato, ma che paraddossalmente consente un’allocazione migliore delle
risorse (cfr. par 4.6.) se trattasi di sovvenzioni dirette al rispetto dei
parametri ecologici. Nonostante che le sovvenzioni siano in diminuzione,
rimangono pur sempre molto elevate rispetto agli altri paesi.
Il
rapido passaggio verso la produzione integrata e biologica è avvenuto grazie ai
massicci finanziamenti indirizzati a questo cambiamento. La riforma agraria
sostanzialmente, ha mutato i criteri per ricevere i contributi statali. Nei
prossimi paragrafi, andremo a vedere sia i pagamenti diretti allo standard
ecologico (par 4.4.), sia la netta diminuzione di quelli indiretti (par 4.5.).
Sulla
stessa dinamica “eco-protezionistica”, i contadini possono ricevere pagamenti
diretti in base al programma SRPA (Sortie Régulières en plain air[13]), che consiste
nel portare in estate i propri animali al pascolo e nel garantire almeno 13
uscite mensili in inverno. Esiste ancora il programma SST[14], che promuove sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli
animali: essi vengono tenuti in gruppi, possono muoversi conformemente alle
esigenze della loro specie, dispongono di luoghi di riposo e di possibilità di
occupazione (v. tab 5 in appendice).
Altri contributi federali in favore dell’agricoltura
si trovano nella creazione da parte dei contadini, di superfici di
compensazione ecologica, nelle quali troviamo anche delle nicchie ricchissime
di specie nel territorio agricolo (set-aside). Tali superfici sono costituite da prati sfruttati in modo estensivo,
arboreti da frutto ad alto fusto, maggesi fioriti, siepi e fasce di colture
estensive in campicoltura, che non possono essere concimate e sulle
quali le malerbe sono ben accette. Tali superfici di compensazione hanno già
dato dei buoni risultati, in quanto si è potuto reinserire nel territorio
specie scomparse o a rischio (v. progetto “starna” a cura dell’UFAG, tab 10 in
appendice)[15].
Addirittura,
esistono delle prestazioni supplementari, non riconosciute ricorrendo ai fondi
agricoli, che consistono nel falciare, in maniera rispettosa dell’ambiente, le
torbiere basse e i prati secchi. Nel 1999 la Confederazione ha versato ai
contadini 11 milioni di franchi per questi lavori di manutenzione. Un
contributo analogo è stato versato anche dai singoli Cantoni.
In
Svizzera, dunque, dal 1993 al 1999 la percentuale delle aziende che si dedicano
alla coltivazione biologica è quadruplicata (1999). Nel 1998 era il 7%, oggi
(marzo 2003) tale quota è arrivata a 11% degli agrocoltori, pari a più di 1/10
della SAU (Rapporto Agricolo 2003).
Fare
tutto il possibile per salvaguardare l’ecosistema suolo ed evitare tutto quello
che può danneggiarlo: questi i principi dell’agricoltura biologica. Se
generalmente i fattori che stimolano lo sviluppo dell’agricoltura biologica
sono legati a motivazioni di carattere privatistico (migliore qualità del
prodotto per i consumatori ed economicità per la grande distribuzione e per i
contadini), qui ci troviamo di fronte ad obiettivi socio-ecologici (riguardanti
i benefici sull’intero ecososistema) che, tramite la riforma, completano i
primi.
Ma
riprendiamo in esame i punti chiave dell’agricoltura biologica:
·
Cicli chiusi: i campi devono essere
fertilizzati con concime di fattoria prodotto dagli animali e il bestiame deve
essere nutrito con foraggio coltivato sui campi della fattoria. Ci vogliono
quindi aziende poliedriche con animali e campi da coltivare.
·
Divieto di concimi minerali e di pesticidi artificiali: le malattie delle piante devono essere prevenute
attraverso la selezione delle varietà e la rotazione delle colture, le erbe
infestanti devono essere estirpate meccanicamente. Si concima esclusivamente
con composto e concime di fattoria.
·
Detenzione di animali conforme alla specie: le direttive sono più severe delle leggi sulla
protezione degli animali.
·
Rinuncia ad organismi geneticamente modificati (OGM): le tecnologie ad alto rischio per la salute dell’uomo
e a forte impatto ambientale, non vengono impiegate nella coltivazione
biologica.
“Bio Suisse”[16], l’associazione di riferimento dei contadini che si dedicano
all’agricoltura biologica, disciplina il controllo e la dichiarazione
conformemente all’ordinanza federale sull’agricoltura biologica.
La riforma agraria ha già dato i primi frutti (cfr. par 5.3.2.) ed è in
linea con gli altri paesi in transizione verso l’agricoltura sostenibile:
·
Il consumo di concime diminuisce: l’impiego di concime minerale è in forte diminuzione.
Questa tendenza è particolarmente marcata per quanto riguarda i concimi
contenenti fosforo: dalla metà degli anni ’80 il consumo si è più che dimezzato
(v. tab 2 e 3 in appendice).
·
Le aziende hanno dovuto ridurre il loro effettivo di
animali da reddito: gli oneri
ecologici hanno costretto le aziende agricole a ridurre il numero dei bovini e
dei suini. La diminuzione del quantitativo di concime di fattoria si ripercuote
positivamente sui corsi d’acqua.
·
Il consumo dei prodotti fotisanitari diminuisce: il senso di responsabilità dei contadini svizzeri nei
confronti dei prodotti per il trattamento delle piante è sensibilmente
aumentato, comportando una riduzione del loro impiego.
·
La contrazione delle superfici naturali nel paesaggio
è stata interrotta: nelle
regioni di pianura, nel 1998 sono stati dichiarati 42.500 ettari di superfici
di compensazione ecologica, che corrispondono circa al 6% dell’intero paesaggio
agricolo. Per bloccare la diminuzione delle specie nel territorio agricolo,
sono necessari almeno 65.000 ettari, obiettivo che dovrebbe essere raggiunto
entro un paio di anni, quando ogni azienda agricola dichiarerà in media almeno
il 7% di superficie utile sotto forma di compensazione ecologica (v. fig 9 e
tab 10 in appendice).
·
Le condizioni di detenzione di numerosi animali da
reddito sono migliorate: nel 1998,
il 40% dei bovini delle fattorie svizzere viveva in condizioni conformi alla
propria specie, secondo quanto stabilito dai programmi URA o SSRA (v. tab 7 in
appendice).
·
La Svizzera rispetta gli accordi commerciali
internazionali: riduzione
del 20% del sostegno federale riferito ai prodotti dell’agricoltura, riduzione
del 36% delle sovvenzioni all’esportazione entro l’anno 2000. Questi gli
impegni contratti dalla Svizzera nei confronti dell’Organizzazione mondiale del
commercio.
·
Il reddito dei contadini si è stabilizzato: nonostante la sostanziale riduzione dei prezzi alla
produzione, il reddito dei contadini ha potuto essere mantenuto, anche se ad un
livello più modesto. In rapporto con il resto della popolazione, nel 1998 il
reddito rurale per azienda (senza guadagno accessorio) ammontava a 73.000
franchi (circa 50.000 euro) per le regioni di pianura ed a 50.000 franchi
(circa 33.000 euro) per quelle di montagna.
4.4. L’agricoltura
svizzera: l’importanza del riorientamento degli incentivi diretti
(eco-condizionalità).
4.4.1.
Aspetto ambientale
La
Svizzera, come l’Europa, dimostra quindi di essersi resa conto degli errori
commessi in passato e d’impegnarsi per trasformarli in opportunità per
un’agricoltura sostenibile. Il cambiamento di rotta è già avvenuto e gli sforzi
sostenuti in questa nuova direzione hanno coinvolto tutta la popolazione, che
con il referendum ha scelto un’agricoltura più autonoma dai capitali statali.
La Svizzera si sta dirigendo verso un’agricoltura sostenibile, nonostante che
la strada da fare sia ancora molta.
Contraddittoriamente,
ciò che ha permesso alla Svizzera questo rapido passaggio sono stati appunto
gli ingenti capitali statali che proteggono l’agricoltura. Ed è proprio da
questi capitali che si cerca di ridurre la dipendenza. Si è cercato,
interpretando la volontà popolare, di indirizzare tali capitali verso
un’agricoltura ecologicamente migliore.
Ci
sarebbe da chiedersi se fosse stato possibile invertire così repentinamente la
rotta senza la presenza delle sovvenzioni alla produzione trasformate in sovvenzioni all’ ecologia. Teniamo
presente che le sovvenzioni all’agricoltura in Svizzera sono le più alte tra
tutti i paesi industrializzati, l’obiettivo è quello di ridurle al minimo, ma
inizialmente esse sono state necessarie per indurre questa inversione di rotta.
Le
aziende che veramente si impegnano verso un’agricoltura più rispettosa
dell’ambiente sono quelle che ricevono i pagamenti diretti e le sovvenzioni
maggiori. Ogni sforzo
aziendale verso una riduzione dell’impatto ambientale è premiato con pagamenti
diretti maggiori. Questo spiega anche la ragione per la quale adesso le aziende
che si dirigono verso l’agricoltura sostenibile hanno un reddito maggiore
rispetto alle altre, o almeno si spiega una parte di tale ragione. Le aziende
che scelgono l’agricoltura biologica ricevono un notevole aiuto da parte della
Confederazione e dei singoli Cantoni.
Se
questo a prima vista può sembrare una forma di favoreggiamento o di concorrenza
sleale a favore delle aziende rispettose dell’ambiente, in realtà è
semplicemente il risultato dell’internalizzazione delle esternalità negative
nell’agricoltura svizzera, che si traduce in una riduzione dei costi per la società.
Una
pubblicazione[17]
dell'Ufficio Federale di ricerca in economia e tecnologia agricola, riguardante
i costi macroeconomici delle misure ecologiche finanziate dalla confederazione
e dai Cantoni, evidenzia il fatto che la maggior parte delle prestazioni
ecologiche in agricoltura siano sovrafinanziate. Questo è vero se il nostro
spettro d'indagine rimane confinato ad una logica economica privatistica, ma se
lo estendiamo ad un piano socio-economico ci rendiamo conto che esse sono
necessarie a dare una priorità in termini di redditività alle forme agricole
più rispettose dell’ambiente (cfr par 5.2.).
La
forza della riforma dell’agricoltura è la presa di coscenza collettiva del
reale impatto dell'agricoltura convenzionale sia in qualità di consumatori e
produttori (aspetto privatistico), sia in qualità di esseri umani e di
cittadini (aspetto sociale).
L’interesse,
dei consumatori, è quello di acquistare prodotti genuini, nei quali non siano
presenti residui di pesticidi o erbicidi, prodotti non provenienti da
un’alterazione genetica, prodotti non gonfiati dagli ormoni, ovvero
semplicemente dei prodotti di qualità. Questo interesse, di natura egoistica,
non basta a dirigere l’economia verso un nuovo equilibrio, anche se sicuramente
ha la capacità di stimolare il mercato dell`agricoltura biologica e quella
rispettosa dell’ambiente. L’attenzione del consumatore e i coraggiosi impegni
presi, talvolta, da alcuni contadini spinti da ragioni di carattere filosofico
o pionieristico, infatti, non sono sufficienti per indirizzare l’agricoltura
verso la sostenibilità. È necessario che la popolazione percepisca l’interesse
sociale di tale cambiamento, cioè abbia coscienza delle esternalità positive che
derivano dall’agricoltura biologica o si renda conto delle esternalità negative
prodotte dall’agricoltura convenzionale. L’agricoltura rispettosa dell’ambiente
non fa bene soltanto all’ecosistema umano, ma soprattuto fa bene all’ecosistema
ambiente.
L’impatto
ambientale dell’agricoltura biologica è 6-7 volte minore rispetto
all’agricoltura convenzionale. Il costo dell’agricoltura convenzionale si
presenta anche sotto forma di esternalità negative sopportate dall’ambiente e
dalla società: residui tossici negli alimenti, trattamento talvolta disumano
degli animali d'allevamento, inquinamento delle falde acquifere, erosione,
maggiore emissione dei gas responsabili dell'effetto serra, incertezza del
reale impatto degli OGM sulla salute dell’uomo, estinzione di alcune specie di
animali con relativa alterazione della catena alimentare, contribuzione al
fenomeno della “mucillagine” nei mari, diminuzione delle varietà da coltivare,
bilancio energetico squilibrato, residui tossici nel terreno e a migliaia di km
di distanza (DDT in Antartide), lisciviazione, acidificazione, perdita di
fertilità, distorsione dei mercati, oligopolizzazione dell’offerta, ect….
Questi sono tutti i costi che l’ambiente e la società devono sopportare sotto
forma di esternalità negative, che il costo di produzione per i coltivatori non
evidenzia.
Nel
prezzo di acquisto sono presenti il costo delle materie prime (semi, pesticidi,
concimi, ect…), il costo della manodopera e altri costi di natura fondiaria, ma
non sono presenti i costi riguardanti gli effetti sull’ecosistema dati dai
pesticidi, dai concimi minerali e dall’eccessiva meccanizzazione. In altri
termini, il mercato non riesce ad esprimere tutti i costi dell'agricoltura
convenzionale, dunque è un mercato inefficiente. Il
mercato trova il suo equilibrio esclusivamente tra i due opposti interessi
privatistici, quello dei produttori e quello dei consumatori, ma non tiene in
considerazione l'interesse sociale.
L’agricoltura biologica (o quella a produzione
integrata), invece, presenta una composizione del prezzo di vendita più
trasparente e diretta, le esternalità negative sono fortemente ridotte, inoltre
presenta una struttura dei costi nella quale la voce manodopera ha un margine
maggiore ed è invece molto ridotta quella per concimi chimici e quasi assente
quella dei pesticidi e questo permette di giustificare la presenza
di sovvenzioni (v. Tab..
Gli
incentivi diretti all’ecologia, quindi, stimolano, in linea di principio, la
riduzione dell’impatto ambientale dell’agricoltura, rispondendo al primo
criterio della sosteniblità, l’aspetto ambientale. Nei prossimi capitoli
vedremo se anche i dati confermano ciò.
4.4.2.
Aspetto socio-economico
Analizzando
la questione da un punto di vista di allocazione del capitale, l’agricoltura
biologica genera una migliore redistribuzione del reddito, essa genera minori
esternalità negative ed impiega una quota maggiore di manodopera. Attraverso un
approccio marginalista, basato sul modello neoclassico, andremo a vedere tali
dinamiche.
Il
prezzo di equilibrio si trova ad un valore più alto, ma ciò non riduce il
benessere sociale, anzi permette una massimizzazione di tale benessere. Sul
nuovo punto di equilibrio formato da un prezzo più alto, da una minore quantità
scambiata, il benessere privato di consumatori e produttori viene ridotto, ma
tale riduzione è più che compensata dall’aumento del benessere sociale.
Guardando la fig. 4.2.,
individuiamo con D la curva di domanda di prodotti provenienti
dall’agricoltura, che s’interseca con la curva di offerta S, nel punto di equilibrio A (cfr. par 5.2.4.). In
tale punto il volume scambiato è pari a Q2 e il prezzo di vendita è pari a P.
Presupponendo l’esistenza di un mercato concorrenziale sappiamo che la curva di
offerta S è anche la curva dei costi marginali. In tale punto il surplus dei
consumatori è pari al triangolo BPA e il surplus dei produttori è pari al
triangolo POA (con O che indica l’origine degli assi), cioè il benessere
privato è pari al triangolo BOA. Questo potrebbe essere un punto di allocazione
efficiente, se non fosse per l’esistenza dei costi sociali, ovvero per
l’esistenza delle esternalità negative.
La
curva T è la risultante dei costi marginali privati della produzione più i
costi marginali del danno ambientale (esternalità negative dovute all'agricoltura
convenzionale), cioè indica i costi marginali sociali. Introducendo la curva T notiamo che i costi sociali
sono in realtà più alti di quanto credevamo. Infatti
la curva S dei costi marginali privati della produzione non considerava il
reale impatto che l’agricoltura convenzionale ha sull’ambiente e sulla società.
La curva T propone una nuova realtà degli eventi, cioè l’esistenza di
esternalità negative pari all’area HOA. Quello che avveniva prima della riforma
faceva tendere il mercato, grazie anche agli incentivi alla produzione, verso
un equilibrio socialmente inefficiente. Con la riforma, attraverso l’utilizzo
mirato degli incentivi ci si sta dirigendo verso il punto di equilibrio C.
Infatti i produttori sono incentivati dallo Stato a produrre in modo ecologico
(v. sopra). Cioè mentre prima gli incentivi alla produzione facevano tendere il
punto di equilibrio verso destra e in basso, adesso con gli incentivi alla
sostenibilità la tendenza è verso l’alto e verso sinistra. In altri termini gli
incentivi alla produzione creavano un aumento dei costi sociali.
Il punto C è un punto socialmente efficiente, cioè
un punto nel quale è massimizzato il benesserere sociale, un punto di ottimo
paretiano da un punto di vista sociale.
Un’agricoltura rispettosa dell’ambiente ha dei costi
marginali più alti, dati in primo luogo dalla presenza più marcata del costo
del lavoro. La curva T infatti indica anche la curva dei costi marginali di
un’ideale forma di agricoltura che non ha nessun impatto negativo sull’ambiente
e sulla società. La forma di agricoltura che più si avvicina oggi a tale
ipotesi è l’agricoltura biodinamica e in generale l’agricoltura biologica,
sebbene un'impatto negativo sull'ambiente si abbia comunque. Anche molte forme
di agricoltura rurale hanno un impatto minimo sull'ambiente.
Figura 4.2. Efficienza sociale
dell’agricoltura
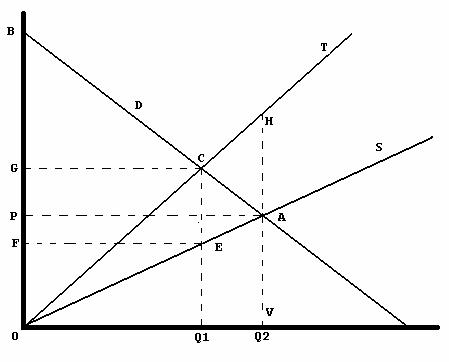
Fonte: mia
rielaborazione del MUSU, Introduzione all’economia dell’ambiente, Il
Mulino
Il
punto C rappresenta l’equilibrio sul mercato dei beni di una produzione data da
un’agricoltura priva di esternalità negative e l’agricoltura biologica è quella
che più si avvicina a tale putno. Diciamo, per semplicità, che nel caso di
un’agricoltura convenzionale l’equilibrio si trova nel punto A e nel caso di
un’agricoltura biologica (o biodinamica) l’equilibrio si trova nel punto C (in
realtà potremo parlare di un intorno destro del punto C).
Il
nuovo punto C è un punto di equilibrio nel quale la quantità scambiata è pari a
Q1, una quantità minore rispetto al punto A.
Nel
punto C il prezzo unitario di vendita G è più alto di P, dunque il mercato ha
meno bisogno di politiche per sostenerlo, in quanto il prezzo tende a
stabilizzarsi su un livello più alto dell’equilibrio dato dall’agricoltura
convenzionale.
Nel
punto C il surplus dei consumatori si riduce all'area BCG, così come il surplus
dei produttori diventa il triangolo GOC. Tuttavia il valore espresso dal
rettangolo GCEF, che rappresenta l'entità dei pagamenti diretti allo standard
ecologico, viene versato direttamente ai produttori, ciò presuppone quindi una perdita di benessere esclusivamente dei consumatori, controbilanciata
parzialmente con l'aumento della qualità del prodotto e con un generale
miglioramento ambientale. Se da una parte i produttori sono compensati
della loro riduzione di benessere, dall’altra i consumatori si vedono ridurre
notevolmente il loro benefici, essi sono costretti a pagare più cara la stessa
quantità di alimenti e solo parzialmente l'aumento di qualità del prodotto e
dell'ambiente controbilancia la diminuzione di benessere. I produttori inoltre
hanno dei risparmi dovuti anche alla riduzione dei costi d’esercizio relativi
all’acquisto di pesticidi, energia fossile e concimi chimici (cfr. par. 4.6.2).
Dunque
i benefici netti privati si riducono dell’area EAC. Con la riforma i
consumatori si vedono ridurre in modo abbastanza sostanziale il loro potere
d'acquisto. Per rendersi conto di ciò
basta fare un giro nei supermercati svizzeri e controllare il prezzo
elevatissimo dei prodotti biologici.
Nel
nuovo punto di equilibrio C si riduce il benessere privato, ma non il benessere
sociale. I costi ambientali hanno una riduzione pari a EAHC e la riduzione dei
costi ambientali è maggiore della riduzione dei benefici netti privati. Vi è quindi
una riduzione netta di costi sociali e un aumento di benessere pari a HCA.
Questo dimostra il fatto che il punto C è un punto socialmente più efficiente
del punto A, cioè l’equilibrio di un’agricolura biologica tende verso un punto
socialmente più efficiente dell’equilibrio dato dall’agricoltura convenzionale.
Le distorsioni del mercato causate dagli incentivi alla produzione sembrano
ridursi con la loro sostituzione con gli incentivi condizionati agli standard ecologici
(eco-condizionalità). Ogni sforzo andato a segno
nella direzione di un’agricoltura più ecologica, crea quindi un aumento di
benessere.
Gli
incentivi diretti allo standard ecologico fanno quindi tendere l’agricoltura
svizzera verso la sosteniblità.
Ovviamente
se non ci sono dubbi circa l’aumento di efficienza sociale al tendere
dell’agricoltura verso la sostenibilità, qualche perplessità sorge nel capire
quale sia il sistema migliore e più efficiente per arrivarvi. Per ora la
riforma nell’agricoltura in Svizzera necessita di ingenti incentivi per indurre
questo cambiamento e sappiamo che gli incentivi posso essere distorsivi.
4.4.3.
Aspetto sociale
Ciò
che differenzia un'impresa convenzionale da una biologica, non è solo la
produzione, ma anche l'allocazione dei fattori produttivi. Nell'impresa
biologica il fattore umano ha una proporzione maggiore e sono esclusi i costi
di pesticidi, mentre i costi per i concimi minerali e per l’energia fossile
sono notevolmente ridotti (34-52 %, cfr par 5.1.3.).
Se
guardiamo di nuovo la fig. 2.4., nell'area
OCE è contenuto anche il costo della manodopera supplettiva necessaria per produrre in maniera biologica.
Quest'ultima affermazione è un'arrotondamento per eccesso della realtà, che
vedremo è diversa. Per ora ci basta sapere che tale affermazione è valida per
le imprese agricole collocate in pianura, i dati parlano di un fattore di
aumento dei salariati esterni al nucleo familiare nell'ordine del 50% (cfr.
par. 5.1.3.).
Nell’aria
OCE è contenuto anche il costo supplettivo dovuto alla maggior manodopera, nel
caso che tutte le imprese si convertano al biologico. Le sovvenzioni sono
indirizzate sia all’ecologia, sia all'occupazione, in quanto stimolando la produzione biologica stimolano
l'occupazione, riducendo ulteriorimente la distorsività delle sovvenzioni
stesse. Le sovvenzioni alla sostenibilità non sono distorsive e al contrario
hanno un triplo dividendo:
· riducono l'inquinamento ;
· stimolano l'occupazione;
· migliorano l'efficienza economica.
I dati
daranno conferma di ciò (cfr. cap 5).
4.5. L’agricoltura
svizzera: importanza della riduzione degli incentivi indiretti
4.5.1.
Incentivi indiretti: inefficienza e inefficacia
Riprendendo
un precedente discorso lasciato in sospeso, dovremo adesso considerare il lato
della domanda, il lato del consumo. Se guardiamo la realtà notiamo che ciò che
favorisce l'inquinamento in agricolutra, non è di esclusiva responsabilità dei
produttori, ma anche dei consumatori. Per essere più precisi la politica
agricola alla produzione e allo smercio (incentivi indiretti) si traduce in un allargamento della domanda per garantire ai prezzi di
rimanere a determinati livelli e garantire lo smercio dei prodotti. Ma questo
allargamento della domanda è finanziato dalla Confederazione. Per questo la
nuova riforma agraria prevede che la spesa della Confederazione, destinata alla
produzione e allo smercio, debba essere ridotta di un terzo rispetto al livello
del 1998 ovvero entro 5 anni dalla sua entrata in vigore. Nel 2003 è possibile
destinare soltanto 800 milioni di franchi a favore di provvedimenti in tale
ambito, mentre nel 2001 per la promozione della produzione e dello smercio sono
stati destinati circa 902 milioni di franchi. Rispetto all'anno precedente si è
registrata una diminuzione delle uscite di circa 53 milioni di franchi (-6%).
Ciò rappresenta un ulteriore passo verso lo smantellamento dei mezzi finanziari
destinati alla promozione della produzione e dello smercio conformemente
all'art. 187 capoverso 12 L agr.
Dalla
tabella 4.3. appare evidente l'importanza del settore
lattiero (che prenderemo come esempio), in quanto riceve il 70 % della spesa.
Nel corso del 2001 le uscite della Confederazione a favore dell'economia
lattiera sono state ulteriormente ridotte (-7 %). Per il sostegno del prezzo
nel settore lattiero sono stati stanziati complessivamente 666,1 milioni di
franchi, di cui 486,1 a favore del settore caseario (73 %), 104,3 milioni di
franchi per il burro (16 %), 69 milioni di franchi per il latte in polvere (10
%) e 6,7 milioni di franchi (1%) per le spese amministrative. Questo per dire
che è ancora forte la partecipazione della Confederazione al sostegno della
domanda di prodotti agricoli e la competitività dell’economia lattiera svizzera ne è fortemente
influenzata.
Nel corso dell’ultimo ventennio la produttività
della produzione lattiera non ha potuto essere migliorata, il che mostra i
limiti delle sovvenzioni alla produzione. La ripartizione individuale dei
contingenti lattieri e il vincolo alla superficie, applicato fino al 1° maggio
1999, non hanno contribuito a migliorare il reddito dei produttori lattieri,
malgrado prezzi del latte più elevati, in quanto hanno ostacolato lo sviluppo
di strutture più efficienti. C’è un’inefficacia di fondo tra gli obiettivi alla
base degli incentivi indiretti e i risultati ottenuti, almeno per il mercato
lattiero e caseario.
Tabella 4.3. Uscite della confederazione per la
produzione e lo smercio, in agricoltura.

Fonte: UFAG, Rapporto agricolo 2002; Conto dello
Stato.[18]
Nonostante i
mezzi usati dalla Confederazione per mantenere il prezzo del latte ad un
determinato livello, che garantisse un reddito comparabile a quello della
rimanente popolazione attiva, il risultato è stato contemporaneamente una
perdita di concorrenza e una
produttività stazionaria. Gli aiuti hanno ostacolato il
naturale e continuo assestamento del mercato.
Quindi se non ci sono dubbi sul fatto
che i redditi degli agricoltori e l’esportazione debbano essere sostenuti,
tuttavia ci sono dubbi sui mezzi utilizzati per tale fine. Cioè mantenere prezzi
e produzione artificialmente elevati crea un effetto perverso, se allo stesso
tempo vogliamo aumentare la nostra concorrenza all’esterno del paese.
4.5.2. L’aspetto economico-ambientale
Il grafico che esprime la riduzione degli incentivi indiretti è quello della figura 4.4., nella quale riprendiamo le nostre 2 curve di domanda D e di offerta S di prodotti agricoli.
Il meccanismo è tanto più vero per il
latte (quindi per i prodotti caseari) che per gli altri prodotti agricoli, in
quanto abbiamo visto che riceve il 70 % degli aiuti alla produzione e allo
smercio. In ogni modo parliamo di un mercato di agricoltura convenzionale, dove
non c’è stata internalizzazione delle esternalità negative e dove la domanda è
sostenuta dagli incentivi indiretti.
In questo mercato la curva dell’offerta rimane S, mentre la curva della domanda, tolti gli incentivi indiretti, diventa D-I. Si pone come ipotesi che D-(D-I) = 0 per Q = 0, cioè il prezzo = B e che max D-(D-I) per Q max. In altri termini I = 0 per Q = 0 e max I per max Q, cioè gli incentivi sono proporzionali alla quantità venduta. Gli interventi della Confederazione con un po’ di semplificazione si possono tradurre in un allargamento del surplus della domanda totale pari all’area BEA. La curva D-I rappresenta quindi la curva di domanda esclusivamente dei consumatori, mentre D è la curva di domanda comprensiva della spesa pubblica per la promozione della produzione e lo smercio (incentivi indiretti).
È interessante notare quello che
succede al surplus dei consumatori, che con gli incentivi diretti (cfr.
par. 4.4.3.) avevamo visto diminuire (fig.5.4., area BPA). Se invece separiamo
appunto il surplus dei consumatori dalla spesa della Confederazione per la
promozione della produzione e dello smercio, scopriamo che il vero surplus dei
consumatori (rimanendo sempre nel punto di equilibrio A) è BPR. Separando la
spesa della Confederazione dalla spesa dei consumatori, troviamo il reale
surplus di quest'ultimi, che è ridotto del triangolo BRA.
L'area PFER rappresenta la perdita di
benessere dei consumatori causata dall’effetto distorsivo degli incentivi
indiretti. Quest’ultimi agiscono sul mercato alzando il prezzo, aumentando la
quantità prodotta e smerciata e riducendo
il reale benessere dei consumatori. La quantità scambiata con i consumatori si ruduce
e il prezzo aumenta, essi sono costretti a ridurre il loro volume d’acquisto da
Q1 a Q3, nonostante che sul mercato la quantità scambiata totale aumenti fino a
Q2. Inoltre il prezzo P è superiore a F. La diminuzione della quantità
scambiata sarà tanto maggiore quanto più elastica è la curva di domanda, e
viceversa l’aumento di prezzo sarà tanto più alto quanto più rigida è la curva
di domanda.
I produttori, invece, hanno un beneficio dall’introduzione degli
incentivi indiretti. In un mercato perfetto, senza l'intervento della
Confederazione, il loro surplus sarebbe pari all'area FOE, ma l'effetto degli
interventi fa aumentare tale benessere all'area POA. Dunque, l'effetto della spesa della
Confederazione per la promozione della produzione e lo smercio, è quello di
aumentare la quantità scambiata, aumentare la produzione, aumentare il prezzo e
aumentare il benessere dei produttori. In realtà avevamo visto nel paragrafo
precedente, che il prezzo più elevato non si traduce automaticamente in un
reddito più alto per i produttori e che, invece, ostacola la concorrenza e la
produttività. L’area PFEA indicherebbe un aumento di benessere dei produttori
soltanto in un mercato concorrenziale perfetto e per coerenza economica
manterremo questa ipotesi.
Figura 4.4. Riduzione degli incentivi alla produzione
e allo smercio

Fonte: mia
rielaborazione del MUSU, Introduzione all’economia dell’ambiente, Il
Mulino
Il discorso
diviene interessante quando andiamo a vedere quello che succede nel caso che la
spesa della Confederazione per la promozione della produzione e lo smercio
cessi di esistere, o almeno si riduca. In tal caso il nuovo punto di equilibrio
sarebbe il punto E (o un intorno destro del punto E). Il nuovo stato delle cose
favorirebbe i consumatori, in quanto si vedrebbero aumentare il proprio surplus
dell'area PFER. Ogni
sforzo indirizzato alla riduzione degli incentivi indiretti aumenta il
benessere dei consumatori. Il surplus dei produttori quindi, si ridurrebbe
dell'area PFEA (in un mercato di concorrenza perfetta), in realtà la riduzione
di benessere è inferiore all’area PFEA, anzi ci sarebbe un guadagno in termini
di produttività e concorrenza. Il
benessere privato si riduce del triangolo REA.
Il passaggio da un economia
agricola sovvenzionata alla produzione e allo smercio ad una non sovvenzionata
provoca dunque una diminuzione del benessere privato dell'area REA (ricordando
sempre il fatto dell’inefficacità e non solo inefficienza, delle sovvenzioni
indirette, almeno per il mercato del latte e caseario).
Ma cosa succede al benessere pubblico? La spesa effettuata dalla Confederazione per
promuovere la produzione e lo smercio dei prodotti agricoli è un costo per
l’economia pubblica, facilmente quantificabile in 902 milioni franchi nel 2000.
Tale valore viene prelevato ai contribuenti sotto forma di tasse che ovviamente
riducono il benessere pubblico, collettivo. In realtà tali costi hanno la
funzione di stimolare la domanda o di indirizzare i prodotti verso l’esportazione
o nella trasformazione in derivati. Per semplicità economica diremo che tali
costi sono pari all’area RVA. Quindi la sospensione delle sovvenzioni indirette
della Confederazione creerebbe un aumento di benessere sociale pari all’area
EVA. Ogni diminuzione degli incentivi indiretti crea un miglioramento
dell’efficienza e un aumento di benessere.
Anche qui,
come per gli incentivi diretti, si assiste ad un vantaggio in termini di
sostenibilità. Togliere o ridurre gli incentivi indiretti crea un aumento del
benessere pubblico, che migliora l’aspetto economico della sostenibilità.
Più delicato è analizzare l’aspetto
ambientale; l’unica cosa che possiamo dire è che, riducendo la quantità
prodotta, verosimilmente andremo a ridurre anche il danno ambientale (quindi le
esternalità negative). Maggiore sarà l’impatto sull’ambiente e maggiori saranno
i benefici sociali risultanti dalla riduzione del danno ambientale, al ridurre
della quantità prodotta generata dalla riduzione degli incentivi indiretti.
Un ulteriore aspetto della riduzione
degli incentivi indiretti sta nel miglioramento della competitività e
concorrenza, anche sul piano internazionale, generati dalla diminuzione del
prezzo (cfr. prossimo capitolo)
4.6. Relazioni tra riorientazione degli incentivi
e riduzione degli incentivi indiretti. Effetti economici e ambientali
Dunque abbiamo visto i due aspetti
della riforma agraria in Svizzera e abbiamo indagato le ragioni che hanno
favorito la promulgazione del referendum. Abbiamo analizzato da un punto di
vista economico in quali direzioni si sta spostando l’equilibrio tra domanda e
offerta. Gli incentivi diretti sono stati riorientati verso l’ecologia,
stimolando coltivazioni più rispettose dell’ambiente, e dall’altra parte sono
in via di riduzione in special modo gli incentivi indiretti ovvero quelli per
la promozione della produzione e lo smercio.
Guardando l’evoluzione delle uscite
della Confederazione per agricoltura e alimentazione (v. tab 5.2.) notiamo una
riduzione degli incentivi indiretti in favore di quelli diretti. È importante
analizzare i due differenti interventi economici contemporaneamente e
individuare il loro punto di arrivo. Se guardiamo la figura 4.6., si
riconoscono i due differenti interventi:
·
il primo
diretto alla riorientazione dei pagamenti diretti, dalla produzione
all’ecologia , ovvero all’internalizzazione delle esternalità negative
nell'agricoltura (sovvenzioni dirette);
·
il secondo
diretto alla riduzione del sostegno della produzione e lo smercio (sovvenzioni
indirette).
Guardando la fig.4.6., infatti,
abbiamo rispettivamente il punto C e il punto E. Nel caso di una riorientazione
dei pagamenti diretti verso l’ecologia, il mercato tende al punto C e nel caso
di riduzione delle sovvenzioni indirette, il mercato tende al punto di
equilibrio E.
Se, come sta avvenendo in Svizzera, tali eventi
avvengono contemporaneamente, ci sarà uno spostamento dell’equilibrio di
mercato dal punto A al punto X o almeno ad un intorno destro del punto X.
4.6.1. Cambiamento politico
Gli effetti della riforma agricola
determinano uno spostamento verso sinistra del punto di equilibrio (figura
4.6). In altri termini entrambi gli interventi hanno un effetto di riduzione
della quantità scambiata, cumulativo.
Abbiamo visto però, che questa riduzione
della quantità scambiata non si traduce necessariamente in una riduzione del
benessere, in quanto il primo intervento riduce contemporaneamente anche il
danno ambientale, aumentando l’occupazione e l’efficienza sociale e il secondo
aumenta il benessere del consumatore, migliora la concorrenza (vedi paragrafi
precedenti) e riduce il danno. Di quanto si ridurrà la quantità scambiata? Ciò
dipenderà dal successo e dagli obiettivi della riforma e dall’elasticità della
domanda e dell’offerta. Una maggiore flessibilità dell’offerta e della domanda
amplia l’effetto sulla produzione.
Tuttavia, se guardiamo la tabella
4.5. notiamo che questa diminuzione è iniziata prima della promulgazione della
riforma (già a partire dagli inizi degli anni '90), causata anche da altri
fattori come la congiuntura internazionale, i cambiamenti climatici,
l’alterazione di certi equilibri e anche il rispetto di determinati oneri
ecologici. Quindi la riforma è intervenuta quando il cambiamento era già
cominciato, il cambiamento politico (seguendo certi livelli soglia) ha
accompagnato e indirizzato il cambiamento economico, ovvero il cambiamento
economico è stato interpretato e sostenuto dal cambiamento politico.
Conseguentemente
c’è stata una riduzione del valore aggiunto al prezzo di mercato, di quasi il
50 % (tra il 1990 e il 2001). Tuttavia questa riduzione, non ha determinato una
corrispondente riduzione del valore aggiunto lordo al costo dei fattori, in
quanto le sovvenzioni dirette hanno parzialmente coperto tale calo tra il 10 e il
20% (tra il 1990 e il 2001). Le sovvenzioni dirette introdotte sono state in
buona parte delle sovvenzioni all’ecologia, che hanno limitato la distorsione
delle sovvenzioni alla produzione. Qui si trova una buona parte del vantaggio dell’intervento popolare
(referendum) per la riforma dell’agricoltura. La politica ha saputo
interpretare la realtà (abbassamento della produzione e aumento
dell’inquinamento) e introdurre delle misure nuove (presenti già in parte in
Europa), gli incentivi all’ecologia, creando benefici per i contadini, per i
cittadini e per i consumatori.

Tabella
4.5. Evoluzione della produzione e del reddito dei contadini
Fonte: OFAG, 2000
Se continuiamo l’analisi della
tabella 4.5, notiamo che il reddito totale netto del lavoro in agricoltura ha
avuto un calo intorno al 25 %. Dato che alcune aziende hanno chiuso (v. anche
5.1.1.), il reddito pro-capite dei contadini non ha subito la stessa sorte.
Secondo Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste: “Il reddito dei contadini si è stabilizzato: nonostante la
sostanziale riduzione dei prezzi alla produzione, il reddito dei contadini ha
potuto essere mantenuto, anche se a un livello più basso. Nel confronto con il
resto della popolazione, qual’è la posizione finanziaria dei contadini svizzeri?
Nel 1998, il reddito rurale per azienda (senza guadagno accessorio) ammontava a
73 000 franchi per le regioni di pianura e a 50 000 franchi per quelle di
montagna. Nello stesso anno, le uscite medie delle economie domestiche svizzere
- dove solitamente vive più di una persona attiva professionalmente -
ammontavano a 89 000 franchi”[19].
L’impulso dato dalla società
svizzera, nei suoi aspetti politici, economici e sociali, verso un’agricoltura
sostenibile ha trasformato una situazione negativa da un punto di vista
economico (diminuzione della produzione) in un occasione per mantenere i
redditi dei contadini, internalizzare le esternalità. La Svizzera, grazie ai suoi quattro fattori
distintivi (v. fine par. 4.1.1.) ha saputo, se pur con un po’ di ritardo, interpretare
la realtà e muoversi nella direzione giusta con un buon dinamismo. Un dinamismo
che l’avvicina a quel modello di agricoltura sostenibile che è obiettivo di
molti paesi sviluppati, ma che in svizzera dimostra un accelerazione maggiore,
si prenda come esempio l’incremento di aziende biologiche e la percentuale di
aziende a PI (tab 6 in appendice). La riduzione della produzione, pur cercando
sempre di contrastarla, non è stata considerata il male peggiore.
4.6.2. Aspetto biologico della riduzione della produzione
Da un punto di vista fisico, sappiamo che le rese dell’agricoltura
biologica sono minori. Uno studio[20],
avvalorato anche dalla rivista americana Science, condotto su un periodo
di 21 anni dimostra che le rese in agricoltura biologica sono in media l’80%
delle rese in agricoltura convenzionale. Tale studio, avvenuto a Therwill
(Basilea-campagna), riconosciuto anche dall’Università del Michigan, dice che
la diminuzione della resa varia da pianta a pianta: 10 % in meno per il
frumento, fino al 30-40 % in meno per le patate (a causa della carenza di
potassio e della forte incidenza del mildu).
Peraltro
l’agricoltura biologica è incredibilemente efficace, perchè ha impiegato dal 34
a 52% in meno di concimi minerali e energia fossile e il 97 % in meno di
prodotti fitosanitari nell’arco di questi 21 anni. Il terreno mostra un
fertilità maggiore ed una attività biologica doppia rispetto all’agricoltura
convenzionale, il che dimostra i buoni rendimenti anche in assenza di apporti
di concimi minerali. Il tenore in nutrienti solubili (fosforo e potassio) è
minore, data la loro maggior velocità di reazione. Infine una presenza del 40 %
in più di funghi permette un migliore nutrimento per le piante. L’agricoltura biologica (ancor
di più la biodinamica) contribuisce a mantenere una grande biodiversità
nonostante l’utilizzazione del suolo per fini agricoli.
L’economia,
la politica e i rendimenti fisici, seppur con intensità e connotati diversi,
attraverso un’agricoltura biologica seguono la stessa dinamica: una minor
produzione, con aumento di benessere collettivo. In altri termini l’agricoltura diventa veramente
sostenibile, in quanto interessa sia il piano politico, sociale, economico che
quello ambientale. Cioè passando ad un’agricoltura biologica è naturale che ci
sia una riduzione della quantità prodotta, assieme ad una grande riduzione del
danno ambientale; tale
riduzione si traduce solo parzialmente in una riduzione del reddito dei
contadini.
4.6.3. Effetto sul prezzo: un’attrito di forze
I due interventi, ossia la
eco-condizionalità degli incentivi diretti e la riduzione degli incentivi
indiretti, hanno un effetto comulativo di riduzione della quantità prodotta (v.
figure 4.2. e 4.4.). Essi, tuttavia, esercitano sul prezzo due forze contrarie:
·
Il primo intervento
(v. par 4.4.), diminuendo sostanzialmente l’offerta, esercita sul prezzo una
forza all’aumento.
·
Il secondo
intervento (v. par 4.5.), diminuendo sostanzialmente la domanda, esercita sul
prezzo una forza al ribasso.
In un mercato concorrenziale perfetto, tali effetti si
bilanciano generando due casi diversi:
·
ll nuovo
punto di equilibrio X ha ordinata maggiore rispetto al punto di partenza A,
cioè f (X) ³ f (A) ovvero il prezzo aumenta.
·
Il nuovo
punto di equilibrio X ha ordinata minore rispetto al punto di partenza A, cioè
f (X) £ f
(A) ovvero il prezzo diminusice.
La differenza di flessibilità tra domanda e offerta
influenzerà il meccanismo.
Anche nella realtà ci sono state due
forze contrarie e contrastanti che hanno determinato, nel periodo 1990-2000,
sia un decremento dei prezzi alla produzione del 24%, sia un incremento dei
prezzi al consumo del 7% (UFAG, Rapporto agricolo 2002). Per un confronto con
gli altri paesi fino al 1998, si veda le tabelle 12 in appendice.
Tuttavia, il mercato agricolo è un
mercato lontano dall’essere perfetto, dove il prezzo non esprime il libero
incontro tra domanda e offerta, ma piuttosto il risultato di un’attenta e costosa
politica di prezzo da parte degli stakeholders. Questo crea un attrito di forze tra politica (nel suo
significato più ampio) che agisce per un prezzo generalmente più alto ma
inefficiente, ed economia, che lascerebbe il prezzo equilibrarsi ad un livello
inferiore, mettendo in pericolo il reddito dei contadini. Questo attrito
di forze rimarrebbe inalterato o addirittura potrebbe aumentare se non fosse
per una nuova “forza” che sta entrando sulla scena.
Figura 4.6. Effetti sul prezzo e sulla produzione agricole
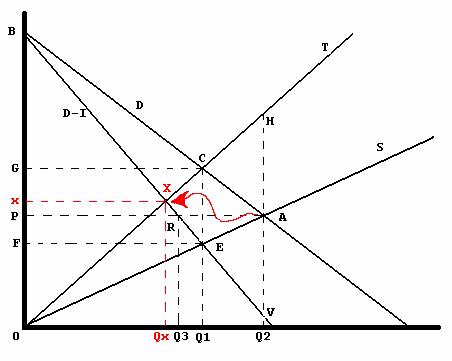
Fonte: mia
rielaborazione del MUSU, Introduzione all’economia dell’ambiente, Il
Mulino
Inizialmente l’ambiente era visto
come un costo aggiuntivo, come un sacrificio da sopportare da parte degli
stakeholders. Questa iniziale e distorsiva percezione della realtà sta
lasciando il posto ad una migliore interpretazione del valore ambiente, come
opportunità del mercato di migliorarsi. Per quanto riguarda il mercato
agricolo, infatti, introdurre il fattore ambiente significa trovare un punto
d’equilibrio per ridurre gli attriti.
La contabilità del danno ambientale
permette una visione più chiara del reale costo dell’agricoltura. In altri
termini, il fatto di considerare come fattori produttivi soltanto capitale,
terra e lavoro, mantiene l’economia in uno stato di alterazione con una
produzione costante di costi ambientali che la società presente e futura è
costretta a sostenere. La percezione dell’agricoltura come la risultante di
terra, capitale e lavoro mantiene l’agricoltura convenzionale come la forma
agricola più conveniente (v. anche par 5.3.3.). Se invece internalizziamo nel
prezzo di produzione anche le esternalità negative, ecco che la forma agricola
più conveniente diventa quella che minimizza i costi sociali, cioè la biodinamica
o la biologica. Internalizzare le esternalità negative nel costo di produzione
si traduce in aumento del prezzo di vendita, tuttavia bilanciato (almeno in
parte) dalla riduzione degli incentivi indiretti che stimolavano la domanda.
L’utilizzo contemporaneo dei due interventi (diretti e indiretti) garantisce
ancora meglio la riuscita del progetto sostenibile (cfr fig 5.9.).
Da un punto di vista di contabilità
pubblica la riduzione di spesa per gli incentivi indiretti (secondo intervento)
viene riconvertita dalla Confederazione in incentivi diretti all’ecologia
(eco-condizionalità), socialmente più efficienti.
Vedremo nel prossimo capitolo che in
realtà non sono stati soltanto gli interventi pubblici a indirizzare
l’agricoltura verso la sostenibilità.
4.6.4. Effetto sull’ambiente
L’internalizzazione delle
esternalità negative sta avvenendo mediante l’uso degli incentivi. I contadini
che rispettano di più l’ambiente, ricevano più incentivi. La realtà ci mostra
infatti un cambiamento avvenuto in questi ultimi anni che conferma questa tesi
(cfr par 5.3.2.). Una valutazione dell’impatto ambientale potenziale
dell’agricoltura svizzera (SRVA, 2000) rivela dal 1980, e in modo più
significativo a partire dal 1990, una netta riduzione dell’ecotossicità
acquatica e di quella terrestre nell’ordine del 50 - 60 % nel 1998. Una
riduzione più contentuta per la tossicità umana, l’eutrofizzazione totale e
l’acidificazione dei suoli nell’ordine del 20 - 30 %, a seconda se prendiamo in
considerazione l’impatto ambientale per ettaro o per energia alimentare
prodotta. Una riduzione tra 0 e 10 % per la formazione d’ozono e l’effetto
serra a 500 anni (cfr par 5.3.2). Infine un peggioramento delle condizioni
ambientali per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse energetiche non
rinnovabili tra il 10 e il 18 % anche se
bisognerebbe sempre contare il fatto che l’energia elettrica in svizzera
proviene per metà da energia atomica e per metà da energia idroelettrica.
Franz Fischler commissario
dell’agricoltura all’UE ha affermato: "La Svizzera ha realizzato
un’agricoltura sostenibile esemplare per l’Unione Europea”. Se prendiamo
l’esempio della tossicità acquatica ridotta del 50-60 %, ci rendiamo conto che
questa si traduce in una riduzione dei costi di depurazione e di gestione delle
acque in generale. ). Il professor Pretty ed altri (2001) hanno
stimato che il costo annuale della contaminazione di acqua potabile con
pesticidi sia, per la sola Gran Bretagna, approssimativamente 190 milioni di
euro all’anno!
Vedremo nei prossimi capitoli
più nel dettaglio il miglioramento dell’impatto dell’agricoltura in Svizzera,
che si traduce in una riduzione dei costi sociali che il danno ambientale crea.
5. IL SISTEMA TERRITORIALE
SVIZZERO: UNA “V.I.A.” PER L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE (CONCLUSIONI)
5.1. Cambiamento strutturale
Abbiamo
già visto nel capitolo precedente il cambimento politico avvenuto negli anni
‘90.
5.1.1. Dell’offerta dei beni agricoli
C’è stato un mutamento strutturale delle aziende, a detrimento specialmente delle piccole aziende. Nel 2000 sono state censite complessivamente 28.200 aziende in meno rispetto al 1985. La metà di esse erano aziende di piccole dimensioni con una superficie compresa tra 0 e 3 ettari. Dall’inizio del periodo considerato è rimasto praticamente soltanto un terzo di queste aziende.
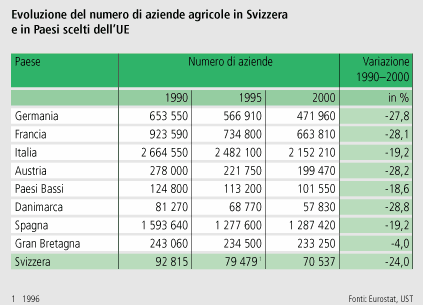
Tabella
5.1. Evoluzione del numero di aziende agricole in Svizzera e in UE
Fonte: OFAG, Rapporto agricolo
2002; Eurostat, UST.
Si è cioè verificato un mutamento strutturale che ha aumentato le grandi aziende e ridotto drasticamente le piccole (OFAG, 2002). Il calo del numero di aziende agricole è un processo riscontrabile non solo in Svizzera, bensì anche nel resto d’Europa. In tabella 5.1. è illustrata l’evoluzione in Svizzera e in Paesi scelti dell’UE.
La Svizzera, come abbiamo visto, ha cercato di trarre beneficio da
questo cambiamento strutturale. La crisi nel settore agricolo in altre parole è
stata uno stimolo in più per concentrare gli sforzi verso la sostenibilità. La
Svizzera ha ridotto notevolmente il suo impatto sull’ambiente, inteso nel suo significato più ampio, in
quanto si possono ritrovare gli effetti anche a livello internazionale, nel
rispetto degli impegni e nella riduzione delle emissioni inquinanti
transfrontaliere.
L’analisi del Rapporto Agricolo 2002 (OFAG) ci mostra che il bestiame
bovino è diminuito del 15% dal 2001 e le ragioni sono molteplici, da ricercarsi
nella congiuntura internazionale, nella diminuzione delle aziende e nei
maggiori oneri ecologici, mirati a migliorare le condizioni di vita degli
animali (v. i programmi SSRA, URA nel par. 4.3.3. e tab 5 in appendice) che in
pratica consistono in un aumento e miglioramento del loro spazio vitale. Anche
qui la riforma, ha trasformato una tendenza negativa del mercato in
un’occasione d’impulso verso la sostenibilità.
Dopo aver registrato, nel 2000, un lieve incremento, nel 2002 l’indice
dei prezzi alla produzione è diminuito del 5,4 %. La flessione è riconducibile
in particolare al basso livello dei prezzi nei settori cerealicolo e della
produzione animale. Dal 1990/92 al 2001 i prezzi alla produzione sono dimuiti
del 25 %, mentre quelli al consumo sono aumentati nello stesso periodo del 7 % [21].
Nel 2001 importazioni e esportazioni hanno subito un aumento del 2 %
rispetto al 2000. La Svizzera produce il 60 % delle derrate alimentari
consumate (espresse in calorie), con punte del 95% per i prodotti di origine
animale e del 46 % nel 2000 per il settore vegetale.
La produzione finale, ossia il valore di tutti i prodotti del settore
primario, ha subito una flessione del 4,7 per cento rispetto all’anno
precedente: il 10,7 per cento in meno per piante e prodotti vegetali (252 mil
CHF) e l’1,9 per cento in meno per animali e prodotti di origine animale (100
mil. CHF).
5.1.2. Del mercato del lavoro
Un cambiamento strutturale si è avuto anche nella composizione della forza lavoro, con una diminuzione di
circa il 24 % di quella familiare ed un aumento del 5 % di quella
extrafamiliare, nel periodo 1990-2000 (OFAG). Se escludiamo quindi la riduzione della manodopera familiare interessata
dai mutamenti strutturali (riduzione di 1/3 delle piccole aziende), l’aumento
della manodopera extrafamiliare conferma quanto asserito nel paragrafo 4.4.3. e
cioè che le aziende agricole più rispettose dell’ambiente registrano una
componente di manodopera extrafamiliare maggiore delle aziende non biologiche,
specialmente per le aziende di pianura (cfr tab 5.4.). Ciò è dovuto
direttamente al fatto che più l’agricoltura tende verso l’ecologia, più
necessita di lavoro umano, sia prettamente meccanico, sia di natura
scientifica, in quanto ogni coltivazione necessita di un approfondito e
preliminare studio per determinare i metodi e i sistemi di protezione e
concimazione alternativi.
Se infatti prendiamo come rifermimento che
anche la produzione nello stesso periodo è diminuita del 25%, ci rendiamo conto
che in termini relativi la manodopera familiare è rimasta stabile e quella
extrafamiliare è aumentata più del 5%. Questi
dati evidenziano il fatto che sono state soprattutto le piccole imprese
familiari a uscire dal mercato, mentre si sono rafforzate quelle di più grandi
dimensioni.
5.1.3. Della spesa della Confederazione
L’evoluzione delle uscite (v. tabella 5.2.) della Confederazione per
produzione e smercio (incentivi indiretti) è in funzione dell’adempimento di
quanto previsto dall’articolo 187 capoverso 12 delle disposizioni transitorie
della nuova Lagr (riforma), secondo cui, cinque anni dopo l’entrata in vigore
della legge, i mezzi finanziari impiegati nel settore del sostegno del mercato
vanno ridotti di un terzo rispetto alle spese per il 1998. Sulla base di tale
disposizione, nel quinquennio in questione la riduzione dovrà corrispondere a
400 milioni di franchi circa. Nel 1998 le uscite per produzione e smercio erano
state di 1'203 milioni di franchi, nel 2001 di 902 milioni di franchi. In
questi tre anni i mezzi finanziari sono quindi stati ridotti di 301 milioni di
franchi (783 milioni dal 1990).
Se tuttavia andiamo a vedere i valori relativi notiamo che le uscite
della Confederazione per produzione e smercio erano nel 1990 attorno all’8,7 %
delle uscite totali, nel 1999 arrivavano oltre il 9 %, mentre nel 2001 sono
scese sotto l’8 %. Oltre l’1% di spesa totale risparmiata! Sappiamo quanto sia
politicamente difficile tagliare la spesa senza procurare malcontenti nella
popolazione.

Figura 5.2.
Evoluzione della spesa agricola della
Confederazione
Fonte:
OFAG, Rapporto 2002; Conto dello Stato.
5.1.4. Del conto economico delle aziende
Nella tabella 5.3. notiamo l’evoluzione del conto economico nelle
aziende. Notiamo immediatamente che
i contributi dello Stato (sovvenzioni) sono aumentati dal 1990. Ma dal grafico
non si nota che tale variazione è stata anche di carattere qualitativo, nel
senso che gli incentivi all’ecologia hanno sostituito quelli alla produzione.
In altri termini la Confederazione ha diminuito gli incentivi indiretti e
diretti alla produzione, per trasformarli in incentivi alla sostenibilità.
La riforma ha indirizzato il mutamento del mercato verso la sostenibilità,
in altri termini ci si è resi conto della crisi del settore e si è cercato di
trasformare il cambiamento già in atto per ridurre il danno ambientale,
migliorando l’efficienza sociale. Una certa tendenza, verso una riduzione della
quantità prodotta e aumento della qualità, si era fatta sentire anche prima
della riforma; la riforma ha semplicemente saputo sostenerla e meglio
indirizzarla ai fini della sostenibilità.
Nella tabella 5.3. abbiamo l’esempio concreto di quanto esposto in
figura 4.6, circa l’efficienza sociale in agricoltura. Avevamo detto essere A
l’equilibrio di partenza di un mercato ad agricoltura convenzionale dove non
erano state internalizzate le esternalità (v. par. 4.4.2.). La quantità
scambiata era Q2, con una certa emissione di danno ambientale, con presenza
d’incentivi diretti alla produzione.
Figura 5.3. Evoluzione del conto economico
dell’agricoltura

Fonte:
OFAG, Rapporto Agricolo, 2002; USC.
Nell’esempio concreto del mercato agricolo svizzero il nostro Q2
corrisponde a 10.006 CHF. Cioè nel 1990 la produzione agricola, stimolata anche
dagli incentivi alla produzione (sia diretti che indiretti), era di ca. 10.000
milioni di CHF, con produzione di un certo quantitativo di danno ambientale.
Gli incentivi indiretti erano 1.685 (1990) milioni di CHF e incentivi diretti
(alla produzione) erano 772 (1990) milioni di CHF. La riduzione degli incentivi
indiretti a 902 milioni (2001) e la sostituzione degli incentivi diretti con
quelli all’ecologia (2.300 milioni), hanno partecipato a ridurre la produzione
fino a 7.300 milioni, che rappresenta appunto un’intorno destro del punto f(Qx)
= X (cfr. par 5.4.1.). Questa diminuzione non è stata combattuta, ma
semplicemente canalizzata verso la sostenibilità. Il prezzo si è stabilizzato
sul segmento che va da E a C (fig. 4.6.), il prezzo ha subìto due forze
contrastanti (v. la comparazione con altri paesi fino al 1998, tab 12 in
appendice):
·
Aumento: il prezzo
al consumo è umentato del 7% (v. par
5.1.1.) e ha fatto tendere il mercato agricolo verso quel punto C (v. figura
4.2.), che rappresenta il punto d’arrivo di un agricoltura che ha
internalizzato le esternalità, migliorando l’efficienza sociale;
·
Riduzione: il prezzo
alla produzione è diminuito del 25%, facendo tendere il mercato agricolo verso
il punto A (v. figura 4.3.), che rappresenta il punto nel quale il mercato
agricolo ha ridotto le distorsioni date delle sovvenzioni indirette,
migliorando l’efficienza sociale.
Vedremo,
poi, con la figura 5.9. e nel paragrafo 5.4.4., come si traduce graficamente la
transizione verso la sostenibilità del sistema territoriale svizzero.
5.1.5. Della volontà comune per un’agricoltura sostenibile. Il principio di neutralità
Considerando il grafico 4.6, notiamo che il nuovo punto d’equilibrio,
sul quale il mercato si è stabilizzato, potrebbe essere un intorno destro del
punto X (cfr. par. 4.6.3.), ammettiamo di aver superato il segmento che lega A
a C (v. 5.4.1.). Se questo risultasse vero gli stakeholders (cittadini,
consumatori, produttori, elettori, amministratori) esprimono, consapevolmente o
inconsapevolmente, tramite le loro scelte (referendum, consumo, produzione) e
tramite il mercato, una volontà comune, quella di un’agricoltura più
sostenibile e più rispettosa dell’ambiente.
Ma come
si è potuto raggiungere un tale obiettivo? Un sistema territoriale è formato da
relazioni tra i soggetti e l’esteriorità, ma l’esteriorità non è sotanto
l’ambiente, ma anche il mercato stesso. Le relazioni tra i soggetti avvengono
tramite il mercato e l’ambiente, nel nostro caso anche tramite l’agricoltura.
Per capire meglio tale obiettivo dobbiamo vedere dove si forma questa volontà
comune del sistema territoriale svizzero alla sostenibilità (per territorialità
nel tempo v. par 4.1.3.).
La
definizione di territorialità (v. par 1.1.2.), infatti, impone come obiettivo,
la massima autonomia, compatibile con le risorse del sistema. Non a caso,
l’obiettivo della politica agricola svizzera è sempre stato quello
dell’autonomia, si vuoleva che l’agricoltura interna bastasse per soddisfare i
bisogni interni. Le ragioni di ciò risalgono al periodo delle due Guerre
Mondiali, nel quale la Svizzera, confinata in una posizione di neutralità,
doveva farsi carico da sola dei suoi bisogni interni; sono delle ragioni
“dettate dalla fame” e dal rispetto di certi ideali. Il principio di neutralità
diventa quindi un pre-requisito importante, non esclusivo, per raggiungere
l’autonomia.
Un’autonomia
agricola inseguita al prezzo dell’isolazionismo, del protezionismo, delle
politiche di prezzo selvagge, della perdità di competitività, ma mai realmente
raggiunta. Simbolo di tale autonomia è sempre stata la “mucca”, (più protetta
che in India) da sempre fonte alimentare promiscua (latte, formaggi, carni) e
di pelli e, in passato, anche fonte di energia animale per il traino
dell’aratro e il trasporto; basti vedere l’enorme e spropositato livello di
aiuti che la Confederazione accordava all’economia lattieria (v. tabella 4.3.),
pari al 74% del totale degli incentivi indiretti (uscite per produzione e smercio)
per l’anno 2000.
Il pre-requisito della sostenibilità è
l’autonomia (cfr. 4.1.3.) e il pre-requisito, non esclusivo, dell’autonomia è
la neutralità e, chiuderei il cerchio dicendo che, il pre-requisito per la
neutralità dovrebbe essere la sostenibilità. La neutralità non si deve limitare
soltanto all’aspetto economico (talvolta messo in discussione con il “segreto
bancario”), all’aspetto politico (la Svizzera sta entrando solo adesso
nell’ONU), all’aspetto sociale, ma si deve estendere a quello ecologico (le
esternalità hanno carattere globale, cfr. cap 3). Attraverso l’agricoltura
sostenibile, la volontà comune, sembra aver trovato anche una direzione comune.
In
questa direzione comune, sono contenuti sia l’aspetto valutativo, sia l’aspetto
decisionale. Gli stakeholders compiono una valutazione (consapevole o meno) del
valore da dare all’ambiente e all’agricoltura, successivamente essi scelgono,
con pesi diversi, attraverso il consumo, i referendum, la produzione. Il punto
centrale di tale meccanismo è l’associazione tra la performance
ambientale e la performance aziendale. Chi meno inquina più guadagna. Ci sono
cioè delle economie di scala crescente legate alla performance ambientale.
5.2.
Il mercato dell’agricoltura biologica
L’agricoltura biologica costituisce
il traino dell’agricoltura verso un’agricoltura sostenibile.
5.2.1. Domanda e offerta
La politica agricola (PA 2002)
costituisce per l'agricoltura e il settore agroalimentare un gioco di scala. Le
famiglie contadine hanno reagito al cambiamento in maniera egregia. Esse hanno
preso misure per la riduzione dei loro costi di produzione (per esempio
intensificando la collaborazione tra di esse), hanno trovato l’occasione di
realizzare dei redditi accessori (esempio vendita diretta), hanno intensificato
le loro attività di pubbliche relazioni e si sono prese la responsabilità di
lavorare anche nel settore della promozione e della vendità. Molte di loro,
tuttavia sono arrivate al limite delle loro capacità.
L’Union Suisse des Paysan[22] afferma che l’agricoltura tende verso la multifunzionalità offrendo alla collettività
prestazioni concorrenziali, diversificate e localmente adatte, riuscendo
a guadagnare in termini di efficienza.
Dal lato dell’offerta, le vendite bio in
Svizzera hanno superato la soglia di un miliardo di CHF. L’agricoltura
biologica ha registrato una crescita del 6% dal 2002 al 2003. Oggi circa 6500
contadine e contadini svizzeri praticano un’agricoltura biologica, che
corrisponde all’11 % dell’insieme degli agricoltori. In particolare i prodotti
freschi (prodotti lattieri, carne,
frutta e verdura) hanno una crescita sostenuta. Persistendo su una strategia di
qualità, Bio Suisse previene il pericolo di una sovrapproduzione. L’adozione
costante delle nuove disposizioni è all’origine di un aumento dei costi di
produzione, mentre la diminuzione dei prezzi alla produzione è un motivo
d’inquetudine per gli agricoltori svizzeri. Le colture biologiche occupano oggi
più di 1/10 della totalità della superfice agricola utile.
Leader incontrastato dell’agricoltura
biologica resta il canton Grigioni con il 50% di coltivazioni biologiche,
mentre la svizzera romanda possiede meno agricoltori bio, ma ha un tasso di
crescita superiore alla media nazionale (14%).
Dal lato della domanda, le vendite
sono aumentate del 13% nel corso dell’anno 2002 per raggiungere 1056 milioni di
CHF (700 milioni di euro), superando la soglia del miliardo di CHF. Ogni
svizzero ha comprato in media 144 CHF di prodotti biologici.
Accordando la priorità assoluta alla qualità, Bio Suisse
spera di equilibrare l’offerta alla domanda al fine di evitare la creazione di
un “mare di latte”. La limitazione sull’utilizzazione di alimenti concentrati,
l’approvvigionamento degli animali con fieno, le severe norme per la
coltivazione del foraggio, il divieto di comprare tori nati da inseminazione
artificiale o il divieto di dressaggio elettrico per la vacche non sono che
alcune prescrizioni dettate da Bio Suisse. Oggi quasi tutte le aziende producono rispettando per lo meno i criteri
della Produzione Integrata (PI).
5.2.2. Confronto tra aziende a coltivazione biologica e non biologica[23]
Nel rapporto che ne è sortito, i risultati contabili delle aziende a coltivazione biologica (CB) sono comparati con quelli delle aziende a coltivazione non biologica (CNB). Ogni coltivazione biologica è comparata ad una non biologica che presenti condizioni di produzione comparabili. I criteri di selezione sono i seguenti:
· Condizioni locali: le coltivazioni prese in comparazione devono essere situate nella stessa zona di produzione (pianura, collina, montagna), ma non si tengono in considerazione le diverse condizioni climatiche.
·
Struttura di produzione: la struttura di produzione della CB e della sua corrispettiva CNB
devono essere identiche, in quanto fornisce preziose informazioni circa le caratteristiche naturali del sito
(porzione delle terre a solatio o di quelle foraggere), i dati della
coltivazione (porzione del bestiame,
manodopera, cosi come le capacità e le qualità del gestore della coltivazione.
·
Rapporto di proprietà: il rapporto di proprietà delle coltivazioni comparate deve essere
equivalente, condizione indispensabile per raffrontare le cifre contabili
dell’insieme della coltivazione, ossia serve per dare un valore contabile alle
comparazioni relative, non soltanto all’attivo e al passivo, ma a tutta la
struttura del capitale, come l’affitto, gli interessi sui debiti o l’interesse
sul capitale proprio investito nella coltivazione.
·
Grandezza
fisica della coltivazione: la superficie agricola utile (SAU) serve come indice per determinare tale
grandezza. Si selezionano quindi delle CNB la cui grandezza corrisponda il più
possibile a quella della CB comparata.
Sono considerate come coltivazioni
biologiche le coltivazioni che soddisfano i criteri fissati nell’Ordinanza
sull’agricoltura biologica (RS 910.18) e quelle che, secondo il servizio
contabile competente, praticano l’agricoltura biologica da più anni o hanno
ottenuto la certificazione di conversione all’agricoltura biologica.
Nell’analizzare i dati del
Rapporto (tabelle 5.4. e 5.5) ho incontrato alcune difficoltà :
- La prima relativa al fatto che il vocabolario
contabile non sempre corrisponde essendo il rapporto in lingua francese.
- La seconda derivante dal fatto che i dati non
sono espressi esattamente con gli stessi criteri e le stesse voci
utilizzati per il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale espressi nello
schema legale italiano, ma sono espressi in modo tale da mostrare le voci
che realmente esprimono la differenza tra una CB e una CNB.
I dati qui riportati non contengono
la prima parte del Rapporto, che per esigenze di spazio non ho potuto riportare
e che dunque andrò a sintetizzare qui di seguito. In tali dati si evidenziava
in modo specifico l’analisi comparativa per ogni tipo qualitativo di coltura e
per ogni tipo di animale di allevamento, ovvero per ogni ramo di produzione.
Le minori rese per le CB confermano
quanto detto nel par. 4.6.2. sui rendimenti fisici. In media, negli anni tra il 1998 e il 2000, i rendimenti dei
cereali panificabili ottenuti dalle CB
arrivano al 71 % del rendimento fisico realizzato dalle CNB. Per quanto
riguarda i cereali da foragggio le CB arrivano sino al 80 % del rendimento
fisico realizzato dalle CNB. Ma la minor resa fisica è generalmente più che
compensata dal prezzo più elevato che determina un margine contabile maggiore
per le CB, il che conferma quanto affermato nel par 4.4. e cioè che il mercato,
e non solo tramite gli incentivi, premia l’agricoltura biologica con prezzi più
elevati. Nel 2000 i cereali panificabili hanno beneficiato di un prezzo più elevato (dal 43 % al 79 % di differenza a
seconda della varietà) e di costi per la protezione dai parassiti e per la
concimazione nettamente più bassi, il che ha fatto registrare per le CB dei
profitti ben superiori rispetto alle CNB corrispondenti. Quanto all'orzo e
all'avena, i margini contabili rilevati nel 2000 per le CB ammontano
rispettivamente a 102 % e 106 % dei margini realizzati dalle CNB equivalenti. Per la coltivazione di patate,
nonostante un rendimento fisico del 66 %, l'agricoltura biologica realizza un
margine contabile del 113 % maggiore rispetto all'agricoltura non biologica
comparata. I margini contabili dell'allevamento dei maiali nel 2000 sono
praticamenti equivalenti per i due gruppi. Ma la comparazione su più anni
mostra che il margine contabile degli allevamenti biologici è più elevato. Gli
allevamenti biologici realizzano un prodotto nettamente più elevato, ma essi
devono, allo stesso tempo, supportare maggiori costi per gli alimenti per ogni
kg di crescita. Nel caso
dell'allevamento della galline ovaiole, i due gruppi rilevano margini contabili
differenti nel 2000. Grazie al prezzo di vendita più alto, i risultati
contabili degli allevamenti biologici sono nettamente superiori a quelli degli
allevamenti non biologici comparati, e questo malgrado i costi maggiori per gli
alimenti. In tutte le
zone di produzione, la performance riguardante la quantità di latte
prodotta da ogni mucca è minore negli allevamenti biologici, ma questa
differenza è più che compensata dal prezzo di vendita del latte biologico
(regolato in parte con i contingenti), dal minor costo degli alimenti
complementari e dai minori costi veterinari, permettendo margini contabili
maggiori.
Conformemente ai criteri di selezione,
le coltivazione dei due gruppi comparati presentano una taglia media simile.
Esistono tuttavia delle differenze relative all'utilizzazione dei suoli. Le
CB in pianura presentano una zona
leggemente maggiore di superficie orticola e di pascoli, ma inferiore di
cereali da foraggio e di mais d'insilamento (silos). Nel 2000 nessuna azienda agricola biologica ha
coltivato barbabietole da zucchero e soltanto una volta della colza. Inoltre l'allevemento biologico
detiene dei capi di bestiame leggermente più piccoli, rispetto a quelli non
biologici.
Successivamente il Rapporto compara
le coltivazioni secondo un lavoro d’insieme che raggruppa i vari rami della
produzione (tab. 5.4.). Le coltivazioni
che praticano l'agricoltura biologica sono nettamente meno intensive che le CNB
comparate, ciò si riflette sui rendimenti fisici delle grandi colture, sul
numero di animali per SAU, sulla superficie destinata alla produzione di
foraggio per unità di bestiame, in quanto consuma del foraggio invece che
alimenti complementari.
Tabella 5.4. Rapporto tra aziende
coltivazioni biologica e non – Stato Patrimoniale
|
RAPPORTO
2000 SULLE COLTIVAZIONI PRATICANTI
L'AGRICOLTURA BIOLOGICA -
STATO PATRIMONIALE |
||||||||||||
|
|
Coltivazioni di pianura |
Coltivazioni di montagna |
Insieme delle coltivazioni |
|||||||||
|
Tipo di
coltivazione |
Non bio |
Bio |
Non bio |
Bio |
Non bio |
Bio |
Non bio |
Bio |
Non bio |
Bio |
Non bio |
Bio |
|
ANNO |
1998-2000 |
2000 |
1998-2000 |
2000 |
1998-2000 |
2000 |
||||||
|
N°
di coltivazioni |
204 |
204 |
68 |
68 |
440 |
440 |
158 |
158 |
644 |
644 |
226 |
226 |
|
in zona di pianura |
146 |
146 |
49 |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
146 |
49 |
49 |
|
in zona di collina |
58 |
58 |
19 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
58 |
19 |
19 |
|
in zona di montagna |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 |
440 |
158 |
158 |
440 |
440 |
158 |
158 |
|
in proprietà |
190 |
190 |
64 |
64 |
415 |
415 |
150 |
150 |
605 |
605 |
214 |
214 |
|
in affitto |
14 |
14 |
4 |
4 |
25 |
25 |
8 |
8 |
39 |
39 |
12 |
12 |
|
SAU aziendale (in
ha) |
18.77 |
18.8 |
19.29 |
19.37 |
19.91 |
19.94 |
20.05 |
20.1 |
19.55 |
19.58 |
19.82 |
19.88 |
|
Famiglia e mano d'opera |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lavoratori totali
coltivaz |
1.8 |
1.94 |
1.75 |
1.9 |
1.66 |
1.64 |
1.64 |
1.6 |
1.71 |
1.74 |
1.67 |
1.69 |
|
a) del nucleo familiare |
1.39 |
1.35 |
1.35 |
1.34 |
1.44 |
1.42 |
1.44 |
1.42 |
1.42 |
1.4 |
1.41 |
1.4 |
|
b) salariati del nucleo familiare |
0.11 |
0.12 |
0.1 |
0.12 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
|
c) salariati esterni
nucleo fam |
0.3 |
0.47 |
0.3 |
0.44 |
0.16 |
0.16 |
0.14 |
0.13 |
0.21 |
0.26 |
0.19 |
0.22 |
|
lavoratori del nucleo fam (%) |
77 |
70 |
77 |
71 |
87 |
86 |
87 |
89 |
83 |
81 |
84 |
83 |
|
taglia della
famiglia |
3.5 |
3.7 |
3.5 |
3.7 |
3.5 |
3.6 |
3.4 |
3.7 |
3.5 |
3.7 |
3.4 |
3.7 |
|
STATO
PATRIMONIALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
numero delle coltivazioni |
190 |
190 |
64 |
64 |
415 |
415 |
150 |
150 |
605 |
605 |
214 |
214 |
|
attivo
(CHFr) |
846071 |
850582 |
879746 |
899903 |
600003 |
700060 |
608968 |
724271 |
677397 |
747430 |
689948 |
776796 |
|
() dell’azienda |
787498 |
785704 |
823718 |
834836 |
575515 |
650550 |
586390 |
673436 |
641804 |
693203 |
657366 |
721705 |
|
() dell'impresa annessa |
58573 |
64878 |
56028 |
65067 |
24488 |
49510 |
22578 |
50835 |
35593 |
54227 |
32582 |
55091 |
|
§ attivo finanziario |
122687 |
138288 |
126581 |
145725 |
75670 |
104255 |
75224 |
117146 |
90709 |
115198 |
90583 |
125692 |
|
§ attivo della coltivazione |
723384 |
712294 |
753165 |
754178 |
524333 |
595805 |
533744 |
607125 |
586688 |
632232 |
599365 |
651104 |
|
~ stock e giacenze |
27620 |
26949 |
29217 |
30000 |
20814 |
19217 |
21446 |
20146 |
22956 |
21651 |
23770 |
23093 |
|
~ bestiame |
52350 |
46026 |
56441 |
50499 |
42390 |
39496 |
44669 |
41111 |
45485 |
41484 |
48190 |
43919 |
|
~ bestiame morto |
49451 |
52752 |
47153 |
51378 |
53090 |
56110 |
52333 |
53509 |
51832 |
55078 |
50784 |
52872 |
|
~ piante |
12170 |
9903 |
11148 |
9052 |
5865 |
5345 |
5437 |
5943 |
7812 |
6793 |
7145 |
6873 |
|
~ immobili e fabbricati |
479321 |
473990 |
503177 |
508903 |
341298 |
407121 |
348050 |
412440 |
384694 |
427700 |
394443 |
441289 |
|
~ terre e migliorie |
92875 |
93671 |
94513 |
94236 |
53799 |
59868 |
54287 |
65027 |
66043 |
70780 |
66317 |
73762 |
|
passivo
(CHFr) |
846071 |
850582 |
879746 |
899903 |
600003 |
700060 |
608968 |
724271 |
677397 |
747430 |
689948 |
776796 |
|
debiti |
365576 |
343489 |
371111 |
358676 |
252384 |
279282 |
263120 |
281187 |
287983 |
299791 |
295416 |
304361 |
|
~ a breve termine |
13809 |
18248 |
12801 |
14979 |
14159 |
15388 |
15288 |
14427 |
14148 |
16360 |
14544 |
14592 |
|
~ debiti d'investimento |
53329 |
49270 |
60131 |
47374 |
57254 |
57658 |
55345 |
56026 |
55884 |
54963 |
56776 |
53438 |
|
~ debiti ipotecari |
188855 |
148807 |
170927 |
158851 |
117364 |
127323 |
124067 |
138574 |
139907 |
134456 |
138081 |
144638 |
|
~ altri debiti |
109583 |
127164 |
127252 |
137472 |
63607 |
78913 |
68420 | |||||